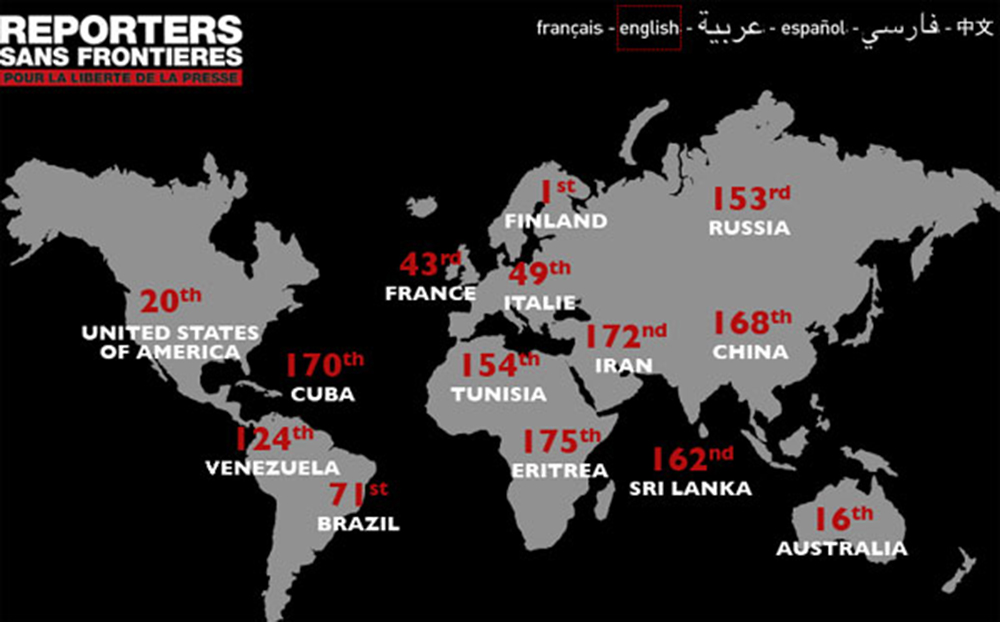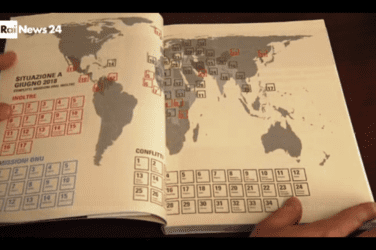Un Atlante per capire la guerra. Intervista a Raffaele Crocco

Per chi studiando il mondo e la politica internazionale si sentisse come il ‘viandante sul mare di nebbia’ di Friedrich, l’Atlante dei Conflitti e delle Guerre nel Mondo potrebbe essere un valido aiuto per diradare la foschia. Giunto alla terza edizione, l’Atlante contiene anche un approfondimento sui ‘temi caldi’ di questo 2011: wikileaks, primavera araba e crisi finanziaria. Abbiamo avuto l’opportunità di parlare dell’Atlante con il suo direttore, Raffaele Crocco, giornalista e documentarista Rai. Un’opera nata con le ‘migliori intenzioni’ che, proprio per questo, noi di mRI abbiamo provato mettere in discussione recitando la parte dell’ avvocato del diavolo.
La ratio dell’Atlante è chiara: adottate un criterio geografico dedicando lo stesso numero di pagine ad ogni conflitto perché ‘ogni conflitto ha i suoi morti e ogni morte merita di essere denunciata’. Ma non è così nella realtà. Vi sono ‘major war’ con pochi morti, le cui ripercussioni a livello di equilibri globali del pianeta hanno effetti superiori a ‘small war’ con molti morti ma effetti limitati ad un contesto regionale. Non le pare un approccio utopistico quello usato dall’Atlante?
E’ vero, ma l’ottica dalla quale abbiamo deciso di raccontare le guerre del mondo è quello del normale cittadino che vuole sapere, non l’ottica dell’analista politico che è in grado di dare una lettura approfondita di ciò che accade. Per sapere occorre rigore e neutralità.
Solo dopo aver assimilato le informazioni, ognuno elaborerà la propria visione del fenomeno bellico e, se il caso, esprimerà giudizi di valore. Ma per eliminare un approccio ideologico (nell’uno e nell’altro senso) è necessario essere informati, ed è quello che con l’Atlante cerchiamo di fare.
L’Uppsala University fornisce una lista di conflitti del mondo secondo i criteri elaborati nelCorrelates of War Project. Una precisa scala della violenza che permette di classificare diversamente conflitti interstatuali da conflitti intrastatuali. C’è una ragione per cui avete scelto di ignorare questo approccio?
Sì, ed è semplice. Abbiamo scelto di raccontare la guerra con l’ottica delle vittime. Per chi vive una guerra, dieci o mille morti non fanno molta differenza.
In Siria ci sono 27 vittime al giorno (rapporto di Human Rights Watch) e venerdì scorso un attentato ha causato circa 40 vittime. Dal punto di vista della macabra contabilità è peggio della Libia. Secondo il criterio che adottate, si potrebbe sostenere che in Siria ci sia effettivamente una guerra?
Dobbiamo distinguere tra scontro armato interno (tra fazioni avverse) e scontro tra forze armate esterne e interne. Non si può parlare di tutto. Nel primo caso, quello siriano, fintantoché non si deciderà di intervenire, la crisi rimane confinata nell’ambito di sovranità di Assad. Il monopolio della violenza è suo.
Torniamo per un attimo al criterio geografico. Samuel Huntington aveva previsto e delineato il raggruppamento di civiltà non solo su base geografica ma anche sulla base di appartenenze culturali e religiose. Gli scontri ci saranno, anche all’interno di una stessa civiltà, ma saranno scontri per l’ascesa al ruolo di leader di quella civiltà. Nonostante nell’Atlante non si riscontri l’utilizzo del criterio culturale-religioso, emergono comunque le dinamiche descritte daHuntington?
Sì, io credo che sia una dinamica reale. Huntington aveva visto giusto. Si pensi ad esempio alla guerra in Kosovo, quando vi era la necessità di rendere inoffensiva una media potenza come la Serbia. Il suo potere di attrazione culturale avrebbe potuto far emergere Belgrado come ‘guida’ di una zona di civiltà.
Quindi l’immagine di un mondo formato da diversi raggruppamenti di civiltà divisi da linee di faglia è reale?
Dall’Atlante emerge un nuovo asse di analisi. Dagli scontri tra diverse zone geografiche emerge un dato che spazza via il luogo comune di un ‘Nord’ del mondo in guerra contro un ‘Sud’ povero. Non è più così. Il ruolo di guida del ‘Nord’ è ormai minacciato, non solo militarmente ma anche economicamente. La redistribuzione geografica del potere segue criteri economici. Potremmo fare una mappa geoeconomica del mondo e vedere che Paesi come Cina, India, Brasile non hanno i posti che meritano nei consessi internazionali. Si pensi all’ONU e al potere di veto ancora nelle mani di Francia e Gran Bretagna.
Uno scenario turbolento. L’anno prossimo uscirà la quarte edizione dell’Atlante: concluso recentemente il ritiro delle truppe americane, troveremo ancora qualcosa sull’Iraq?
Molto probabile che lo troverete. Il ritiro difficilmente si tradurrà in cessazione delle ostilità.
Gli analisti descrivono uno scenario per i prossimi mesi simile a quello del 2006 (apice della guerra civile) e il rischio della divisione del Paese in tre aree (sunnita, sciita e curda) è reale. Condivide?
E’ la dimostrazione che l’occupazione non ha portato i risultati politici sperati. E credo che, anche nel caso si arrivi ad una transizione come quella descritta dagli analisti, molto difficilmente sarà indolore.
Una curiosità che ci ha colpito. Le pagine dedicate alla Cina sono intitolate Cina/Tibet. Crede davvero alla possibilità che la Cina possa abbandonare una provincia così importante, sulla quale rivendica sovranità?
Credo che sia impossibile. Ma lo stesso criterio che adottiamo per il Tibet dal prossimo anno lo vorremmo adottare per le isole Hawai, occupate dagli Stati Uniti a seguito della guerra ispano-americana del 1905. Nessuno ne parla più, ma è un caso identico. Noi europei guardiamo al Tibet con un po’ di snobismo, come se uno Stato teocratico guidato da un prete fosse qualcosa di così lontano da noi. Il messaggio è: il Tibet non otterrà l’indipendenza, ma quantomeno avrà il diritto di combattere?
Lei ha parlato di rigore e neutralità nell’analisi. Gli iracheni o gli afghani che piazzano IED (Improvised Explosive Device) contro i convogli militari cosa sono? Resistenti o terroristi?
Il confine è sottile ma credo vi siano delle esigenze di chiarezza che fanno sì che alcune definizioni si debbano dare.
Non crede che il terrorismo sia solo un ‘modus operandi’? Arthur Harris, comandante delBomber Command della RAF, indossava una divisa e per stroncare la Germania nazista non esitò a bombardare a tappeto il cuore di città abitate da civili.
Quando si sceglie deliberatamente di colpire vittime civili si compie un atto criminale.
La Germania minacciava di invadere l’Europa e sterminare interi popoli. Seguendo il suo ragionamento anche Churchill che decise di bombardare Dresda fu un terrorista.
Churchill fu un grande terrorista. Purtroppo la verità storica non corrisponde sempre con la verità giudiziaria.
Spesso un politico sceglie il ‘male minore’. A Coventry, Churchill scelse di sacrificare dei civili per non far sapere ai nazisti che era in grado di decifrare ‘Enigma’. Non crede che questo sacrificio abbia risparmiato molte altre vite?
Capisco la necessità di scegliere il male minore. Ma siamo sempre certi di aver compiuto la scelta giusta? Truman ha davvero fatto l’unica cosa che poteva essere fatta sganciando sul Giappone due ordigni atomici? Pensiamo anche che quella guerra poteva essere evitata sin dall’inizio.
Forse considerare il terrorismo un semplice ‘modus operandi’ aiuterebbe a capire le azioni irregolari e giudicare chi le commette su un piano non discriminatorio.
Si, senza dubbio questo è vero. E’ una riflessione che manca nel dibattito politico. Come manca un dibattito sulla guerra. La scelta deve essere tra ‘gestire’ o ‘prevenire’ il conflitto. Cosa preferiamo?
L’Italia partecipa a missioni di pace. L’articolo 11 della nostra Costituzione pone dei caveat ai nostri militari e dei vincoli ai nostri politici.
Non siamo certamente contro i militari. Anzi. In Libano l’esercito italiano compie un’opera meritoria che deve essergli riconosciuta.
Gli eserciti servono insomma.
Quello che occorre oggi è una riflessione sul termine ‘pace’. Cosa significa? Noi siamo in pace se s’intende pace come assenza di conflitto. Ma abbiamo militari sparsi ovunque nel mondo e continuiamo ad investire in spese militari. Di fatto è come se fossimo in guerra, e lo siamo da almeno 20 anni.
Photo Credit: fondazionegiovannizanoni.it