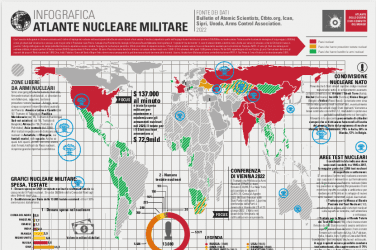di Sara Gorelli*
Dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia mondiale, lo scorso mese sono ripartite le consultazioni sul testo della Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive. Dal 6 all’8 aprile il Palazzo delle Nazioni a Ginevra ha ospitato 65 delegazioni diplomatiche provenienti da altrettanti Paesi, rappresentanti di organizzazioni internazionali umanitarie come il Comitato della Croce Rossa Internazionale e quelli della società civile, tra cui INEW, la Rete internazionale di ONG contro le armi esplosive. Per la società civile italiana era presente l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, a sua volta in rete con Campagna Italiana Contro le Mine e Rete Italiana Pace e Disarmo.
Per tre giorni gli oltre 200 delegati si sono consultati formalmente per accettare e respingere i contenuti della Dichiarazione proposti dall’Irlanda, lo Stato che si è offerto di guidare il processo di negoziazione. Un processo che non si è rivelato affatto facile e il cui risultato parziale per il momento lascia molti interrogativi sul reale interesse della Comunità internazionale per il problema del coinvolgimento dei civili nei conflitti e sulla possibilità effettiva di garantire sistemi di protezione realmente efficaci. L’obiettivo centrale della Rete INEW è quello di promuovere a livello internazionale comportamenti e pratiche militari da parte degli Stati in conflitto per minimizzare il più possibile i rischi per i civili derivanti dall’impiego delle armi esplosive impiegate nei centri urbani. Quello delle armi esplosive, infatti, è diventato un vero e proprio problema umanitario senza precedenti nel corso degli ultimi dieci anni. Non è un caso che la Croce Rossa Internazionale e ben due Segretari generali delle Nazioni Unite (Ban Ki-Moon e Guterres) abbiano espresso più volte preoccupazione a riguardo.
E’ un dato di fatto che quando le armi esplosive sono usate nei centri urbani o comunque in aree densamente popolate un numero ingente di civili rimane ingiustificatamente ucciso e ferito o soffre per le conseguenze derivanti la distruzione di infrastrutture e servizi vitali per la sopravvivenza umana. Questo “schema di danno”, ampiamente documentato, è riscontrabile in tutti i più sanguinosi conflitti contemporanei: Etiopia, Iraq, Gaza, Yemen, Siria e Ucraina. I dati, incontrovertibili, dimostrano che le vittime dei conflitti urbani sono civili per il 90%. Che si tratti di attacchi aerei, artiglieria, razzi o ordigni artigianali, il problema è che le armi esplosive sono progettate per essere utilizzate in campi di battaglia aperti, non tra le strade strette e i palazzi di una città. La conformazione topografica tipica dei centri abitati amplifica esponenzialmente la loro portata distruttiva e causa ai civili e alle comunità sofferenze che si protraggono molti anni dopo la fine del conflitto.
È dal 2019 che il tema del danno umanitario delle armi esplosive è diventato oggetto di un preciso percorso diplomatico. Prima di allora, infatti, la percezione diffusa era che le armi esplosive non costituissero un problema umanitario, perché il loro uso è lecito ai sensi del diritto di guerra, conosciuto anche come Diritto internazionale umanitario (DIU). È con la conferenza di Vienna del 2019 che i costi umani e le sofferenze causate dalle armi esplosive in guerra cominciano ad essere percepite dalla comunità internazionale come un problema umanitario di cui farsi carico ed è su questo riconoscimento che si è basato il percorso diplomatico della Dichiarazione politica internazionale.
L’obiettivo della Dichiarazione è quello di incoraggiare gli Stati a concordare e adottare pratiche militari “conservative” rispetto all’uso delle armi esplosive, in maniera da garantire una maggiore salvaguardia delle popolazioni civili durante le operazioni belliche. Questo obiettivo si riflette nella struttura della Dichiarazione. Il testo parte da un riconoscimento dei molteplici danni umanitari e conseguenze sociali e ambientali derivanti dall’impiego di queste armi (Preambolo e Sezione 1), per poi esaminare il quadro normativo internazionale di riferimento (Sezione 2) e arrivare a stabilire gli impegni operativi (Sezione 3) e il sistema di monitoraggio degli stessi (Sezione 4). Le consultazioni di aprile sono servite per esaminare i progressi di questi anni di negoziazione rispetto a ciascuno dei quattro punti.
L’andamento dei lavori di aprile è stato piuttosto burrascoso. A distanza di due anni dal primo incontro e malgrado l’ampio riconoscimento della necessità di agire urgentemente per affrontare il danno sofferto dai civili, rimangono sostanziali divergenze di vedute tra i Paesi. Queste divergenze, purtroppo, sono profonde e sostanziali.
Belgio, Canada, Danimarca, Israele, Repubblica della Corea, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno lavorato per indebolire di fatto gli impegni operativi proposti nella bozza e per rigettare in parte l’impianto di riconoscimento sostanziale che motiva alla base il processo stesso di negoziazione stesso e la necessità di sviluppare una Dichiarazione ad hoc per le armi esplosive. Qual è il motivo di tanta ostilità?
Gli impegni sulle procedure operative militari proposti principalmente dalle organizzazioni umanitarie e della società civile si basano sul concetto di “presunzione di non uso”, introdotto dalla Croce Rossa Internazionale. Questo principio prevede che uno Stato si astenga totalmente dall’impiego di armi esplosive nei centri abitati quando si rilevi che possano avere effetti a largo raggio. Le conseguenze degli effetti a largo raggio nelle aree urbane, infatti sono imprevedibili, indiscriminati – cioè, nel colpire non fanno distinzione tra combattenti e non – e vanno ben aldilà delle intenzioni di chi sferra l’attacco. Più l’area di esplosione è ampia, più alto è il numero dei civili e delle strutture e infrastrutture civili che viene colpito.
Se diventasse un principio cardine largamente condiviso dagli eserciti, la presunzione di non uso avrebbe un impatto positivo sulla vita delle popolazioni in guerra. Il problema è che cade in una zona grigia di interpretazione e applicazione del Diritto internazionale umanitario: se da una parte le armi esplosive non sono vietate, dall’altra i loro effetti a largo raggio causano ai civili proprio i danni che il DIU ha come scopo ultimo di evitare. Le modifiche proposte dai paesi elencati sopra si basano quindi sulla logica che usare le armi esplosive nelle città non è esplicitamente vietato dal diritto di guerra e che le sofferenze dei civili sarebbero causate non tanto dall’uso delle armi esplosive di per sé, ma piuttosto da violazioni imputabili alla controparte del conflitto (quasi sempre un’entità non statale). Secondo questi Stati, ogni impegno restrittivo in tal senso equivarrebbe a creare nuove norme internazionali che una Dichiarazione non ha la facoltà di poter imporre, in quanto documento giuridico non vincolante. Inutile dire che queste posizioni hanno determinato uno stallo nelle negoziazioni.
Come tutte le consultazioni di questo tipo, a essere importante nelle trattative è l’appartenenza regionale e/o trattati di natura commerciale o militare che può influenzare la posizione negoziale di interi gruppi di Stati. Anche queste consultazioni non hanno fatto eccezione. È il caso del Cile e del Messico, che partendo dagli impegni presi con il Comunicato di Santiago, un accordo regionale proprio sulle armi esplosive, hanno guidato le delegazioni dei paesi dell’America a chiedere a gran voce un testo dalla più decisa connotazione umanitaria. Alla stessa maniera si sono mossi i paesi africani firmatari del Comunicato di Maputo, i cui portavoce sono stati Togo e Nigeria.
Un discorso a parte invece meritano i Paesi europei, incastrati tra l’appartenenza all’Unione Europea, il cui orientamento è favorevole ad un testo “protettivo”, e alla NATO, il cui retaggio comporterebbe un approccio molto più “conservativo”. Con l’eccezione dell’Austria e dell’Unione Europea, le posizioni dei paesi del vecchio continente, in primis Francia e Germania, si sono rivelate prudenti e concilianti, anche se non distanti dal blocco dei paesi conservativi sul tema dell’astensione dall’uso delle armi esplosive con effetti a largo raggio.
L’Italia si è allineata alle posizioni prudenti dei suoi omologhi europei, ma con una sostanziale differenza. Il 6 aprile la Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato una risoluzione parlamentare che vincola il nostro paese ad aderire alla Dichiarazione e a riconoscere il documento come il punto di riferimento per gli standard di uso delle armi esplosive. La risoluzione è stata fortemente voluta dalle organizzazioni della società civile che si occupano di armi esplosive nel nostro paese e ha fornito all’Italia rinnovato slancio ad una partecipazione al processo consultivo che, fino ad allora, altrimenti, avrebbe potuto tranquillamente essere definita come incolore. La risoluzione ha permesso di ridisegnarne il ruolo strategico all’interno del gruppo dei paesi europei, dove l’Italia si è distinta per il lavoro di mediazione portato avanti con la Germania per smussare il dissenso su alcune parti del testo, in particolare quelle che riguardano gli effetti riverberanti o per favorire l’adozione di meccanismi di monitoraggio che non comportino un impegno di spesa da parte dei paesi che vincoli di budget sulle spese militari. Anche nel caso dell’Italia, tuttavia, rimangono irrisolti i nodi riguardanti la presunzione di non uso delle armi esplosive.
L’ultimo e definitivo round dei negoziati è previsto per la prima metà di giugno. Il testo che sarà presentato sarà quello definitivo. Al momento non è possibile fare previsioni se prevarrà la decisione, calcolata, di presentare un testo più blando, conservativo e dalla portata sostanzialmente più debole per far salire tutti Stati a bordo o uno più coraggioso e, per certi aspetti, radicale. Appuntamento a giugno.
- L’Osservatorio – Centro di Ricerca sulle Vittime Civili dei Conflitti
L’immagine è tratta da Wikipedia