Con questa nuova edizione il Piccolo Atlante di una Pandemia nato il 21 marzo scorso cresce. Con un aggiornamento che diverrà mensile e che intende fotografare non tanto l’evoluzione del virus ma quella della risposta di Paesi, Governi, Continenti, Persone. Un motivo ci spinge a farlo ed è quello di pensare al dopo.
Il tema del durante. La questione del dopo
di Raffaele Crocco

Il tema del durante è la questione del dopo. Mi spiego: tutto ciò che accade mentre infuria questa pandemia ha conseguenze dirette e precise su quello che accadrà appena tutto questo sarà finito. Non solo. Ogni decisione che viene presa da un Governo, da un Paese ha una ricaduta secca sulla distribuzione dei diritti e della ricchezza fra le persone che vivono in quel Paese e, più in generale, negli equilibri che regolano la vita fra gli Stati.
Per questi motivi, il tema del durante è la questione del dopo. Capire come agiscono i Governi – singolarmente e collettivamente -, intuire come si riposizionano gli eserciti, come ripartono le economie, come si abbattono i prezzi e quali prezzi, significa tracciare il profilo del Pianeta del dopo Covid-19.
Una logica antica
La logica è quella di sempre: ogni spazio abbandonato, verrà riempito da qualcuno o qualcosa. Vi faccio un esempio: alcuni Paesi dell’Asia più orientale vivono anche grazie ad un sistema industriale basato sulla “lavorazione conto terzi”. Parliamo di abbigliamento e borse, soprattutto. A causa del Coronavirus, il blocco della produzione, del reperimento della materie prime da parte delle industrie “ordinanti”, sta paralizzando quelle fabbriche. Nel solo Bangladesh – ne parliamo in questo speciale – sono stati bloccati in poche settimane ordinativi per 3 miliardi di dollari. Questo vuol dire che qualche migliaio di operaie e operai si ritroveranno senza lavoro, in un luogo in cui le tutele sono inesistenti, così come gli ammortizzatori sociali. Significa che saranno ragionevolmente alla fame.
Nel frattempo, è molto probabile che qualche altro Paese colga la palla al balzo, offrendo alle medesime società straniere che oggi hanno bloccato gli ordinativi, condizioni di produzione più favorevoli, in termini di costi. Quelle società – che hanno subito una perdita – per la voglia di rifarsi rapidamente accetteranno, alzando la già alta percentuale di guadagno che hanno sulla vendita del prodotto finito. Fantascienza? No, certezza sul futuro. E’ così da sempre. Possiamo evitarlo? Si potremmo. In assenza di leggi che permettano di punire gli imprenditori scorretti, potremmo scoprire quali aziende si comporteranno così e boicottarle sistematicamente sul mercato.
Resta comunque il punto fondamentale: dobbiamo giocare d’anticipo. Dobbiamo immaginare ora, subito, come sarà dopo, per prevenire le storture.
Giocare d’anticipo
Non ci sarà nulla come prima. Le organizzazioni internazionali prevedono una caduta netta del Prodotto Interno Lordo mondiale. La decrescita è stimata fra il meno 1% e il meno 3%. A rimetterci saremo tutti, ovvio. Ma ci rimetteranno di più quei quasi due miliardi di individui che oggi vivono grazie alla cosiddetta “economia informale”. Avete presente? Parliamo di venditori ambulanti, gente di mercato, piccoli artigiani di strada, che soprattutto – ma non solo – in India, America Latina e Africa vivevano grazie al poco che incassavano ogni giorno.
Ora quell’incasso non c’è più, perché in molti Paesi di quei continenti la scelta – scientificamente corretta e inevitabile – di chiudere tutto e tenere la gente a casa, li ha privati di ogni risorsa. Risultato: fame, tanta e niente ammortizzatori sociali che – ricordiamolo – sono una meraviglia sociale certa solo in una parte d’Europa, sino a quando terranno. Anche qui, ci spiegano molto le agenzie delle Nazioni Unite, dicendo che una conseguenza del Coronavirus, se non si interviene, è l’annullamento degli ultimi trent’anni di lotta alla fame nel Mondo. Ora, se resteremo fermi e ciechi, la conseguenza inevitabile sarà l’aumento del numero di persone che abbandoneranno la loro terra, per cercare fortuna altrove. Si chiama migrazione e se era “il problema” dell’ultimo decennio, possiamo immaginare – dati alla mano – cosa sarà in futuro.
Nella sola Africa, si avrà la prima recessione economica degli ultimi 25 anni. Il Pil, per la prima volta, non crescerà. Il tutto in una situazione in cui il controllo sanitario dell’epidemia è praticamente impossibile: oggi sul Continente ci sono in media 2 medici ogni 10mila abitanti (in Italia ne abbiamo 41) e i posti letto ospedalieri sono 5 ogni milione di persone. Inevitabile immaginare la fuga di milioni di esseri umani.
Tentazioni autoritarie
Arretra l’economia e, di conseguenza, arretrano i diritti. Il numero di Paesi che stanno stringendo i lacci in nome della “resistenza alla pandemia” cresce. La tentazione è forte. Orban in Ungheria si è dotato di leggi speciali, che permettono per altro di dichiarare “nemico” chiunque lo critichi. Erdogan in Turchia prosegue il cammino verso l’eliminazione dell’opposizione, imitato dall’Arzebajan, dal Mynamar, dall’India. La Cina, in questo elenco, era già compresa, come la Russia.
La democrazia rischia di diventare residuale, nel Pianeta, privilegio di pochi, vecchi Paesi. E anche in quei Paesi, sta diventando una democrazia stanca e classista, con cittadini di serie A e B. Il comportamento di Germania e Olanda nell’Unione Europea è esemplare, da questo punto di vista: se la democrazia è solidarietà e condivisione dei problemi in un sistema comune, bene nell’Unione Europea è un valore morto.
E’ un mondo destabilizzato quello che esce da questa pandemia. E’ un mondo spaventato, in cui chi è forte – o si sente tale – pensa di avere spazi di conquista. Lo pensa Trump, che in cerca di consenso interno e per resistere alla potenza economica cinese, riposiziona le proprie flotte, per controllare i mari e rilanciare la grandezza degli Usa. Lo pensa Putin, gigante nel corpo da bambino: la grandezza della Russia è uccisa dalla sua economia asfittica, dalle fabbriche chiuse con milioni di disoccupati alla fame, dal prezzo del petrolio che è crollato, trascinando il Paese nella crisi. Anche qui, il rilancio è nel mostrare i muscoli, schierare l’esercito, alla ricerca di credibilità e sponsor economici.
Le nostre responsabilità
Il cosa accadrà, dipende come sempre da noi e dalla capacità di capire cosa accade ora. Un Mondo destabilizzato è un mondo che possiamo reinventare, esattamente come accadde dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ un mondo in cui possiamo cambiare le regole economiche, misurare la ricchezza secondo modelli differenti, riorganizzare la distribuzione del reddito e dei diritti in modo nuovo, più equo. Farlo significherebbe aver imparato che la sanità pubblica regge meglio della cialtrona e parassitaria sanità privata. Vorrebbe dire aver capito che gli ammortizzatori sociali tengono vivo il mercato, ridistribuiscono denaro, fanno lavorare le imprese senza soste o buchi.
Cambiare avrebbe il senso di indirizzare meglio investimenti e risorse, puntando a produzioni utili, riconvertendo quelle militari, dannose, inquinanti.
La paura di queste settimane avrà un senso solo se costruiremo un Mondo più moderno e coerente. Non solo qui, a casa nostra, ma ovunque, in stretta relazione con altri popoli, altri sistemi, altri mondi. Davanti all’epidemia abbiamo capito di essere tutti nudi. Approfittiamone e cambiamo. E’ la cosa intelligente da fare.
#IoRestoaCasa
#NoiRestiamoaCasa
Un lavoro di: Giuliano Battiston, Raffaele Crocco, Teresa Di Mauro, Lucia Frigo, Elia Gerola, Emanuele Giordana, Alice Pistolesi, Maurizio Sacchi, Luciano Scalettari, Beatrice Taddei Saltini

Nei Paesi del Vicino Oriente le scelte governative e gli scenari legati alla pandemia hanno tratti di somiglianza ma anche varie sfumature nell’azione e nelle misure attuate. Il caso iraniano viene trattato nella sezione Asia Centrale.
Il caso libanese
In Libano la pandemia ha esacerbato una crisi economica già devastante. Il 7 marzo 2020 il Governo di Hassan Diab aveva annunciato il default del Paese. Già nel novembre 2019 la Banca Mondiale aveva previsto che la porzione di popolazione libanese al di sotto della soglia di povertà sarebbe aumentata dal 30 al 50% nel 2020. La pandemia non farà che peggiorare questa previsione. Secondo Human Rights Watch milioni di persone sono a rischio fame a causa delle misure di blocco legate alla pandemia. La Banca mondiale ha approvato la riassegnazione di 40 milioni di dollari da un progetto esistente per aumentare la capacità del sistema sanitario libanese.
Per fronteggiare il coronavirus il Governo libanese ha esortato le persone a rimanere a casa dal 15 marzo 2020. Misure precauzionali sono state imposte anche alla missione Unifil nel Sud del Paese che comprende oltre 11mila persone tra soldati e civili. Il Libano è inoltre uno degli Stati che ospita più rifugiati. Le Nazioni Unite hanno realizzato sessioni di sensibilizzazione e distribuzione di kit igienici in tutti gli insediamenti informali e non. L’Onu sta attuando un programma di autoapprendimento nelle sue 65 scuole per rifugiati palestinesi in Libano.
Il virus non ferma l’annessione
In Israele e Palestina la diffusione del coronavirus pare non stia fermando l’annessione della Valle del Giordano e degli insediamenti ebraici, così come previsto dal piano presentato da Donald Trump nel gennaio 2020. Il diritto internazionale chiarisce però le responsabilità che Israele ha nei confronti dei palestinesi: l’articolo 56 della Quarta Convezione di Ginevra stabilisce che il Governo israeliano, in quanto potenza occupante, abbia la responsabilità di garantire l’assistenza sanitaria necessaria ai palestinesi della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e della Striscia di Gaza. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento dell’assistenza umanitaria (Ocha) ha annunciato che il piano per contrastare il coronavirus nei Territori palestinesi occupati richiede 34milioni di dollari. L’Unrwa (l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi,) ha poi lanciato un appello indipendente urgente, richiedendo 14 milioni di dollari per coprire gli interventi Covid-19 nelle sue cinque aree operative.
A Gaza il coronavirus si sommerebbe a una situazione già disperata. La disoccupazione giovanile è al 70% e quasi l’80% della popolazione dipende in maniera diretta dagli aiuti umanitari. Gli abitanti convivono con la cronica mancanza di acqua potabile e con continui blackout elettrici. Secondo l’associazione israeliana Physicians for Human Rights – Israel (Phri), in tutta la Striscia di Gaza ci sarebbero solo 70 posti letto in terapia intensiva, per una popolazione di circa due milioni di persone.
I problemi non mancano nemmeno in Cisgiordania. Sono quasi 100mila i palestinesi che si recano quotidianamente in Israele per ragioni lavorative, ora bloccati a causa della pandemia senza stipendio o indennizzi. I loro salari rappresentano circa il 14% del Pil totale della Cisgiordania.
Il Governo giordano è stato tra i primi al mondo a decidere di adottare misure preventive straordinarie e particolarmente restrittive al fine di contenere la diffusione del Covid-19, Il Primo Ministro Al Razzaz ha emanato la Defense Law con la quale ha dichiarato lo stato d’emergenza. A partire dal 17 marzo sono stati chiusi i tutti confini marini, terrestri e aerei. Successivamente è stata imposta la quarantena per tutto il Paese, sospendendo scuole, esercizi commerciali e uffici pubblici.
La popolazione può lasciare la propria abitazione, ove necessario, per l’approvvigionamento dei viveri ma alle 18 scatta il coprifuoco. Ogni venerdì, è previsto invece il coprifuoco totale. Sono previsti arresti fino ad un anno per chiunque violi tali misure. In Giordania il sistema sanitario nazionale è molto debole. Nel Paese ci sono poi 750mila rifugiati, per la maggior parte provenienti dalla Siria.
In Turchia contagio in ascesa
Il numero di infezioni da coronavirus è in rapida ascesa. Nonostante questo il presidente Recep Tayip Erdoğan non ha optato da subito per il lockdown insistendo sul fatto che “le ruote dell’economia devono continuare a girare”. Il Governo ha però gradualmente aumentato le misure per combattere il virus, con la sospensione dei voli internazionali, i valichi di frontiera e i viaggi tra le città, il divieto di raduni pubblici e di preghiera comunitaria e la chiusura delle scuole e della maggior parte dei negozi. Le persone di età inferiore ai 20 anni e oltre i 65 anni sono soggette a coprifuoco e i movimenti di truppe nella vicina Siria sono stati limitati. La Turchia ha poi imposto un coprifuoco di 48 ore a partire dalla mezzanotte del 10 aprile nelle 30 città metropolitane, tra cui Istanbul e la capitale Ankara.
La Turchia sta poi accelerando la stesura di una proposta di legge che potrebbe far tornare in libertà fino a 100mila detenuti. Stando alla bozza del provvedimento, giornalisti e difensori dei diritti umani rimarranno dietro le sbarre. Varie Ong hanno per questo diffuso una nota chiedendo l’estensione della misura a questa categorie di detenuti. Inclusi nella bozza, invece, gli autori di reati sessuali e quelle condannate per violenza di genere. Almeno 14 donne sono state assassinate dall’inizio delle restrizioni imposte per il coronavirus, aggravando il problema della violenza domestica in Turchia. Reporter senza frontiere ha nello stesso periodo denunciato che sette giornalisti sono stati arrestati per aver scritto articoli sulla pandemia e accusati di “diffondere il panico” e che almeno 385 persone sono state indagate per post critici sui social media.
Tregua in Yemen
Il coronavirus non ha risparmiato la casa reale saudita: secondo fonti di stampa il governatore della regione di Riad e altri membri della casa reale sarebbero positivi al virus. I primi giorni di aprile le autorità avevano avvertito che nelle prossime settimane potrebbero registrarsi fino a 200mila casi di covid-19 nel Regno. Le autorità hanno imposto il coprifuoco 24 ore su 24 in tutte le città del Paese. E’ stato vietato il pellegrinaggio a La Mecca e Medina e all’inizio di marzo 2020 sono state sigillate le aree.
Intanto per lo Yemen il coronavirus potrebbe essere riuscito là dove la diplomazia ha fallito. La coalizione araba a guida saudita che combatte contro i ribelli Houthi dello Yemen ha dichiarato un cessate il fuoco temporaneo unilaterale accogliendo la richiesta del Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres il 23 marzo per una moratoria delle azioni di guerra, rilanciata il 29 marzo da papa Francesco. Lo Yemen ha però annunciato il 10 aprile il suo primo caso confermato di contagio da coronavirus, nella provincia meridionale di Hadramout, controllata dal governo. Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito dell’impatto potenzialmente catastrofico di un’epidemia in questo Paese, devastato da cinque anni di guerra.
Scenario potenzialmente devastante anche in Siria, dove nove anni di guerra hanno distrutto, tra le altre cose, il sistema sanitario. In più casi, infatti, gli ospedali sono stati bombardati. Secondo il ‘The Syrian Response Coordination group’ al 27 marzo in Siria c’era a disposizione un letto d’ospedale ogni 2.378 persone nelle aree di opposizione nella Siria Nord Occidentale, mentre per ogni 37.549 persone era disponibile un solo respiratore. A febbraio 2020 nel Paese si contavano circa 1,5 milioni di sfollati, la maggior parte concentrati nella zona di Idlib, a cui non si può chiedere di ‘rimanere in casa’. Il governo siriano ha disposto la chiusura di attività non essenziali, la sospensione di scuole e università e l’imposizione di un coprifuoco di 12 ore al giorno.

Chiusura dei confini, misure di contenimento, controllo dei media, reticenza e scarsa trasparenza verso la popolazione. Per fronteggiare la pandemia, i governi delle ex repubbliche sovietiche hanno adottato strategie simili, mentre in Iran aumentano i numeri dei contagiati e si consolida la battaglia diplomatica con Washington. In Afghanistan, invece, salgono i contagi ufficiali e il Governo corre ai ripari, ma il sistema sanitario e istituzionale è estremamente vulnerabile e le Nazioni Unite insistono nella richiesta di un cessate il fuoco immediato.
Repubbliche dell’ex Urss
In Kazakistan, dove i confini con la Cina sono chiusi dalla fine di gennaio e dove a febbraio – rivela lo United States Institute of Peace – si sono registrate proteste contro cittadini kazachi finiti in quarantena dopo essere tornati dalla Cina – continuano i test e le misure di distanziamento sociale, adottate da circa un mese ormai. Il 12 marzo sono state cancellate le celebrazioni pubbliche per il Nowruz, la festa di primavera che segna il nuovo anno; al 13 marzo risalgono invece i primi casi ufficiali di contagio, a cui ha fatto seguito la chiusura di tutti i confini, dei luoghi di culto e il 15 marzo l’annuncio di un mese di stato di emergenza, che potrebbe essere prolungato. Le misure di contenimento, particolarmente severe nelle città di Almaty, Symkent e nella capitale Nur-Sultan, si accompagnano alla mano dura (centinaia i cittadini in carcere per aver violato la quarantena) e alle prime misure economiche per i disoccupati, mentre è allo studio piano economico di emergenza.
Tra le misure adottate dal Governo uzbeco c’è la chiusura dei confini, che continua a provocare seri ostacoli alle migliaia di lavoratori stagionali che cercano di rientrare dall’estero, specialmente dalla Turchia. Poche centinaia i casi registrati, ma il sospetto è che i casi effettivi siano molti di più. Il governo ha già stanziato un fondo speciale per affrontare l’impatto sanitario ed economico dell’epidemia e ha cominciato la costruzione di nuovi ospedali.
In Kirghisitan i primi tre casi accertati sono riconducibili a un pellegrinaggio religioso nel distretto russo di Blagoveshchensk, al confine con la Cina. Ai tre pellegrini le autorità kirghise hanno consigliato l’auto-isolamento, ma avrebbero comunque avuto contatti con centinaia e centinaia di persone. I confini sono chiusi, ma i lavoratori migranti pare possano rientrare in patria. Pochi centinaia i casi confermati, mentre le misure di sostegno economico per ora si limitano al posticipo dei pagamenti per le utenze domestiche e per alcuni esercizi commerciali.
Logiche diverse
A dispetto del confine con la Cina, il Governo del Tajikistan non ha ancora registrato ufficialmente alcun contagio. Il Governo ha organizzato voli di rientro per i tagichi che lavorano in Russia, ma il numero – più di un milione – è superiore alle capacità del Governo retto dal Presidente Emomali Rohman, al potere dal 1991. Le politiche contro l’epidemia dipendono dalle sue scelte: mentre gli altri Paesi dell’area hanno annullato le celebrazioni per il Nowruz, Rohman ha confermato la festa del 20-21 marzo, invitando 12.000 studenti in uno stadio, convinto che la demografia – in Tajikistan solo il 9% della popolazione supera i 55 anni – possa risparmiare il Paese. La scarsa credibilità dei mezzi di informazione e di quelli istituzionali fa diffondere velocemente teorie cospiratorie.
Voli per la Cina e per altri Paesi cancellati già dall’inizio di febbraio, voli dall’estero dirottati dalla capitale verso Turkmenabat, nel nord-est, dove era stata approntata una zona di quarantena, poi chiusura della maggior parte dei confini terrestri. Il Governo turcmeno ha agito in fretta, ma le notizie sul coronavirus hanno cominciato a raggiungere la popolazione solo dalla fine di marzo. Il Presidente Gurbanguly Berdimuhamedov, che ha suggerito come rimedio di bruciare in casa l’erba medicinale ruta siriana, cerca di mantenere l’immagine di un Paese sano e forte. Così, il 7 aprile ha organizzato eventi di massa per celebrare il World Health Day, con competizioni sportive nei parchi, sfide di judo, boxe e wrestling. Nel contempo, si prepara all’epidemia, concordando un piano di azione e risposta con le agenzie dell’Onu. Il confine con l’Iran non promette nulla di buono.
Il caso Iran
Il caso dell’Iran è il più noto dell’area ormai da tempo per numero di contagi e decessi, una situazione aggravata dalle sanzioni verso la Repubblica islamica imposte dagli Stati Uniti. Il Ministro della Sanità di Teheran, Saeed Namaki, ha annunciato al Parlamento che l’epidemia verrà contenuta entro la fine di maggio e ha rivendicato i 251.000 test diagnostici effettuati finora e i posti letto ancora disponibili (tra il 30 e il 50% dei totali), mentre altri 15.000 posti letto sarebbero già pronti per i pazienti in fase di recupero. Ma i contagi continuano a crescere.
Sul piano internazionale, continua intanto la battaglia diplomatica con gli Stati Uniti. Il Presidente Hassan Rouhani accusa Washington di “terrorismo medico”, a causa delle sanzioni che impedirebbero l’arrivo di rifornimenti medici indispensabili e ha invitato il Fondo monetario – a cui ha chiesto un prestito d’emergenza di 5 miliardi di dollari – a resistere alle pressioni statunitensi. Ma per il dipartimento di Stato Usa quei soldi serviranno a “finanziare l’avventurismo” iraniano all’estero, “non a comprare medicine per gli iraniani”.
Incognita Afghanistan
Sono più di 600 i casi ufficiali registrati in Afghanistan, dove cominciano a registrarsi contagi anche tra i medici, ai quali spetta un compito impossibile: contenere la diffusione dell’epidemia in un Paese dalle strutture sanitarie vulnerabili, senza mezzi e risorse necessarie. L’aiuto degli attori internazionali – tra i quali l’Unione europea, che ha destinato 117 milioni di euro per contenere il virus in Afghanistan – non sarà sufficiente, a meno che le ostilità non vengano interrotte. Lo ha ribadito il 31 marzo il Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il Presidente Ashraf Ghani si dice pronto a una tregua, mentre i Talebani hanno fatto sapere di essere disposti a deporre le armi, se e quando il virus arriverà anche nelle aree da loro controllate. Potrebbe essere troppo tardi: il cessate il fuoco, sostiene la società civile afghana, deve avvenire subito. Ma per ora il virus non ha fermato la guerra anche se gli stessi talebani hanno iniziato una campagna sanitaria (con una posizione opposto a quella dell’autoproclamato Stato Islamico) per rendere consapevoli nelle zone da loro controllate sui rischi di contagio.

Il continente asiatico è colpito dal virus in maniera molto diversa con differenti stati di contagio, capacità di controllo, scelte politiche, resistenza dei sistemi sanitari. Dopo una prima fase di contagi, molti Paesi che hanno contenuto la pandemia si trovano ora a fare i conti con una nuova fase di virus “importati” da concittadini rientrati dall’estero, persone che si riammalano e asintomatici. Alcuni Paesi membri dell’Asean (Associazione regionale del Sudest asiatico) hanno dimostrato un’invidiabile capacità di reazione con la sola eccezione dell’Indonesia, dove il futuro è colmo di incognite e il virus è stato affrontato con leggerezza e sottovalutazione più o meno calcolata. Le risposte migliori al virus, a parte il caso cinese, appaiono quelle di Singapore, Taiwan, Corea del Sud ma anche di Hong Kong e Vietnam e persino di piccoli Paesi come Laos e Myanmar anche se, in questi ultimi, i pochi casi conclamati potrebbero essere collegati alla mancanza di test diffusi. Non di meno, rispetto all’Europa, l’Asia orientale ha fatto passi da gigante scegliendo, più che il lockdawn, la tracciatura selettiva dei casi e il loro immediato isolamento. Più grave la situazione in Giappone dove, non avendo introdotto un lockdown totale, il Governo ha chiesto ai cittadini di restare a casa evitando di uscire se non per servizi essenziali (Tokio alla fine ha scelto di posporre le Olimpiadi di un anno). Resta una preoccupazione la criticità dei sistemi sanitari di Filippine, Cambogia, Indonesia (che pure ha introdotto il ticket sanitario gratuito), Laos e Myanmar, dove a prevalere è l’assistenza sanitaria privata o dove i sistemi pubblici non sono in grado di sopportare emergenze diffuse.
Lockdown per oltre un miliardo di persone
Quanto a India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal la situazione anche qui è stata affrontata in modi assai diversi. Pochissimi test in India e quindi un fenomeno di cui non conosciamo la portata (al momento oltre 10.000 casi e oltre 330 morti), mentre lo Sri Lanka ha chiuso immediatamente le sue frontiere essendo, stato uno dei primi Paesi colpiti fuori dalla Cina. I cinesi hanno comunque collaborato prontamente con tutti i Paesi dell’area con i quali esiste (con chi più, con chi meno) un rapporto privilegiato. In India, Narendra Modi ha deciso di estendere sino al 3 maggio il blocco già deciso in marzo a livello nazionale che scadeva martedi 14 aprile. Aumentano intanto le preoccupazioni sul fatto che la chiusura abbia già escluso dal lavoro milioni di poveri e informali costringendoli a un esodo dalle città ai villaggi. Nel momento della decisione di estendere il blocco, l’India registrava solo poco più di 8.400 casi con meno di 300 decessi. Nel vicino Pakistan a quella data si registravano 5mila casi e meno di 90 decessi.
La Cina
Mercoledi 8 aprile, dopo 11 settimane di lockdown, la città cinese di Wuhan, dove il Covid-19 è apparso per la prima volta, ha riaperto alla libera circolazione, pur con tutte le precauzioni del caso. Al centro anche di una battaglia politica (con reiterate accuse di aver diffuso un “virus cinese” o di aver nascosto i morti reali che ufficialmente risultano poco più di 3.200), la Cina continentale ha riferito sabato 11 aprile 46 nuovi casi di coronavirus, di cui 42 che hanno coinvolto viaggiatori dall’estero, in aumento rispetto ai 42 casi del giorno precedente. Domenica 13 la Rpc ha riportato 108 nuovi casi, il suo numero più alto in settimane, quasi tutti “importati”. Il ministero dell’Agricoltura intanto ha pubblicato l’elenco ufficiale degli animali commestibili nel quale, per la prima volta, non sono inclusi cani e gatti, la cui carne è consumata da una minoranza di cinesi. A febbraio era già arrivato il divieto di commercio e consumo di animali selvatici, pratica sospettata della diffusione del coronavirus.
Pericolo Indonesia
Il 14 aprile il presidente Joko “Jokowi” Widodo ha dichiarato la pandemia “disastro nazionale”. Una mossa tardiva mentre la sfida più grossa – in un Paese che oggi conta quasi 5mila casi e oltre 450 decessi (erano 1500 a inizio aprile con 136 morti) – deve ancora arrivare: si chiama Ramadan e prevede che tra 20 e 30 milioni di persone si spostino per il mese del digiuno, che inizia a breve. Ma anziché vietare i viaggi, il governo si è limitato a raccomandare che chi partecipa al mudik – o pulang kampung, il rientro a casa per le feste – faccia la quarantena. Il quarto Stato più popoloso al mondo (270 milioni) dopo Cina, India e Usa non è indenne dai rischi propri dei grandi Paesi, dove la mobilità è elevata e che oggi sono esempi di buone o cattive pratiche. Se negli Usa i casi aumentano, l’India ha rinnovato il lockdown e in Cina si sta uscendo dall’incubo, l’Indonesia sembra la negazione di quanto fatto sinora in Asia, visto che molti Paesi hanno saputo gestire il virus abbastanza bene. Fin dagli inizi di marzo, con l’ammissione reticente dei primi casi, Giacarta – continuando a gettare acqua sul virus – si è affidata a una sorta di fatalismo della speranza, nascondendo i dati come lo stesso Presidente Jokowi ha ammesso “per non suscitare panico”. Negligenza, attendismo, calcolo politico o difesa dell’economia?
Il 10 marzo l’Oms aveva scritto a Giacarta per spingerla ad azioni drastiche, ma lo stato di emergenza è solo del 1 aprile. Nonostante Jokowi stia costruendo nel Paese un sistema sanitario diffuso e universale, l’Indonesia non è pronta per una crisi in grande stile. Secondo la stampa locale ci sono tre posti letto ogni centomila persone, 8mila ventilatori in tutto l’arcipelago e pochissime strutture per terapia intensiva. A fine marzo una proiezione sviluppata da Universitas Indonesia-Bappenas ha spiegato che, senza distanziamento fisico obbligatorio e altre misure drastiche, si potrebbe avere un bilancio tra 48mila e 240mila morti entro aprile e che l’assenza di interventi forti potrebbe portare a circa 2,5 milioni di positivi per fine mese. Indice puntato anche sullo scontro tra Jokowi e il Governatore della capitale Anies Baswedan, favorevole a misure coercitive e al blocco totale di Giacarta cui Jokowi si è inizialmente opposto. Il Presidente si sarebbe – dicono i detrattori – occupato più dell’economia che della salute dei cittadini. Nel mirino anche il suo ministro della sanità Terawan Agus Putranto, un ex generale secondo cui il Paese sarebbe stato risparmiato dal virus grazie… alle preghiere.
Il dramma del lavoro
Tra i tanti, uno dei grandi settori dell’economia globale – il tessile/calzaturiero – ha in Asia – dal Bangladesh al Vietnam, da Sri Lanka all’India (solo qui circa 100 milioni di lavoratori) – la fucina dove le grandi firme fabbricano a prezzi super convenienti vestiti e scarpe. L’ondata peggiore della crisi passa soprattutto nei Paesi dove si produce su commissione e quindi in gran parte dell’Asia, dove la relazione tra aziende e sindacato è fragile, dove le garanzie per chi perde il lavoro sono minime e dove i meccanismi di protezione sociale, come l’assicurazione sanitaria o l’indennità di disoccupazione, non esistono o sono insufficienti. Lo stesso vale per i fondi di garanzia in caso di insolvenza. Marchi e distributori – salvo pochissimi – scaricano le conseguenze del calo della domanda sui fornitori e non pagano gli ordini già in essere. Ciò significa che i proprietari delle fabbriche esecutrici non hanno più liquidità per pagare i salari e che in futuro il quadro potrà solo peggiorare. Secondo l’associazione dei produttori del tessile (Bgmea) del Bangladesh per esempio, ordini per oltre tre miliardi di dollari sono finora stati cancellati. Si teme infine che alcune fabbriche possano utilizzare il Covid-19 come scusa per chiudere e riaprire o per licenziare più facilmente. E con lo stato di emergenza in molti Paesi scioperare diventa impossibile.

In tutto il Continente africano i casi registrati finora di Covid-19 equivalgono ai nuovi positivi di Italia e Spagna di un solo giorno. Il contagio, mentre chiudiamo il dossier, ha raggiunto circa 13 mila persone (di cui circa 8 mila concentrati in sole 4 nazioni), anche se oramai il virus ha toccato praticamente tutti i Paesi, 52 su 54.
Uno sguardo al continente
Guardando una mappa del Continente, alcuni elementi balzano all’occhio: i Paesi più colpiti (Marocco, Algeria, Egitto, Tunisia, Sudafrica), che comunque contano un numero di contagi sotto le 2.000 unità, sono alcuni degli Stati affacciati sul Mediterraneo e, al polo opposto, il più meridionale, ossia quelli col clima più temperato, con variazioni stagionali di temperatura. Alcuni Paesi che contano alcune centinaia di casi (da poco più di cento a meno di 500) si trovano nell’Africa centrale (Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Niger, Camerun, Senegal, Costa d’Avorio). Nel resto del Continente si tratta di poche decine di casi.
Va anche detto che solo in alcuni Stati la comparsa del virus è recente (in qualche caso anche solo da pochi giorni), mentre nella maggioranza le prime segnalazioni risalgono ad alcune settimane fa, o anche a oltre un mese. Naturalmente, questa progressione lenta non può essere attribuita a una migliore capacità delle nazioni africane di contenere il contagio rispetto a realtà come quelle europee, o agli Stati Uniti, oppure alla stessa Cina, che ha avuto la prima esplosione della pandemia.
Occorre anche sottolineare, osservando le linee di crescita della diffusione del virus, che quelle dei Paesi con pochi casi sembrano avere una crescita del tutto diversa da quelle di aree che stanno vivendo le maggiori emergenze: si tratta, almeno finora, di un andamento lineare, o talvolta “a gradini”, non esponenziale com’è avvenuto in Cina e poi in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, i Paesi africani più colpiti, quelli che oggi sono vicini o al di sopra delle mille unità, nell’ultima decina di giorni mostrano una linea di crescita che assomiglia a quelle europee, cinese o americana, cioè esponenziale, che negli ultimissimi giorni – fatte salve le differenze di scala (parliamo di decine di nuovi positivi, non di migliaia) – si stanno pericolosamente verticalizzando.
L’incognita tampone
Un primo quesito: dove i casi sono pochi dipende da quanto si sta monitorando? In altre parole, così come in Italia oggi si attribuisce l’elevato numero di positivi di questi giorni al fatto che è fortemente cresciuto il numero di tamponi effettuato sulla popolazione, può essere che il numero esiguo di positivi in tanti Paesi africani sia dovuto in realtà a un’assenza o scarsità di monitoraggio? Verrebbe da rispondere di no, perché se da un lato è certo che la totalità dei sistemi sanitari africani è meno strutturata di quelli europei, è altrettanto vero che in tutti gli Stati del Continente nero sono comunque presenti, soprattutto nelle capitali e nelle grandi città, presidi medico-sanitari sia locali, sia di organizzazioni umanitarie internazionali in grado di rilevare, se non altro per campione, i focolai di contagio. Si potrebbe obiettare che il maggior numero di casi è stato individuato in Paesi che hanno una sanità più strutturata. Ma anche questo è vero fino a un certo punto: Ruanda, Kenya, Nigeria, Senegal non presentano realtà medico-sanitarie così diverse da quelle di Marocco, Tunisia o Sudafrica. Inoltre, i rapporti intrattenuti fra la Cina e moltissime delle nazioni africane sono intensi, sia a livello di relazioni commerciali, sia di spostamenti di persone da e per il Paese asiatico. Quindi, ammesso che, ad esempio, l’Italia abbia “importato” l’epidemia dalla Cina, per ragioni analoghe diversi Stati africani avrebbero dovuto manifestare i primi casi più o meno alla stessa epoca. Insomma, detto tutto questo, sembra che in ogni caso il Covid-19 abbia in Africa un andamento diffusivo diverso da quello a cui abbiamo assistito in Cina, Corea del Sud, Europa o Stati Uniti.
I rischi e le ipotesi
Questo non significa che il coronavirus non possa diventare una catastrofe per l’Africa. Il guaio è che lo può diventare a prescindere dalla dimensione della pandemia.
Resta il fatto che finora il virus ha avuto una “vita” diversa rispetto a tutta la fascia Nord del Pianeta. Sono state avanzate delle ipotesi, su questo. La prima. I climi caldi o molto caldi rendono meno aggressivo il coronavirus. Può essere. Chi ha avanzato questa teoria lo ha fatto rilevando che si è registrata una minore diffusione del virus nelle zone più calde e umide all’interno degli stessi Paesi duramente colpiti (anche i dati della pandemia in Sud Italia lo confermerebbero).
Vulnerabilità
L’altra ipotesi è che tra le zone più e meno colpite del Mondo c’è una fondamentale differenza, l’età media della popolazione: l’Europa e il Nord America sono regioni a lunghissima speranza di vita. Viceversa, in Africa il 60% del miliardo e 300 milioni di abitanti del Continente è sotto i 25 anni. Quello che non sappiamo – perché finora tutti i Paesi con maggiore contagio hanno reagito al virus solo in emergenza e quindi con mezzi insufficienti a monitorare in modo massivo la popolazione – è quanti sono gli asintomatici (ossia contagiati senza alcun sintomo che vada al di là di un raffreddore) e quanti i paucisintomatici (ossia con sintomi paragonabili a una influenza neanche tanto forte). L’ipotesi quindi è che in Africa il virus possa essere molto, ma molto più presente di quanto sia stato rilevato, ma con nulli o pochi sintomi. Se così fosse, si potrebbe ipotizzare una sorta di singolare “immunità di gregge”, che si crea per via dell’età media molto bassa: il Covid-19 non trova con facilità ospiti “accoglienti” perché in maggioranza sono bambini o giovani. La pandemia, per l’Africa, potrebbe però diventare disastrosa comunque. In parte perché il Continente, ancora una volta, pagherebbe il prezzo dei guai altrui. E questo, in realtà, sta già accadendo: le esportazioni di materie prime, come pure le importazioni di prodotti lavorati e di generi alimentari, sta subendo un forte rallentamento, dovuto in gran parte alle emergenze del Nord del Mondo. Un secondo forte rischio è la diminuzione degli aiuti internazionali e umanitari, provocato dalle emergenze che vivono i Paesi ricchi e alla crisi economica che si prospetta. Un terzo problema è la probabile riduzione delle rimesse dei migranti, che – ricordiamolo – costituiscono la prima voce di “aiuto” ai Paesi africani, superiore a quella del sostegno internazionale. Anche sotto questo profilo, la crisi pesantissima che si prefigura nelle economie forti sarà pagata pesantemente dalle fasce di popolazione più vulnerabile, fra cui c’è la gran parte dei lavoratori stranieri affluiti in Europa e negli Stati Uniti.
Il prezzo da pagare
Se anche fosse vero, dunque, che l’Africa sarà colpita in modo molto meno duro dalla pandemia, pagherà un prezzo altissimo, tanto che le previsioni della Banca Mondiale indicano che per la prima volta da 25 anni a questa parte il Continente andrà in recessione, passando da una crescita del 2,4% del 2019, a un calo compreso fra il 2,1 e il 5,1 nel 2020.
Ovviamente, uno scenario ben diverso si prospetta se, pur con una evoluzione più lenta, il virus esploderà comunque con numeri di contagio rilevanti. Per cogliere la dimensione del disastro basti qualche dato: a fronte del 16% della popolazione globale del Pianeta, l’Africa ha l’1% delle risorse dedicate alla sanità. Il continente africano ha in media solo 2 medici ogni 10.000 abitanti (con le dovute differenze tra Paesi), così come ha, secondo l’Oms, 5 posti letto di terapia intensiva, in media, per milione di abitanti.
Sembra che, comunque vada, sia saggio il consiglio dato ai governi del Continente nero dal Direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Il miglior consiglio da dare all’Africa», ha detto, «è quello di prepararsi al peggio e prepararsi sin da oggi». Lo stanno facendo, le leadership africane? Perlopiù sì, per ciò che possono. La maggioranza dei Governi ha emanato provvedimenti di distanziamento sociale e restrittivi alla circolazione delle persone. Spesso però in modo non coordinato. Se il Ruanda e il Sudafrica hanno posto norme abbastanza simili a quelle italiane e la Tunisia ha persino riesumato alcuni robottini su ruote per “stanare” chi viola il lockdown totale decretato (per ora) fino al 15 aprile, in Kenya il presidente Uhuru Kenyatta ha decretato il 6 aprile scorso 21 giorni di chiusura totale della città e dell’hinterland di Nairobi con coprifuoco serale e ristretto il movimento in altre 3 regioni, mentre il Sud Sudan (che ha ad oggi 4 casi e nessuna vittima) ha stabilito sei settimane di coprifuoco notturno e chiusura totale di aeroporti, scuole, moschee e chiese. Il Senegal ha chiuso scuole, università e ha soppresso le manifestazioni religiose, la Nigeria ha messo in rigida quarantena la capitale federale Abuja e la città più popolosa, Lagos, che conta oltre 20 milioni di abitanti. La RD Congo ha vietato assembramenti al di sopra delle 20 persone. In 20 Paesi sono state chiuse le scuole.
Iniziativa etiopica
Anche in questa circostanza, il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali (Premio Nobel per la Pace 2019) ha dimostrato una levatura diversa: oltre ad avviare da subito un tavolo di coordinamento con una decina di altri presidenti africani, si è rivolto al G-20 con un piano in tre punti: la creazione di un fondo globale per l’Africa con 150 miliardi di dollari per fronteggiare l’emergenza, uno specifico pacchetto di interventi sui sistemi medico-sanitari, infine una sostanziale riduzione o ristrutturazione di quel debito estero che appesantisce tanti degli Stati del continente.
Un’ultima annotazione. Le misure decise nei Paesi del Nord del mondo possono essere efficaci in Africa? La risposta, sintetica e puntuale, l’ha data il ginecologo congolese Denis Mukwege (anche lui Premio Nobel, nel 2018): «Temo l’ecatombe», ha detto, «perché non abbiamo i mezzi per combattere il virus e perché gli africani sono costretti a uscire di casa per procurarsi il cibo. Nessun confinamento è dunque possibile, e il Covid-19 si sta diffondendo a velocità da primato». Il “distanziamento sociale” nel Continente è una chimera. Metterlo in atto per la maggioranza degli africani significherebbe fame entro 72 ore.

Mentre Il presidente Donald Trump ha rivendicato lunedi il potere “totale” di revocare il blocco del coronavirus a livello nazionale, contraddicendo i governatori e i costituzionalisti, con oltre 20 mila vittime accertate e più di mezzo milione di contagiati, gli Stati Uniti d’America sono divenuti a tutti gli effetti il nuovo epicentro della pandemia. Lo aveva già preventivato l’Oms da Ginevra il 24 marzo, ma lo ha ignorato invece il Presidente Trump, nonostante gli allarmanti rapporti interni ricevuti attorno al 20 gennaio, quando il primo contagio venne accertato. “Entro aprile, quando diverrà un po’ più caldo, (il virus) scomparirà miracolosamente” dirà il 10 febbraio durante un briefing con i Governatori locali. E’ però del 10 aprile una lettera dell’Accademia Nazionale dell’Ingegneria e della Medicina che chiede al Presidente di stare attento con le sue famose “gut decisions”, decisioni di pancia, poiché il contagio, non sarebbe una questione di caldo/freddo o secco/umido, bensì di immunità collettiva, ancora molto ridotta, a questo punto della pandemia. Il tentativo di controllare comunicazione e narrazione di Covid-19, manipolarle ed utilizzarle a proprio favore, sembrano essere stata la cifra dell’azione di Trump. Apparire più che agire insomma e sembra aver funzionato, dato che nonostante le critiche ricevute da tutti i maggiori osservatori della stampa, i cittadini che approvano e disapprovano l’operato di Trump nella crisi sembrerebbero eguagliarsi.
Ad oggi l’emergenza sanitaria ha costretto 42 Stati federali su 50, 3 contee, 9 città, il distretto della Columbia ed il territorio di Porto Rico ad imporre misure di distanziamento sociale e quarantena di massa, coinvolgendo il 95% della popolazione americana, 316 milioni di persone. L’impatto economico sull’economia reale è devastante: il boom del mercato del lavoro è finito con i 17 milioni di moduli di disoccupazione compilati nelle ultime 4 settimane. Negli Usa i senza lavoro stavano diminuendo interrottamente su base annuale dal 2010. Nel solo mese di febbraio però i disoccupati sono passati dal 3,5% al 4,4,%, facendo poi registrare a marzo la più grande perdita di lavoro su base mensile dalla Grande Depressione degli anni Trenta: 700 mila posti di lavoro andati in fumo.
Il contagio della Grande Mela
Mentre, quindi, i Governatori dei singoli Stati federali leggono quotidianamente il numero dei contagiati e delle vittime, Trump pensa a quando poter revocare le linee guida non vincolanti di distanziamento sociale, con l’orizzonte oggi del 30 aprile. E’ vero, i numeri sembrano lentamente essere in flessione in California, come nella colpitissima New York, dove come riporta Reuters sono diminuite ospedalizzazioni ed ammissioni alle terapie intensive, ma gli esperti sanitari americani, guidati dal dottor Fauci, raccomandano cautela. I decessi, soprattutto nello Stato della Grande Mela rimangono infatti moltissimi: ad esclusione degli Usa nella loro interezza, è infatti quello lo Stato con più infettati al mondo, almeno 180mila contagiati e 9mila morti. Tanto che MIT press ha osservato che Covid-19 ha rivelato “il fallimento della gestione della logistica dei morti” e della capacità di prevenire ciò che i virus normalmente fanno: “accumulare corpi”. D’altronde se normalmente negli USA nel 2019 morivano circa 8mila persone al giorno, nella settimana 6-12 aprile, Covid-19 avrebbe spezzato le vite di 2000 persone in più al giorno. Così hanno fatto il giro del Pianeta le foto diffuse dal NYPost, che mostrano quelle che sono fosse pubbliche a tutti gli effetti, sull’isola di Hart Island, a largo di Manhattan, dove normalmente vengono seppellite le salme non reclamate, dopo una giacenza in obitorio di 60, oggi diminuita a soli 14 giorni. La media era di 25 corpi una volta alla settimana, ora sono 5 i giorni di lavoro con picchi di oltre 40 cadaveri.
I falchi del business as usual
Al fronte dei cauti e della prima linea di New York, si contrappongono però i governatori repubblicani di Texas e Florida, che continuano ad alimentare l’impazienza di Trump, reclamando il ritorno ad un quasi “business as usual”. Da una parte c’è l’imperativo della crescita economica e la pressione delle lobby di industriali e investitori privati, dall’altra l’esigenza di provare a contenere il malumore economico nell’elettorato trumpiano, che a novembre sarà chiamato a confermare o sfrattare Donald dalla Casa Bianca. Inutile dire quanto il Presidente sia insoddisfatto e preoccupato per la rielezione. Del resto, come punge un osservatore privilegiato come David Smith del Guardian: “Trump ha sempre dichiarato di saper definire gli eventi, ora però sono gli eventi che lo stanno definendo”. Sempre alla rincorsa, con timing sbagliati, decisioni giudicate inefficaci, schizofreniche a livello di politica estera ed in generale incoerenti, la leadership è mancata nei fatti, meno nella capacità di saper mascherare la realtà. In un’epoca di post-verità, infatti, l’accuratezza dei dati e l’essere nei fatti un “bugiardo patologico” (come lo definisce il democratico Sanders) sembrano non contare. Dato che dopo aver negato la gravità della situazione il 9 marzo, dieci giorni dopo Donald è ritornato clamorosamente sui propri passi spiegando di “aver previsto prima di molti altri che sarebbe stata una pandemia”.
Controversie
Tre le questioni più controverse. Innanzitutto l’impiego terapeutico dell’Idrossiclorochina, un potente farmaco antimalarico ed impiegato nella terapia contro il Lupus, ripetutamente esaltato da Trump. Il dottor Fauci ha però spiegato come potrebbe dare “buoni esiti”, ma “non se ne conoscono gli effetti in un organismo malato da Covid-19”. Fauci, infettivologo italo-americano, che è fortemente criticato dagli ambienti conservatori repubblicani, che lo accusano di aver consigliato il lockdown condannando l’economia Usa alla recessione, vive ora sotto scorta, dopo aver ricevuto nell’ultimo periodo numerose minacce di morte da vari gruppi di estrema destra.
Vi è poi la difficoltà politica interna di Trump, che lo ha visto politicizzare la crisi attaccando ed indicando come capri espiatori prima la Cina e più recentemente l’Oms. Quest’ultima è stata accusata di “essersi sbagliata su molte cose” ed aver agito “sino-centricamente”, senza pretendere più trasparenza da Pechino e criticando invece Washington sulle restrizioni di viaggio dalla Cina. Il Presidente ha quindi dichiarato che la sua Amministrazione “rivedrà” il fondamentale contributo che gli Usa versano all’Oms annualmente, circa il 14,67 % del bilancio totale: 893 milioni di dollari, dei quali solo 236 vincolati. Da un lato l’esperta dottoressa Katz ammette su Science che Trump ha il potere legale di farlo, anche se l’Oms, già sotto-finanziato, ha reagito pregando di “non politicizzare la crisi”. Dall’altra Stephen Burany dà invece ragione a Trump suggerendo però che il comportamento dell’Oms possa essere stato strategico, ovvero volto a coinvolgere la Cina nella gestione di una crisi che altrimenti come nel caso della SARS, sarebbe stata affrontata senza il Paese inizialmente più coinvolto e con molte meno informazioni a disposizione.
Infine, in aggiunta alla debolezza contingente della loro leadership improvvisata, gli Usa stanno mostrando la loro più grande fragilità interna e strutturale: essere una grande democrazia neoliberale priva delle fondamentali garanzie di un moderno stato sociale. In un Paese nel quale l’assistenza sanitaria è per lo più privata, i test per Covid-19 sono stati resi gratuiti altrimenti non lo sarebbero stati e persino Trump ha dovuto riconoscere la necessità di pagare le cure dei circa 30 milioni di non-assicurati in caso di contagio. Cionondimeno, come ha ricordato il Senatore democratico Sanders, il problema sorge anche per i nuovi disoccupati, e “l’idea che l’assistenza sanitaria sia un benefit del lavoratore è assurda”. Ecco perché con la rappresentante Pramila Jayapal, ha proposto un disegno di legge che garantirebbe il pagamento delle cure essenziali alla sopravvivenza per tutti gli americani che hanno/perderanno il lavoro o per i quali permettersi le cure per Covid-19 ed altre patologie, come il cancro, significherebbe, durante l’emergenza, dilapidare i propri risparmi.
Disparità socio economiche
Del resto la realtà è impietosa: Covd19 ha un chiaro gradiente socio-economico. La comunità afroamericana presenta il tasso di mortalità da Covid-19 maggiore e tra i giovani under-65 quelli più a rischio, sono persone di colore dal reddito inferiore ai 25 mila dollari annui, dove abitano nuclei multigenerazionali di 3.2 persone per appartamento, con il 20% dei contagiati in più rispetto alla media. Si contrappongono ai quartieri dove i 2/3 della popolazione ha invece un reddito di 120 mila dollari annui, come in alcune aree di Brooklyn, dove il contagio è del 56% inferiore alla media. Due le ennesime prove di una società che abbandona i più poveri premiando i pochi: da una parte le immagini diffuse su Twitter da Reuters e scattate da Steve Marcus, dei 500 senzatetto di Las Vegas, Nevada, fatti dormire all’addiaccio un parcheggio transennato dalle forze dell’ordine locali mentre si è stimato che 150mila camere d’albergo nella città fossero libere; dall’altra l’ennesimo paradosso della Casa Bianca, che mentre consiglia alla popolazione come fabbricarsi con semplice cotone ricavato dai vestiti una mascherina, emana un ordine esecutivo con il quale promette di inviare aiuti sanitari all’Italia.
Il Canada
La risposta Canadese si caratterizza invece per la precauzione del Governo e per la compostezza della popolazione che sta rimanendo in casa, seguendo le rigorose direttive dell’esecutivo di Ottawa, che ha anche stanziato un centinaio di miliardi di dollari canadesi nella lotta al virus. Il denaro non sarà solo destinato alla sanità, (che riceve già oltre il 10% del Pil nazionale, ed è considerata molto efficiente, oltre che essere gratuita e universale a differenza dei vicini Usa dove 87 milioni sono non o solo parzialmente assicurati), ma soprattutto al sostegno delle imprese e delle persone (oltre un milione) rimaste senza lavoro a causa delle ripercussioni economiche della crisi. Mentre la sanità nazionale copre il 70% delle spese mediche dei suoi cittadini, il 30% affidato ad assicurazioni sanitarie private sta infatti divenendo un bene che solo pochi possono permettersi.
Beni sempre più rari sono anche i dispositivi sanitari di protezione: mentre il Parlamento lavora incessantemente per fornire materiali a tutte le Province (vere gestrici della sanità pubblica nel Canada federale), è necessario fare i conti con la Casa Bianca, che nel pieno della crisi, avrebbe impedito alle compagnie americane di vendere respiratori e altro equipaggiamento al vicino settentrionale. Il messaggio di Ottawa a Washington è però stato chiaro: se gli accordi saltassero adesso, ci sarebbero ritorsioni dal Grande Nord, ricordando che l’unico confine canadese ancora aperto è proprio quello con gli Usa, con i quali, ha dichiarato Trudeau, lapidario: “lo scambio di materiale e personale medico è a doppio senso”.
Il Paese si dimostra unito davanti all’emergenza: i cittadini canadesi si sarebbero detti, secondo uno studio dell’Istituto statistico nazionale, pronti a sostenere “qualsiasi misura ancora più restrittiva che il governo vorrà mettere in atto”, anche a costo di un deficit economico. E le prime misure più invasive sono già state prese: per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale, Google Maps Canada ha reso pubblici (in forma anonima) i dati sugli spostamenti delle persone. Un modo per controllare non l’identità, quanto il numero delle persone presenti in un determinato luogo, al fine di scongiurare i contagi. Intanto, dal Quebec sta arrivando un’applicazione per smartphone – sul modello della Corea del Sud – con la quale controllare posizioni delle persone ed eventuali contatti con persone positive al test. Una compressione del diritto alla privacy che, a ben guardare, era già prevista nella legge canadese che sancisce come le norme sulla privacy non possano ostacolare la tutela dell’interesse pubblico alla salute.

Mentre il Covid19 colpisce duramente anche l’America Latina, senza conoscere frontiere, le crisi latenti che si erano espresse nel corso del 2019 si fanno più evidenti, gettando un’ombra minacciosa sul presente e sul futuro immediato. La diseguaglianza sociale ed economica che aveva alimentato le proteste e le crisi politiche dalla Colombia al Cile, investendo tutto il Sud delle Americhe rischia di crescere fino alla rottura del tessuto sociale, gettando nella miseria assoluta decine di milioni di donne ed uomini, che lottano per emergere da condizioni di vita già al limite della sopravvivenza.
Cambio di prospettiva
“Avevamo preparato un rapporto molto diverso, incentrato sulla macroeconomia e sulla disuguaglianza. Era pronto per essere pubblicato, ma con lo scoppio della pandemia abbiamo dovuto cambiare rotta molto rapidamente per rispondere alla nuova situazione” Con queste parole si apre lo studio appena pubblicato dal dipartimento di ricerca del Bid, Banco interamericano de desarrollo, la Banca interamericana per lo sviluppo, che prosegue:
“La crescita si è praticamente bloccata nel 2019 per l’America Latina e i Caraibi. La ripresa della crescita all’1,6% era prevista per gennaio 2020, ma le prospettive sono ora radicalmente cambiate a seguito della crisi umanitaria ed economica causata dal nuovo coronavirus. I Paesi della regione stanno adottando misure decisive per prevenire la diffusione del virus. Queste misure di contenimento equivalgono a una chiusura parziale e organizzata dell’economia e comporteranno una significativa perdita di Pil. Questa è una situazione senza precedenti.”
Gli eventi drammatici in Cina, Europa e Stati Uniti avranno un impatto considerevole in America Latina e nei Caraibi. Le principali banche di investimento prevedono una crescita negativa per l’economia mondiale per il 2020, tra –1% e –3% del Pil, ma un elevato grado di incertezza accompagna queste cifre. Il Bid nel suo studio ha disegnato quattro scenari di shock, definiti moderato, forte, grave ed estremo, anche se fa notare che perfino lo scenario di shock moderato corrisponde a un cambiamento significativo nelle prospettive.
Lo studio parte dal dato base della crescita del Pil in America latina nel 2019, che è stato del 2,1. Ora, a conseguenza della crisi del Covid19, i quattro scenari prevedono tutti una contrazione del prodotto interno lordo, così descritti: impatto moderato: meno 2,1; forte: -3,2; grave: -4,1; estremo -4, 8. Un crollo drammatico, e se si pensa che le proteste dell’anno passato sono avvenute in un contesto di crescita, se pur moderata, non occorre immaginazione per prevedere cosa causerà a livello sociale la caduta dell’economia che già accompagna la crisi sanitaria ed umanitaria in corso.
Quali rimedi propone il Bid ? Nel rapporto si dice che, oltre agli strumenti tradizionali, come la riduzione del tasso di interesse, le banche centrali latinoamericane dovrebbero adottare misure “non convenzionali, per evitare conseguenze permanenti di uno shock negativo che sarà transitorio, ma potenzialmente molto grave”.
Suggerisce il Bid di “fornire liquidità per mantenere aperte le catene di approvvigionamento, e ridurre al minimo la perdita di posti di lavoro e i fallimenti. Questi possono essere tempi molto difficili che possono richiedere misure temporanee straordinarie”.
A rischio il settore informale
Le famiglie con lavoratori nel settore informale saranno le più colpite, non solo perché potrebbero perdere la loro fonte di reddito, ma anche perché non riceveranno sussidi di disoccupazione, e in assenza di una sanità pubblica, non godono di un’assicurazione sanitaria. Le piccole e medie imprese, che dipendono dalle vendite giornaliere, e che dispongono di riserve di liquidità scarse o assenti saranno soggette a gravi stress finanziari, e potrebbero dover licenziare i lavoratori. Queste aziende sono collegate ad altre della stessa dimensione, nonché a società più grandi attraverso le catene di approvvigionamento. Molte di esse, proprio per il loro stato informale, difficilmente avranno accesso al credito, ma, sostiene il rapporto, “tassi di interesse più bassi possono aiutare le grandi aziende a cui esse sono collegate attraverso le catene di approvvigionamento e mantenere in vita il settore informale”.
Questa raccomandazione va in controtendenza con le linee di ispirazione neoliberista che ha orientato non solo il Bid, ma tutti i centri decisionali in materia economica fino a ieri, come la raccomandazione che segue, che, per una volta, raccomanda: “Data la natura straordinaria della situazione attuale, potrebbe essere nell’interesse delle autorità monetarie collaborare con le autorità fiscali per valutare la possibilità di fornire liquidità al sistema sanitario (…) le banche centrali possono rapidamente fornire liquidità, in cambio di un titolo di Stato per una parte dell’iniezione di liquidità che potrebbe essere richiesta”.
Sistemi sanitari fragili
Ma la fragilità dei sistemi sanitari di tutti i Paesi dell’area è il frutto di decenni di disinvestimenti quasi ovunque, e dell’adozione generalizzata di modelli privatistici, e questa apertura all’indebitamento per rafforzare la politica della salute arriva con enorme ritardo, quando le risposte devono essere immediate.
Nel rapporto si fa notare infine che, dalle precedenti crisi economiche, l’America latina ha sempre dimostrato di ripartire con maggiore lentezza di quanto non avvenga nel resto del Pianeta. Si preparano tempi assai duri, specialmente per le classi media e bassa, e per l’economia informale, che per vasta parte della popolazione è l’unica forma di sussistenza. Se con una crescita superiore al 2 percento il 2019 è stato un anno di rivolte, gli anni prossimi si mostrano drammatici.
Drammatica fin da ora è la situazione dei profughi venezuelani in Colombia, almeno 1 milione e 800mila donne e uomini che si ammassano in condizioni precarie nelle periferie delle città, da Cucuta, appena oltre il confine, alla capitale Bogotà. Qui l’impossibilità di mantenere le distanze, la mancanza delle condizioni minime di igiene, e l’assenza di servizi sanitari rappresentano non solo un rischio enorme per i profughi stessi, ma anche focolai di infezione a per il resto della popolazione.
E anche nello stesso Venezuela il sistema sanitario, già in crisi per l’embargo su medicinali e materiale medico, non è minimamente in grado di fronteggiare la pandemia, su cui, vista l’inattendibilità dei dati ufficiali, mancano dati certi. Ma alla scarsità di ventilatori si aggiungono i continui black-out della rete elettrica determinati dalla crisi energetica che non ne rendono possibile il funzionamento costante e necessario. E la stessa erogazione dell’acqua è intermittente. Nemmeno la massiccia presenza di personale medico cubano, in queste condizioni, è in grado di arginare la minaccia incombente.
Polemiche su Cuba
Sul personale medico cubano che collabora ormai da molti anni su tutta l’ America del Sud si è accesa ora la polemica innescata da Donald Trump. Che è passato all’offensiva, denunciando quello che secondo lui è uno sfruttamento dei propri medici, che si vedono corrisposto solo il 10 percento dei salari pagato dai Paesi ospiti, mentre il restante 90 percento – sostiene – va al servizio sanitario di Cuba. Nell’attacco mediatico lanciato dal Presidente Usa, si denuncia anche il fatto che, con l’invio di medici dall’isola caraibica, si toglierebbe lavoro al personale medico locale.
Ma in Ecuador, dove la pandemia comincia a farsi sentire, si denuncia come il ritiro del personale cubano abbia lasciate sguarnite soprattutto le strutture sanitarie rurali, dove i medici ecuadoriani non sono disposti ad andare. Mentre i dati statistici sono difformi da Paese a Paese, rilevati solo parzialmente e con criteri incerti e incomparabili, che la pandemia si vada diffondendo nel subcontinente è ormai appurato. E il prezzo da pagare sarà altissimo.
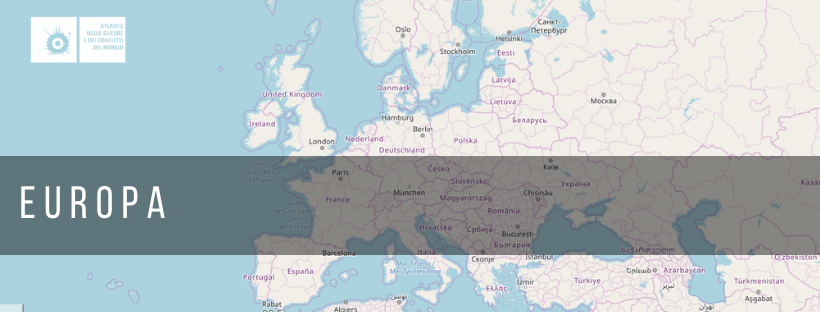
Mentre in Spagna e Italia la situazione è apparentemente in lento, ma costante miglioramento, dopo il picco raggiunto verso la fine di marzo, Paesi la cui risposta è stata meno tempestiva si trovano a fronteggiare un quadro drammatico è il caso, tra altri, della Francia o del Regno Unito. Londra, che dopo aver sostenuto la teoria dell’immunità di massa aveva virato alla strategia del contenimento dei contagi solo a metà marzo, ha visto un rapidissimo incremento di soggetti positivi. Il numero dei decessi giornalieri nel Regno Unito ha già superato i record di vittime italiano e spagnolo: secondo gli esperti, la pandemia in Inghilterra sarà la più letale d’Europa e potrà arrivare attorno alle 3000 vittime nel giorno di picco. Una sorpresa per l’NHS, il tanto acclamato sistema sanitario inglese, che prima dell’emergenza Coronavirus era in testa alle classifiche: oggi, con un numero di contagi che cresce esponenzialmente, le unità di terapia intensiva stanno raggiungendo la saturazione troppo velocemente. Ricoverato (e trattenuto in terapia intensiva per un paio di giorni), il premier Boris Johnson, positivo al virus, è uscito dall’emergenza, ma l’accaduto sembra aver sortito poco effetto sugli inglesi: secondo le autorità sono ancora troppi i cittadini che non prendono sul serio le direttive, violando le regole sul distanziamento sociale invece di stare a casa.
L’eccezione svedese, il caso ungherese
Colpisce il caso svedese, che rimane l’unico Paese del Continente a non adottare misure di lockdown: business, ristoranti e bar restano aperti, e i cittadini continuano a uscire pur rispettando distanze di sicurezza ed evitando grandi raduni. Intanto, in Polonia il Governo insiste invece per non posticipare le elezioni, previste per metà maggio, nonostante le gravi preoccupazioni sollevate da cittadini chiamati alle urne, opposizioni e UE. Radicalmente contraria la reazione alla pandemia dell’Ungheria: adducendo a motivazione l’emergenza coronavirus, il Parlamento ha approvato una legge che concedeva al Primo Ministro Orban amplissimi poteri, estendendo lo “stato d’emergenza” che il Paese aveva dichiarato all’inizio del mese. Una svolta drammaticamente autoritaria: fino a quando la “Legge di emergenza per il Coronavirus” non sarà abrogata, Viktor Orban potrà governare per decreto, anche in violazione delle norme di legge esistenti. I dubbi sul rispetto del principio di legalità (fondamento dei trattati dell’Unione Europea, a cui l’Ungheria ha aderito) non sembrano del tutto infondati, se si osserva come questo potere sia stato usato per limitare diritti umani: le prime norme adottate sono contro la libertà di stampa e la popolazione transessuale. Cose che hanno poco a che fare con la pandemia in corso
Porti sicuri
L’emergenza sanitaria come giustificazione politica ha sollevato reazioni scettiche anche in Italia, che dalla scorsa settimana si è dichiarata “Paese non sicuro” a causa della pandemia di coronavirus: secondo le regole di diritto internazionale, questo impedisce alle navi di soccorso di migranti nel Mediterraneo di far sbarcare i propri passeggeri. Un decreto che equipara la situazione italiana a quella di Paesi affetti da carestie o straziati da guerre decennali, proprio mentre, anche grazie alle condizioni climatiche più favorevoli, le partenze dalla Libia sono tornate ad aumentare. L’Italia, scrivono ONG e osservatori nazionali e mondiali, dovrebbe farsi pilastro di civiltà e dignità in un momento come questo; invece, questo stratagemma permette all’Italia di “lavarsi le mani” da virus e sbarchi, mentre chi parte dai lager libici – dove la tortura è fisica oltre che psicologica – resta intrappolato, in un rimbalzo di responsabilità tra Paesi Europei.
Si appellano alla responsabilità europea anche i Paesi balcanici, che soffrono la decisione europea di chiudere le frontiere esterne alla vendita di dispositivi sanitari: senza rifornimenti dall’Unione Europea, i sistemi sanitari dei Balcani potrebbero trovarsi presto in ginocchio. Il rischio è quello del disordine sociale: in Kosovo, dove al virus si è risposto imponendo lo stato di emergenza, la popolazione manifesta (da casa) contro la corruzione di quello che doveva essere un Governo di cambiamento e “pulizia”.
Dilemma europeo
Lo spostamento dell’epicentro del virus all’Europa a inizio marzo sembra insomma aver stravolto le fisionomie del continente e – più tragicamente – dell’Unione Europea. L’Unione all’insegna della libertà di spostamento, di commercio e di circolazione dei capitali, si è trincerata: nelle proprie case e, spesso, nelle proprie convinzioni.
La libertà di circolazione delle persone è limitata non solo per la decisione delle compagnie di trasporti, aeree e navali, ma soprattutto per la sempre più stringente regolamentazione d’emergenza che i Paesi hanno adottato: reintroduzione di controlli di dogana ai confini, restrizioni alla circolazione interna dei veicoli e diniego a navi e aerei non commerciali di sbarcare sul suolo nazionale. Tutti a casa, quindi, anche dalle scuole (tra il 24 febbraio e il 16 marzo tutti i Paesi Europei hanno riconosciuto la necessità di sospendere l’insegnamento scolastico, anche se a vari livelli). Chiusi da metà marzo anche i confini esterni dell’Unione: una misura emergenziale che la Commissione Europea propone di estendere fino alla metà di Maggio.
Ma ad essere messo in discussione è stato anche un altro grande pilastro dell’Accordo di Schengen, la circolazione dei prodotti: Governi come quello tedesco hanno inizialmente opposto resistenza alla circolazione dei dispositivi sanitari, dal materiale monouso come guanti e mascherine, fino ai respiratori per la terapia intensiva. È stato necessario un intervento delle istituzioni Europee: la Commissione ha messo in atto un piano ambizioso comprendente l’approvvigionamento comune di materiale sanitario, una scorta preventiva comune tra gli Stati Membri e incentivi per velocizzare la produzione di questi dispositivi in Europa.
E fa discutere, proprio a tal proposito, la scelta del Regno Unito. Abbandonato da poco il tavolo a Bruxelles, Londra ha rifiutato l’offerta europea di partecipare all’acquisto congiunto di respiratori: Downing Street ha giustificato maldestramente l’accaduto con un “problema di comunicazione”; la polemica si è scatenata quando, pochi giorni dopo, il presidente americano Donald Trump annunciava l’invio di 200 respiratori all’alleato inglese.
Fine dell’austerity?
La battaglia più grande per i Governi europei si combatte ora dal punto di vista fiscale. Di fronte alla grave crisi economica, Stati e mercato comune necessitano di un’azione coordinata tra misure nazionali, azione a livello di eurozona e di Unione Europea. Che questo non sia il momento per l’austerità è chiaro in primis alle istituzioni UE: fin dall’inizio dell’emergenza, la Commissione ì e i Ministri delle Finanze hanno annunciato grande flessibilità nell’applicazione delle regole finanziarie e di bilancio. Dopo l’azione della BCE, che ha destinato 750 miliardi per l’emergenza e lo sblocco del Fondo di Solidarietà europeo (che permetterà ai Paesi membri di accedere a 800 miliardi nel 2020), i Governi dell’Eurogruppo sono riusciti a trovare un accordo da 500 miliardi di euro. Dibattutissimo e finora rifiutato, il tema dei cosiddetti “Eurobond”, i titoli di credito europei, da affiancare ai vari bond nazionali. Lo scontro ha visto i Paesi del Sud Europa (Francia, Spagna e Italia che hanno a gran voce insistito per la loro creazione) contro una più scettica Europa del Nord. Paesi come Germania, Finlandia, Austria e Olanda hanno dichiarato di non volersi far carico del debito pubblico degli altri Stati Membri, scatenando reazioni da ogni lato dello spettro politico europeo. Come ha dichiarato l’ex Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, “lo spirito dell’Europa è in pericolo”, se i leader nazionali non troveranno un punto d’incontro sul modo di uscire dall’emergenza. Non c’è banco di prova migliore di una pandemia condivisa per testare la solidarietà europea.

Dal 28 marzo anche i russi stanno a casa. I contagi in rapida ascesa hanno costretto il Presidente Vladimir Putin a prolungare il periodo di ‘ferie pagate’, inizialmente previsto per una settimana, fino al 30 aprile. Alle singole regioni è stato affidato il potere decisionale sulle misure di contenimento per prevenire la diffusione di Covid-19. In molte hanno optato per un regime di quarantena. La più colpita è la regione di Mosca, dove il sindaco Sergei Sobyanin ha prolungato le restrizioni fino al 1 maggio.
Primi effetti sull’economia
Secondo quanto riporta Reuters, gli effetti economici del blocco imposto dall’emergenza, aggravano una situazione già difficile per l’economia russa che, assiste ad un grande calo del prezzo del petrolio, sua principale esportazione, e della valuta. Inoltre, il Moscow Times sottolinea come la mancanza di un annuncio che preveda ulteriori incentivi a sostegno dell’economia e delle imprese, già in difficoltà dopo una settimana di chiusura, crei ancora più incertezza rispetto a chi pagherà i costi del prolungamento delle restrizioni. A costituire un caso diplomatico di precario equilibrio è poi quello che riguarda la cittadina di Suifenhe, nel Nordest cinese al confine con la Russia, definita da Repubblica ‘la nuova Wuhan’ per il numero elevato di contagi importati dai cittadini cinesi di ritorno dalla Russia. Al momento infatti, il governo di Pechino ha deciso di chiudere le frontiere anche ai propri connazionali, almeno fino a quando le strutture del posto non saranno pronte ad accogliere nuovi pazienti.
Caucaso meridionale
In Azerbaijan, attualmente il Paese caucasico più colpito dall’emergenza coronavirus, vige uno ‘speciale regime di quarantena’ dal 25 marzo. Le misure restrittive, previste fino al 20 aprile, sono state intensificate a seguito del rapido aumento dei contagi. Dal 5 aprile i cittadini azeri, prima di lasciare la propria abitazione, devono notificare tramite sms un centralino del governo indicando il motivo dell’uscita ed attendere l’autorizzazione. Se la persona viene fermata priva di permesso, ne conseguono pene che vanno da multe, fino ad un mese di carcere. Inoltre, OC Media sottolinea la crescente pressione subita dall’opposizione, definita “nemica dell’Azerbaijan” dal presidente Ilham Aliyev e “l’altro virus da combattere” dal vicepresidente del partito Nuovo Azerbaijan, Ali Ahmadov. Oltre a fare i conti con l’emergenza sanitaria, l’opposizione si trova infatti a fronteggiare ripetuti arresti per ‘violazione della quarantena’.
L’Armenia, similmente colpita da Covid-19, valuta di estendere lo stato di emergenza in vigore dal 16 marzo e previsto fino al 13 aprile. Dopo circa tre settimane di totale chiusura e il numero di contagi in leggero calo, il governo prevede un prolungamento delle misure restrittive accompagnato però, da un lento ripristino di alcune attività economiche, tra cui l’agricoltura, l’estrazione mineraria e la produzione di tabacco. Recentemente il deputato Tigran Aveninya ha annunciato l’invenzione dell’app ‘Covid-19 Armenia’, attraverso cui, tramite domande sullo stato di salute, gli epidemiologi valuteranno quali siano le misure più appropriate da adottare per ogni singolo cittadino.
In Georgia, il Paese caucasico con il numero minore di contagiati, continua a far preoccupare la posizione della chiesa ortodossa. Nonostante gli sforzi di mediazione del governo, le autorità ecclesiastiche si mostrano inamovibili nel consentire l’apertura delle chiese (garantendo il distanziamento dei fedeli all’interno) e la continuazione della pratica, che prevede l’utilizzo di un cucchiaio comune per la comunione. La presidente georgiana Salome Zurabishvili, così come il primo ministro Giorgi Gakharia, hanno però invitato i fedeli a seguire la celebrazione di Pasqua (19 Aprile) da casa. Dal 31 marzo è stato indetto un coprifuoco nazionale dalle 21:00 alle 6:00 e ai cittadini è vietato uscire di casa.
Zone di conflitto nel Caucaso meridionale
Nonostante la difficoltà di accesso in questi territori abbia aiutato a rallentare il contagio e permesso lo svolgimento delle elezioni previste, sono stati registrati i primi casi di Covid-19 anche in Nagorno Karabakh ed Abcasia.
In Abcasia, le votazioni del 22 marzo hanno dichiarato vincitore, con il 56%dei voti, il leader del partito d’opposizione Aslan Bazhania. In Nagorno Karabakh, dal primo round di elezioni del 1 aprile è uscito vittorioso Arayik Harutyunyan, ex primo ministro e membro del partito Free Motherland Party, il quale ha ottenuto il 49% dei voti; un punto percentuale in meno per avere la maggioranza. Il secondo round il 14 aprile.
Caucaso settentrionale
A fare maggiormente i conti con la diffusione di Covid-19 in quest’area, è l’entità federale ‘Krasnodar Krai’, dove l’amministrazione ha proposto una tantum per le famiglie a basso reddito più colpite dall’emergenza.
Dal 29 marzo invece, anche ai ceceni è vietato lasciare le proprie abitazioni se non per comprovate necessità, quali fare la spesa, recarsi in farmacia. Secondo quanto riporta OC Media, il portavoce del parlamento ceceno Magomed Daudov ha annunciato la chiusura nazionale in un video su Instagram sottolineando che le violazioni della quarantena comportano fino a multe di 12.000 dollari.

Rispetto ai Paesi occidentali europei e nordamericani, in Oceania la situazione sembra essere molto più sotto controllo, complici sicuramente l’isolamento geografico di cui godono Australia e Nuova Zelanda, ma anche l’approccio rigorosamente scientifico, basato sull’applicazione tempestiva di misure di contenimento rispetto all’aumento dei contagiati locali e all’emanazione di provvedimenti economici finalizzati a sostenere il mercato del lavoro e rinforzare il sistema sanitario pubblico per l’emergenza. Al 12 aprile quindi, l’Australia contava poco più di 6,3 mila positivi su oltre 300 mila test eseguiti, con 59 morti. In Nuova Zelanda i casi certi/molto probabili di Covid-19 erano 1330, dei quali 4 conclusisi con decesso. Non solo, ma in entrambi gli Stati il picco di casi positivi giornalieri sarebbe già stato raggiunto, mentre i casi totali cumulativi si accingerebbero al plateau massimo e quindi alla discesa. Insomma, la situazione sembra stare rientrando. Differenti le strategie. Canberra sta portando avanti la strategia volta a massimizzare la tutela della salute pubblica nazionale. Sta minimizzando l’impatto economico con importanti ed espansivi stimoli finanziari e fiscali, mitigando e contenendo Covid-19. La vicina Wellington ha invece optato, basandosi sui risultati ottenuti a Wuhan, per la cosiddetta “Elimination”.
La scelta di Wellington
Il 23 marzo infatti, una volta raggiunti i 102 casi, la Wellington è divenuta famosa per aver adottato una strategia di “eradicazione” completa di Covid-19, attivando il livello più alto, il quarto nella scala nazionale di risposta elaborata ad hoc sin dall’inizio dell’emergenza. Non mitigazione, non adattamento dunque, bensì: totale chiusura verso i cittadini stranieri, imposizione di lunghe quarantene per i cittadini di ritorno dall’estero, distanziamento sociale e lockdown di massa molto rigidi e tracciamento sociale per infetti e contatti sociali avuti. Misure che continueranno, è stato spiegato dal Governo, fino a quando la trasmissione locale comunitaria di Covid-19 non si sarà azzerata. Quest’ultima è al 2%, in altre parole l’87% dei casi positivi registrati in Nuova Zelanda ha coinvolto persone che hanno viaggiato all’estero o sono entrate in contatto con tale categoria di individui. Questo ad esempio, perché i 20/30enni sono i più colpiti nello Stato.
Ad onore del vero, solo l’1,45 della popolazione è stato testato, per un totale di circa 7 mila test su quasi 4,9 milioni di abitanti. La spiegazione è semplice: la malattia è per lo più importata e non diffusa localmente. Ecco perché chiunque arrivi dall’estero è appunto messo in quarantena per 14 giorni, mentre al resto della popolazione è stato severamente imposto di rimanere in casa e sottoposto a test solo in caso di sintomi o contatto accertato con un positivo. Come spiega il New Zeland Medical Journal, da una parte si vuole infatti impedire l’ingresso del virus nella comunità, dall’altra ridurre al minimo ogni possibile incremento della sua trasmissione comunitaria, dovuta a casi sfuggiti ai controlli in ingresso.
Plauso alla premier
La vera rivelazione neozelandese sarebbe, però, la Prima Ministra in carica dal 2017 e leader del partito laburista, Jacinda Ardern. Non ha infatti dubbi l’accademica Suze Willson, che spiega come la leader laburista trentanovenne e laureata in Scienze della Comunicazione, sarebbe stata capace non solo di assumere con lungimiranza e massima precauzione, decisione complesse ed economicamente pesanti. Lo avrebbe fatto anche, portando le persone dalla propria parte, evitando il panico e creando invece consenso e responsabilità sociali. Avrebbe mobilitato la popolazione, presentando chiare motivazioni: impedire la trasmissione comunitaria della malattia. Creando significato collettivo: rimanere in casa per salvare vite. Infine, simpatizzando ed avvicinandosi alla popolazione, realizzando dirette spontanee su Facebook, presentandosi naturalmente ed informalmente. Questo in aggiunta alle conferenze stampa più formali, organizzate sempre alla luce del sole, con preavvisi in largo anticipo e con ampio spazio riservato alle domande dei giornalisti.
Infine, come osservato sull’AsiaTimes da John MacBeth, il governo della Arden avrebbe agito evitando corse in avanti, preparando un apposito piano d’azione su 4 livelli, con opzioni secondarie in caso di fallimento dell’obiettivo di eradicazione. In altre parole, l’accento è stato sia quello di sconfiggere Covid-19, spiegando le misure, ma anche di massimo contenimento del rischio di panico e isteria. Ad esempio, il lockdown è avvenuto solo due giorni dopo aver spiegato ed attivato progressivamente tutti i livelli di emergenza del piano d’azione ad hoc, senza cambi repentini di approccio o indecisioni, con un’escalation controllata verrebbe da dire, a differenza dei tentennamenti degli Stati occidentali. Trasparenza decisionale, empatia e coerenza, sembrano dunque essere state le cifre della convincente ed efficacie comunicazione neozelandese.










