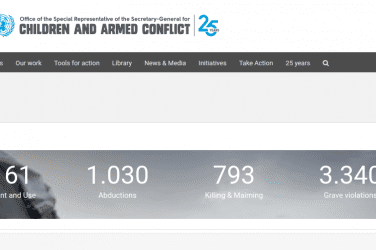Con questa nuova edizione il Piccolo Atlante di una Pandemia nato il 21 marzo scorso cresce. Con un aggiornamento che diverrà mensile e che intende fotografare non tanto l’evoluzione del virus ma quella della risposta di Paesi, Governi, Continenti, Persone. Un motivo ci spinge a farlo ed è quello di pensare al dopo.
di Raffaele Crocco
Arrivati a questo punto, l’elenco delle possibili novità si allunga. Covid-19, il coronavirus che sta bloccando le nostre vite, si sta rivelando un rivoluzionario, in grado di modificare equilibri e geografie, molto più di quanto – forse – fossimo capaci di

immaginare. Tentiamo di mettere in fila alcune cose. La prima, più importante, è che il virus ha sancito l’inizio vero e formale della nuova Guerra Fredda. Protagonisti sono Stati Uniti, potenza in declino a vedere i dati economici e militari e Cina, considerata – ma sarà vero? – in crescita esponenziale. Lo scambio di battute è feroce. Il presidente Tump accusa Pechino di essere responsabile della diffusione del virus, di averne taciuto portata ed effetti per lungo tempo, di usarlo per creare consensi e alleanze nel Mondo. Pechino parla di irresponsabilità degli Stati Uniti, incapaci di gestire la crisi e pronti a risolverla solo mostrando i muscoli e rischierando – come è avvenuto – la Flotta del Pacifico.
La cosa drammatica è che hanno ragione entrambi e la cosa certa è che entrambi i governi sanno che il Coronavirus è un ottimo strumento di “politica estera”, sotto forma di aiuti e intromissione negli affari di intere aree.
Il problema di Trump, però – ed è la seconda novità diventata evidente – è che gli Stati Uniti sono in chiara difficoltà e in evidente declino. Sono il Paese più colpito dalla pandemia, con quasi un milione e mezzo di casi a metà maggio del 2020. Il tutto, con un sistema sanitario affidato prevalentemente ai privati e quindi poco flessibile e poco capace di reggere l’urto della malattia. L’economia non va meglio: i disoccupati sono 36milioni, roba che nemmeno durante la Grande Depressione seguita al crack del ’29. Per qualche osservatore, si sono semplicemente concretizzati gli spettri che da anni si aggiravano sugli Usa: la mediocrità della classe dirigente, l’immobilismo statale e la burocrazia hanno tagliato le gambe alla potenza che ha sognato di diventare guardiana e padrona del Mondo.
La Cina, dal canto suo, ha poco di cui gioire. La sua corsa verso l’egemonia verrà rallentata – dicono gli esperti – dalla crisi economica mondiale, che farà scendere il Pil planetario del 3%. Tradotto, significa che Pechino dovrà fare i conti con materie prime bloccate per la chiusura delle frontiere, merci non prodotte, export fermo. Insomma: se il mercato non gira, la Cina si blocca. In più, l’immagine internazionale è quanto meno offuscata. La gestione dell’epidemia non ha convinto i più attenti: troppe le informazioni negate o nascoste, almeno nelle prime settimane. Non è solo Trump a chiedere che si indaghi sulla scarsa trasparenza di Pechino nella crisi.
A spingere sono anche due Paesi che il coronavirus l’hanno tenuto sotto controllo, con successo: Nuova Zelanda e Australia.
Parlando di queste due nazioni introduciamo la terza novità: l’affermarsi della multipolarità planetaria, con l’esistenza di più potenze regionali in grado di affermarsi in aree di influenza. L’Area del Pacifico si sta materializzando anche grazie ai successi di Wellington e Camberra. I due Paesi hanno tenuto sotto controllo il virus, sono intervenuti sostenendo imprese e famiglie e ora stanno rilanciando, spiegando che fra loro riprenderà la libera circolazione. Hanno rilasciato una dichiarazione congiunta parlando di “Famiglia Pacifica”, che potrà ricongiungersi progressivamente, spiegando che le altre isole del Pacifico verranno coinvolte.
Qualcuno parla della nascita di nuovo “polo” mondiale, voluto per bilanciare l’aggressività cinese e l’immobilismo degli Stati Uniti.
Sarà così? Lo vedremo nei prossimi mesi. Certo è che il Covid- 19 ha segnato il declino dei sogni di altre potenze. Quelle della Russia, ad esempio, che si infrangono nella disoccupazione incontrollabile seguita alla chiusura delle fabbriche e delle attività per il numero elevato di contagi. Proprio mentre il petrolio finiva la sua corsa al ribasso, privando Mosca di moneta di scambio sul mercato internazionale.
A Putin non resta che continuare a mostrare i muscoli dove può, tentando contemporaneamente accordi con gli altri produttori – ad esempio l’Arabia Saudita – per ristabilire un prezzo decente del greggio.
Intanto, il virus traccia la rotta tragica e ambigua dell’Unione Europa, costretta a fare i conti con l’incapacità non tanto e non solo di garantire strumenti finanziari adeguati ad affrontare la crisi e il rilancio economico, ma di intervenire per imporre i valori della democrazia agli Stati membri. Questa è la quarta novità che non ci aspettavamo: conoscevamo la debolezza dell’Unione, ma la immaginavamo salda almeno nella difesa dei valori della democrazia e dei diritti umani. Non è così.
Ad Est, Ungheria, Polonia, Slovenia grazie all’epidemia e alla “necessità di controllarla”, stanno scivolando verso il punto più basso della democrazia negli ultimi 25 anni. La valutazione è di Freedom House, Ong di Washington che ogni anno misura lo stato di salute delle democrazie nel Mondo. Tutto accade sotto gli occhi dei Paesi dell’Unione, pronto ad alzare la voce se i conti finanziari non tornano, ma muti sui temi dei diritti.
Covid-19, per altro, sta definitivamente seppellendo altre democrazie, nei Balcani, in Turchia, Asia centrale e Orientale, in America Latina. L’ultima novità portata dal virus è la “bizzarria antistorica” con cui colpisce: a subirlo di più sono stati i Paesi più avanzanti, più forti economicamente e, spesso, socialmente, quelli con le strutture sanitarie più adeguate.
In Africa, ad esempio, si è fatto relativamente sentire. Lo stesso è accaduto in molti Paesi asiatici. Le spiegazioni che vengono date sono tante e spesso fantasiose: il clima caldo che lo ucciderebbe, la popolazione molto giovane e quindi meno fragile, la mancanza di dati certi. Sarà, una spiegazione ovviamente ci deve essere. Però, fra tante fantasie, è bello immaginare – ingenuamente – che in fondo il virus sia un po’ come Robin Hood: più attento a colpire i ricchi, che i poveri.
Un lavoro di: Giuliano Battiston, Daniele Bellesi, Raffaele Crocco, Teresa Di Mauro, Lucia Frigo, Elia Gerola, Emanuele Giordana, Alice Pistolesi, Maurizio Sacchi, Luciano Scalettari, Beatrice Taddei Saltini

Nel Vicino Oriente gli scenari legati alla pandemia si intrecciano ai conflitti, che l’emergenza sanitaria non ha fermato. Di seguito una panoramica e alcune delle scelte governative prese tra aprile e maggio. Il caso iraniano viene trattato nella sezione Asia Centrale.
Turchia, il covid-19 dà il colpo di grazia alla democrazia
E’ iniziata l’11 maggio la fase 2 delle misure di contrasto al Covid-19 in Turchia. Al termine del quinto fine settimana consecutivo di coprifuoco, sono iniziate le riaperture di alcune attività, mentre il ritorno a pieno regime è previsto dal 1° giugno. Questo, nonostante nel mese di aprile la Turchia sia diventata il Paese del Vicino Oriente più colpito dal Covid-19, superando anche l’Iran. Le misure di contenimento, adottate a partire da fine marzo sono state giudicate da molti non del tutto tempestive. Il “lockdown” totale è stato adottato solo durante il weekend e diversi settori e attività lavorative non si sono fermati. Le associazioni mediche, critiche nei confronti delle cifre del Ministero della Salute, sono state escluse dalla task force e dai Consigli provinciali. Il governo ha attuato un’ulteriore stretta sull’informazione, ampliando il controllo sulle notizie relative al coronavirus ed etichettando come “fake news” quelle in contrasto con i dati governativi. Almeno sette giornalisti sono stati arrestati per aver “diffuso il panico”, mentre oltre 380 persone sarebbero oggetto di indagine per la pubblicazione di post critici sui social network. Se sul piano economico la pandemia ha fatto riemergere le fragilità della Turchia (secondo il Fondo monetario internazionale nel 2020 il Pil subirà una perdita di circa il 5%, con un tasso di disoccupazione che si attesterà attorno al 17,2%), sul piano politico si è aperto uno scontro tra il Governo e alcune municipalità governate dall’opposizione, in primis Istanbul e Ankara.
Yemen senza tregua
In peggioramento rispetto al precedente Piccolo Atlante, la situazione sanitaria nello Yemen. L’11 maggio, Il Comitato nazionale per il coronavirus ha dichiarato Aden, la sede provvisoria del Governo appoggiato dai sauditi, una città “infestata” dal Covid-19 e da altre malattie già diffuse nel Paese dopo le recenti inondazioni. Secondo l’Oms nello Yemen la malattia si sta diffondendo senza essere monitorata e ha infatti richiesto alle autorità locali di riferire i casi confermati. Le fazioni in conflitto si accusano a vicenda di mancanza di trasparenza, il governo di Aden, ad esempio, ha accusato gli houthi di nascondere un focolaio a Sanaa, città sotto il suo controllo.
Accanto al contesto sanitario la guerra continua, nonostante la tregua unilaterale della coalizione saudita sia stata prorogata fino al 26 maggio. Nel Sud del Paese persiste il conflitto tra le truppe filogovernative e i separatisti sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti che hanno annunciato l’istituzione di un autogoverno ad Aden e nella Regione meridionale. In questa fase le Nazioni Unite hanno cercato di tenere colloqui virtuali per concordare una tregua permanente, coordinare gli sforzi sanitari e riavviare i colloqui di pace.

Siria, la guerra continua
Un altro Paese in guerra e che ha smesso di “sperare” che la Pandemia possa almeno fermare il conflitto è la Siria. L’8 maggio l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha accusato le milizie di approfittare della pandemia di coronavirus per realizzare attacchi contro la popolazione civile. “Diverse parti interessate al conflitto in Siria, tra cui l’Isis, sembrano trarre vantaggio dal fatto che l’attenzione del mondo è focalizzata sulla pandemia di Covid-19 per raggrupparsi ed esercitare violenza contro la popolazione”, ha affermato Bachelet in un comunicato sottolineando di temere “una bomba a tempo che non può essere ignorata”.
Israele e Palestina
Anche in Israele e Palestina la pandemia si intreccia al conflitto. Nonostante la pandemia incida pesantemente anche su entrambi i Territori, il piano di annessione della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e della Valle del Giordano prosegue. Per discuterne il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu e il presidente della Knesset Benny Gantz il 13 maggio in uno di quei viaggi-lampo che nemmeno la pandemia ha potuto fermare. Dal punto di vista sanitario, secondo le autorità palestinesi, in Cisgiordania i lavoratori di ritorno da Israele costituiscono la principale fonte di infezione e rappresentano almeno un terzo dei casi riportati. Secondo le autorità locali, 53mila palestinesi sono finiti sotto la soglia della povertà da quando il 29 marzo il presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen ha dichiarato lo stato d’emergenza.
Libano e Giordania
Il governo del Libano ha imposto nuove restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19. Dopo aver parzialmente allentato le restrizioni il Governo ha decretato il 12 maggio una nuova chiusura totale, a causa di un rialzo improvviso della curva dei contagi, causata, secondo i media, dalla cattiva gestione dei rimpatri di libanesi dall’estero. Se dal punto di vista sanitario i dati della Giordania sono in miglioramento, da quello sociale ed economico la situazione si complica, soprattutto per i rifugiati. Nel campo di Zaatari, ad esempio, Amnesty International denuncia che l’isolamento ha impedito alle persone di svolgere qualsiasi tipo di lavoro e queste non sono più in grado di garantirsi anche i servizi minimi essenziali.
Arabia Saudita e l’austerity
La pandemia non ha risparmiato l’Arabia Saudita (il Paese con il maggior numero di infezioni in tutto il Golfo) ma a preoccupare il principe ereditario Mohammad bin Salman non sono tanto le questioni sanitarie, quanto quelle economiche. Gli effetti del lockdown e il calo del prezzo del petrolio stanno mettendo in difficoltà il Paese che ha preparato un piano di austerity che prevede l’aumento delle tasse e la riduzione della spesa pubblica. Alcuni osservatori ipotizzano che l’aumento del costo della vita potrebbe rompere il patto sociale con la popolazione e frenare la portata delle riforme avviate.
Dal punto di vista delle misure di contenimento l’Arabia Saudita ha deciso di introdurre un coprifuoco totale nel Paese in coincidenza con i cinque giorni di Eid al-Fitr, la festa musulmana che segna la fine del Ramadan, tra il 23 e il 27 maggio. La maggior parte delle regioni saudite erano già state sottoposte a un coprifuoco totale a inizio epidemia, ma il governo aveva successivamente alleggerito le misure adottate.

Fatti salvi i casi dell’Iran e e dell’Afghanistan, le due situazioni più allarmanti di una vasta regione asiatica, anche gli Stan dell’Asia Centrale si trovano nel bel mezzo della crisi da Coronavirus, nonostante le dichiarazioni di alcuni Governi che proclamano la totale assenza di contagi – e quindi del virus – nei loro Paesi. Affermazione, questa, accolta con scetticismo dalle organizzazioni sanitarie internazionali. Ali di là dell’aspetto sanitario, però, la crisi vera e reale è quella economica. Il turismo – recente scoperta di quei paesi – è letteralmente sparito. Il crollo del prezzo del petrolio ha colpito chi nella Regione esporta greggio. A calare l’asso, poi, è stata la chiusura delle frontiere, che ha fermato milioni di lavoratori stagionali, creando un blocco delle rimesse dall’estero che crea gravi problemi di bilancio ad alcuni Stati.
Inoltre problemi per quanto riguarda il flusso di denaro legato alle rimesse degli immigrati, che per alcuni paesi della regione rappresenta una percentuale importante del bilancio statale.
Di fatto – dicono gli osservatori – l’intera Regione rischia di diventare una polveriera. Le proteste montano per l’aumento dei prezzi e la scarsità delle merci disponibili. Le risposte cambiano – anche qui, il parere è degli esperti – in relazione al grado di interazione con l’economia globale e la distanza dal passato politico.
Iran
Ponte tra il mondo mediorientale e quello centroasiatico, l’Iran è stato uno dei primi Paesi fuori dalla Cina a destare serie preoccupazioni per una rapida diffusione dell’epidemia. Con 120.198 casi e 6.988 decessi (al 17 maggio 2020), la Repubblica islamica si trova al decimo posto nella classifica mondiale dei contagi. Il Paese inoltre sta affrontando una temuta “seconda ondata” di infezioni ed è la provincia sudoccidentale del Khuzestan è il nuovo focolaio:”Il Khuzestan è in una situazione critica”, ha detto il portavoce del Ministero della Sanità Kianoush Jahanpour. Nel suo ultimo rapporto il Ministero ha dichiarato che c’è una “tendenza in aumento, o l’inizio di un picco” in otto province, incluso ovviamente il Khuzestan.
Afghanistan
Con oltre 6.600 casi conclamati e 169 decessi (al 18 maggio 2020) l’Afghanistan desta forte preoccupazione non solo per la fragilità del suo sistema sanitario ma perché è un Paese ormai in guerra da quarant’anni. Una guerra che non si è fermata né per il Covid-19 né per l’accordo firmato a Doha tra Talebani e Americani. Ne è seguito una stallo durato mesi e risoltosi domenica 17 maggio con l’annuncio che il Presidente eletto Ashraf Ghani e il suo rivale elettorale Abdullah Abdullah hanno finalmente firmato un accordo di condivisione del potere: Ghani rimane al suo posto e Abdullah assume un ruolo guida nel processo di pace. Un accordo che però lascia prevedere nuovi scontri interni e una coabitazione difficile, come già in passato. Sul fronte della guerra, continuata imperterrita, va segnalata l’orribile giornata del 12 maggio, quando è stata presa d’assalto una guest house vicino a un ospedale. Ma attentato e battaglia a seguire hanno coinvolto soprattutto il nosocomio e il suo reparto materno infantile dove lavora un’equipe di Msf. Tra i morti anche dei neonati (https://www.atlanteguerre.it/kabul-battaglia-allospedale/). Nello stesso giorno un attentato uccideva altre persone che partecipavano un funerale nella provincia orientale di Nangarhar. I talebani hanno preso le distanze e dei due episodi è accusata la filiale afgana dell’autoproclamato Stato islamico.

I cinque Stan
Kazakistan (Dati al 15 maggio 2020: 4.834 CONTAGI, 31 MORTI, 1631 GUARIGIONI)
Il governo kazako si è mosso seguendo le orme dei Governi europei. Ha cioè dichiarato la chiusura di confini, scuole ed attività economiche. Contemporaneamente, ha varato una serie di iniziative economiche a supporto della popolazione, che ha comunque preso d’assalto banche ed uffici postali per recuperare i propri risparmi. La paura era che vi fosse un crack finanziario e che si potesse perdere il proprio lavoro. Sono stati, poi, fortissimi i sentimenti anticinesi: folle di dimostranti hanno fatto togliere letti da un ospedale nella città di Saryterek e costretto alla fuga dal Paese circa ventimila kazaki musulmani, di etnia cinese, nella città di Qarakemer. Dalla Cina arrivano comunque tecnologie di controllo del virus.
Kirghizistan (Dati al 15 maggio 2020: 895 CONTAGI, 12 MORTI, 637 GUARIGIONI)
E’ considerato il Paese più democratico dell’intera Asia Centrale. Tradotto: qui il Governo ha dovuto fare i conti con l’opinione pubblica, che è più libera. Così, ha apertamente ammesso le proprie difficoltà. Il Kirghizistan sta applicando il più possibile delle misure simili a quelle applicate in Europa. Quindi, c’è stata la scelta della scuola a distanza, del distanziamento e del lockdown, rafforzato dal coprifuoco notturno nelle principali città. Le autorità hanno confermato di non poter sostenere economicamente la popolazione. Così, è diventato il primo Paese a ricevere l’aiuto del Fondo Monetario Internazionale per cause legate al Covid-19. Altri aiuti sono negoziati con altre istituzioni e altri Paesi.
Tagikistan (Dati al 15 maggio 2020: 1.118 CONTAGI, 33 MORTI)
La scelta del Governo è stata semplice: negare tutto, dire che non vi sono contagi da Covid-19. Così apparentemente la vita è andata avanti come se niente fosse. Il campionato di calcio è regolarmente iniziato, anche se a porte chiuse. Sono anche state riaperte moschee e scuole. E’ stata anche organizzata una cerimonia pubblica in cui è stata elogiata l’igiene tagika: gli studenti universitari sono stati obbligati a partecipare. Nella capitale Dušanbe, vista la preoccupazione dei clienti nonostante le assicurazioni governative, uno dei caffè più frequentati, il Max Biff Burger, ha comunque distribuito gratuitamente a clienti e passanti circa diecimila mascherine di protezione. Intanto, si sta scatenando la crisi economica, dovuta alla chiusura delle frontiere con la Russia e all’inflazione, che ha iniziato a galoppare. Nessuno però protesta, almeno apparentemente: in Tagikistan l’opposizione politica non esiste. Esistono la prigione o l’esilio.
Turkmenistan (Dati al 15 maggio 2020: sconosciuti)
E’ considerato uno dei paesi più isolati e totalitari del Mondo. Stando alle autorità, è anche l’unico Paese ad avere sconfitto il Coronavirus, senza avere contagi o morti. Le autorità mondiali dubitano sia un dato reale, ma il Governo del presidente Gurbanguly Berdymukhamedov ha assegnato ad agenti in borghese il compito di sorvegliare che le persone non parlassero di questo virus. Sono state organizzate oceaniche manifestazioni sportive – ginnastica, bici e arti marziali – per dimostrare che la vita prosegue normalmente, ma la situazione già difficile, secondo gli osservatori sta diventando esplosiva. Ci sono proteste per la mancanza di generi alimentari, i negozianti non accettano i pagamenti con carte emesse in Turkmenistan ed il governo ha trasformato in moneta locale tutti i conti correnti bancari in valuta estera.
Uzbekistan (Dati al 15 maggio 2020: 2.235 CONTAGI, 10 MORTI, 1775 GUARIGIONI)
La pandemia sta regalando ruolo e forza politica nella Regione al presidente Shavkat Mirziyoyev. E’ diventato centrale nella geopolitica dell’Asia Centrale. Il presidente uzbeko sta cercando di coordinare una risposta comune regionale. Sta coordinando gli aiuti all’Afghanistan, tentando di sfruttare le vecchie strutture statali ex-sovietiche. All’intento, ha preso misure simili alle europee, ma applicandole in modo molto rigido. Il risultato è che diverse migliaia di Uzbeki sono rimasti bloccati in Turchia, per la chiusura delle frontiere uzbeke. L’alto numero dei casi di contagio nel Paese è dovuto al numero di tamponi fatti.

Il Covid-19 che si pensava in gran parte contenuto – almeno in Asia orientale – ha fatto la sua riapparizione in Cina e ha visto una recrudescenza in Corea del Sud con strascichi razzisti verso la comunità Lgbtq per via che il nuovo focolaio si è originato nei nightclub. Paesi come India e Pakistan hanno grosse difficoltà col virus pur se hanno allentato il lockdown e hanno numeri ancora relativamente bassi, mentre Paesi ultratecnologici e ricchi come Malaysia e Singapore hanno dovuto fare i conti con un segmento della popolazione abbandonato a se stesso (i lavoratori migranti) col risultato di veder riaccendersi i focolai. Dal punto di vista del rapporto virus-conflitti va invece notato che non solo il virus non ha visto accendersi speranze di tregua (con l’eccezione del Myanmar dove però la tregua vale solo… fuori dalle aree di conflitto guerreggiato!) ma la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti ha trovato nel Covid-19 un’altra buona occasione per proseguire nello scontro – finora solo commerciale o a parole – tra i due grandi imperi. Vale la pena forse di iniziare da qui.
Un Paese due nemici
Il 18 maggio la Cina ha detto di voler sostenere una revisione completa della risposta globale alla pandemia guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità. In un video-discorso, il Presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina è stata aperta e trasparente sull’epidemia e che comunque è disposta a sostenere un’indagine se condotta in modo obiettivo e imparziale. Infine si è impegnato per due miliardi di dollari di contributo in due anni contro la pandemia aggiungendo che qualsiasi vaccino sviluppato dalla Cina sarà reso bene pubblico globale. Mentre la Rpc combatte la risorgenza del virus (la cittadina di Shulan con 700mila abitanti nella provincia di Jilin è stata “chiusa” e la stessa città di di Jilin – 4 milioni di abitanti – ha parzialmente chiuso i suoi confini e tagliato i collegamenti di trasporto dopo l’emergenza di un focolaio locale), l’altro nemico resta Washington che continua ad accusare Pechino di essere la matrice del “virus cinese”, come Trump usa chiamare il Covid-19. Ma gli Stati Uniti sono duri coi cinesi non solo a parole (Trump ha risposto a Xi sostenendo che l’Oms è un burattino in mano alla Rpc). Una proposta di legge per potenziare la difesa americana nella regione Indo-Pacifico (sotto l’egida del Comando Usindopacom) è stata presentata al Congresso il 23 aprile scorso dal repubblicano Mac Thornberry a capo dell’Armed Services Committee della Camera, comitato con compiti di sorveglianza su Pentagono, servizi militari e agenzie del Dipartimento della Difesa, compresi budget e politiche. Falco texano, Thornberry presenta la “Indo-Pacific Deterrence Initiative” come il corollario orientale necessario della “European Deterrence Initiative” che, per controbilanciare l’espansionismo russo, ha già messo sul tavolo fino al 2021 oltre 26 miliardi di dollari. Adesso se ne chiedono più di sei per la sola regione indo-pacifica e per il solo 2021: per finanziare sistemi d’arma, logistica, training, intelligence etc. Venerdi 15 maggio, il cacciatorpediniere americano Rafael Peralta è stato avvistato a 116 miglia (214 chilometri km) al largo delle coste cinesi intorno alle 8 del mattino. E’ la seconda nave da guerra in un mese che si avvicina alla Cina e i nervi sono tesi.
Tecnologia e democrazia senz’anima
La città-stato di Singapore prevede di testare tutti i 323.000 lavoratori migranti che vivono in dormitori aziendali, una truppa di persone abbandonate a se stesse e confinate in grandi dormitori durante la prima emergenza e tra cui si è sviluppato un nuovo focolaio. Le autorità stanno attualmente eseguendo 3.000 test al giorno nei dormitori e intensificheranno i test al fine di completare il processo entro luglio.
Nella vicina e ricca Malaysia, circa un milione di lavoratori migranti indonesiani soffrono la fame a causa del parziale lockdown in atto nel Paese, come hanno denunciato in aprile i volontari della Nahdlatul Ulama, la più grande organizzazione islamica d’Indonesia. Un’inchiesta del South China Morning Post (Scmp) ha rivelato le condizioni drammatiche dei migranti in Malaysia che ne ospita temporaneamente 5,5 milioni, “dei quali – circa 3,3 milioni – privi di documenti”. Provengono principalmente da Indonesia, Bangladesh e Nepal. Mentre il 1 maggio la Malaysia annunciava che sarebbero state allentate le misure di lockdown, sono state arrestate centinaia di lavoratori migranti e rifugiati che vivevano in alcuni edifici della capitale. La documentazione giornalistica di questi fatti è costata alla sua autrice, Tashny Sukumaran del Scmp, un’indagine della polizia che l’ha messa sotto inchiesta ai sensi della Sezione 504 del codice penale per i suoi articoli. Democrazie molto imperfette.

Dati AlJazeera, 19 maggio 2020
Migranti nel mirino in India
Il tema virus/migranti – seppur interni – riguarda anche l’India che il 18 maggio mattina registrava la sua più grande ondata di virus con 5.242 nuovi casi di coronavirus e 157 morti nelle ultime 24 ore, numeri che hanno portato il tasso di infezione del Paese a oltre 96.000 contagiati, il più alto in Asia. Il Paese ora ha oltre 3.000 morti dovuti al virus. La nuova ondata infettiva è arrivata il giorno dopo che il governo federale ha esteso il blocco nazionale al 31 maggio, ma Delhi ha allentato al contempo alcune restrizioni per ripristinare l’attività economica e ha dato agli Stati un maggiore controllo nel decidere la natura del blocco. Le autorità stanno comunque attribuendo l’ondata di infezioni al ritorno di centinaia di migliaia di lavoratori migranti nei villaggi rurali del Paese.
Moschee e Province riottose in Pakistan
Sebbene in termini relativi il bilancio dei decessi sia ancora basso se paragonato ad altri Paesi (i morti sono poco più di 900) i casi conclamati (al 18 maggio 2020) erano oltre 42mila con numeri in ascesa, dati preoccupanti in un Paese ad elevata densità demografica con strutture sanitarie fragili e un alto tasso di povertà sia nelle aree urbane sia in quelle rurali. Il rischio, su cui molti esperti mettono in guardia, riguarda sia la scarsa capacità di test, che forse nasconde una realtà di contagi peggiore, sia una possibile nuova ondata di infezioni. La scelta di allentare il lockdown dal 9 maggio è stata segnata da polemiche che non riguardano soltanto il fatto che il Pakistan è l’unico Paese islamico del mondo dove di fatto le moschee sono rimaste aperte – unicità che ha attirato i riflettori della cronaca – e dove spesso si ignorano le più elementari regole di distanziamento fisico o addirittura vige l’assenza di disinfettanti e mascherine. I dissidi tra province e governo federale hanno creato un clima di confusione che lascia ampi spazi di manovra sia ai singoli ministri provinciali sia alle persone che non hanno indicazioni troppo chiare su cosa e come fare. Le province di Punjab e Sindh, per esempio, prima del 9 maggio, già avevano chiarito l’intenzione di estendere ancora le restrizioni “liberate” invece da Islamabad. Lunedi 18 maggio la Corte suprema pachistana ha dichiarato che il coronavirus “non è una pandemia in Pakistan”, ordinando al governo di riaprire le imprese sette giorni su sette e costringendo un governo provinciale a riaprire i centri commerciali. Il governo federale ha accolto la sentenza con favore.
Il mistero della “cintura” e dell’Asia del Sud
A riguardo, ci sono ancora una serie di punti su cui riflettere. In particolare il fatto che i Paesi dell’Asia meridionale (dal Bangladesh al Pakistan, passando per India e Sri Lanka) – poveri, sovrappopolati e con sistemi sanitari inadeguati – hanno numeri incredibilmente bassi se raffrontati a quelli della pandemia in Europa. Una tabella pubblicata da Al Jazeera che vi ha dedicato un servizio (nell’immagine prima del paragrafo) mostra la situazione in Asia del Sud ma senza riuscire a rispondere alla domanda: come mai? Lo stesso avviene nei Paesi della “cintura” Sud della Cina ossia nelle nazioni che confinano con la Rpc: Myanmar, Cambogia, Vietnam e Laos. Pochissimi casi e, a parte il Myanmar con sei vittime, nessun decesso. Qui forse si può tentare qualche ipotesi: la prima assai comune è che i test sono pochi e i governi nascondono i dati (ciò varrebbe anche per l’Asia del Sud) oppure che, trattandosi di regimi autoritari, è obbligo rispondere sempre signorsi, il che è vero (come in Cina) ma non basta. Ci sono almeno tre elementi da considerare: la rapidità con cui (a parte la Cambogia) i “Paesi della cintura” hanno reagito appena a conoscenza del Coronavirus con la chiusura delle frontiere con la Cina e misure di rimpatrio per i cinesi ospiti. Poi misure di lockdown rigidissimo appena veniva trovato il primo caso seguite da altrettanta trasparenza (far circolare età, sesso e residenza del contagiato). Infine misure di contenimento che, nonostante i bassissimi numeri, sono state poco allentate (attualmente sono assai più dure in Myanmar che non in Lombardia). E ancora una cultura comunitaria forte per cui la salute è, per il villaggio, un bene comune di tutti. Infine, probabilmente, i buoni consigli della Cina, che non si può permettere di avere la cintura come nemica visto che è l’inizio della sua Nuova Via della Seta. Non essendo in grado di fare come Singapore o Bangkok – attrezzatissime con ospedali e tecnologia – e non essendo in grado di fare come Taiwan, Giappone e Sud Corea (tracciatura dei casi), questi Paesi si sono affidati… a buon senso e disciplina. Risultato: sei vittime su qualcosa come poco meno di 200 milioni di anime nei quattro Paesi. Non è poco.
|
Paesi |
Popolazione |
Casi conclamati |
Decessi |
|
Vietnam |
96 mln |
324 |
– |
|
Cambogia |
16 mln |
122 |
– |
|
Laos |
7 mln |
19 |
– |
|
Myanmar |
54 |
187 |
6 |
|
Totale |
173 |
652 |
6 |

In tutto il Continente africano i casi registrati finora di Covid-19 equivalgono ai circa lo stesso numero dei nuovi casi di Stati Uniti, Russia e Brasile in due soli giorni. Soltanto 17 Paesi hanno più di mille casi; 11 ne hanno meno di 100. Il contagio, mentre chiudiamo il dossier, ha superato di poco i 61 mila casi accertati (su oltre 4,5 milioni nel mondo), anche se oramai il virus ha toccato praticamente tutti i Paesi, 52 su 54.
Guardando una mappa del Continente, alcuni elementi balzano all’occhio: i Paesi più colpiti – Marocco, Algeria, Egitto, Tunisia, Sudafrica (l’unico che ha superato i 15 mila casi totali) – sono alcuni degli Stati affacciati sul Mediterraneo e, al polo opposto, il più meridionale, ossia quelli col clima più temperato, con variazioni stagionali di temperatura. Alcuni Paesi che contano alcune centinaia di casi (da alcune centinaia di casi e meno di 3.000) si trovano nell’Africa centrale (Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Niger, Camerun, Senegal, Costa d’Avorio). Nel resto del Continente si tratta di numeri esigui, perlomeno se paragonati a quelli del Nord del mondo.
Va anche detto che solo in alcuni Stati la comparsa del virus è recente (in qualche caso anche solo da pochi giorni), mentre nella maggioranza le prime segnalazioni risalgono ad alcune settimane fa, o anche a oltre un mese. Naturalmente, questa progressione lenta non può essere attribuita a una migliore capacità delle nazioni africane di contenere il contagio rispetto a realtà come quelle europee, o agli Stati Uniti, oppure alla stessa Cina, che ha avuto la prima esplosione della pandemia.
Occorre anche sottolineare, osservando le linee di crescita della diffusione del virus, che quelle dei Paesi con pochi casi sembrano avere una crescita abbastanza diversa da quelle di aree che stanno vivendo le maggiori emergenze: si tratta, almeno finora, di un andamento lineare, o talvolta “a gradini”, non esponenziale com’è avvenuto in Cina e poi in Europa, negli Stati Uniti, oppure in Russia e Brasile. Tuttavia, i Paesi africani più colpiti, quelli che oggi sono vicini o al di sopra delle mille unità, nelle ultime settimane mostrano una linea di crescita che assomiglia a quelle europee, cinese o americana, cioè più vicina alla crescita esponenziale, fatte salve le differenze di scala (parliamo di centinaia non di migliaia).
Un continente molte domande
Un primo quesito: dove i casi sono pochi dipende da quanto si sta monitorando? In altre parole, così come in Italia oggi si attribuisce l’elevato numero di positivi di questi giorni al fatto che è fortemente cresciuto il numero di tamponi effettuato sulla popolazione, può essere che il numero esiguo di positivi in tanti Paesi africani sia dovuto in realtà a un’assenza o scarsità di monitoraggio? Verrebbe da rispondere di no, perché se da un lato è certo che la totalità dei sistemi sanitari africani è meno strutturata di quelli europei, è altrettanto vero che in tutti gli Stati del Continente nero sono comunque presenti, soprattutto nelle capitali e nelle grandi città, presidi medico-sanitari sia locali sia di organizzazioni umanitarie internazionali in grado di rilevare, se non altro per campione, i focolai di contagio.
Si potrebbe obiettare che il maggior numero di casi è stato individuato in Paesi che hanno una sanità più strutturata. Ma anche questo è vero fino a un certo punto: Ruanda, Kenya, Nigeria, Senegal non presentano realtà medico-sanitarie così diverse da quelle di Marocco, Tunisia o Sudafrica.
Inoltre, i rapporti intrattenuti fra la Cina e moltissime delle nazioni africane sono intensi, sia a livello di relazioni commerciali sia di spostamenti di persone da e per il Paese asiatico. Quindi, ammesso che, ad esempio, l’Italia abbia “importato” l’epidemia dalla Cina, per ragioni analoghe diversi Stati africani avrebbero dovuto manifestare i primi casi più o meno alla stessa epoca. Insomma, detto tutto questo, sembra che in ogni caso il Covid-19 abbia in Africa un andamento diffusivo diverso da quello a cui abbiamo assistito in Cina, Corea del Sud, Europa o Stati Uniti.
Questo non significa che il coronavirus non possa diventare una catastrofe per l’Africa. Il guaio è che lo può diventare a prescindere dalla dimensione della pandemia.
Resta il fatto che finora il virus ha avuto una “vita” diversa rispetto a tutta la fascia Nord del pianeta. Sono state avanzate delle ipotesi, su questo. La prima. I climi caldi o molto caldi rendono meno aggressivo il coronavirus. Chi ha avanzato questa teoria – che l’Oms mette in dubbio – lo ha fatto rilevando che si è registrata una minore diffusione del virus nelle zone più calde e umide all’interno degli stessi Paesi duramente colpiti (anche i dati della pandemia in Sud Italia lo confermerebbero).
L’altra ipotesi è che tra le zone più e meno colpite del mondo c’è una fondamentale differenza: l’età media della popolazione: l’Europa e il Nord America sono regioni a lunghissima speranza di vita. Viceversa, in Africa il 60% del miliardo e 300 milioni di abitanti del Continente è sotto i 25 anni. Quello che non sappiamo – perché finora tutti i Paesi con maggiore contagio hanno reagito al virus solo in emergenza e quindi con mezzi insufficienti a monitorare in modo massivo la popolazione – è quanti sono gli asintomatici (ossia contagiati senza alcun sintomo che vada al di là di un raffreddore) e quanti i paucisintomatici (ossia con sintomi paragonabili a una influenza neanche tanto forte). L’ipotesi quindi è che in Africa il virus possa essere molto, ma molto più presente di quanto sia stato rilevato, ma con nulli o pochi sintomi. Se così fosse, si potrebbe ipotizzare una sorta di singolare “immunità di gregge” che si crea per via dell’età media molto bassa: il Covid-19 non trova con facilità ospiti “accoglienti” perché in maggioranza sono bambini o giovani.
Sotto questo profilo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che la pandemia possa diffondersi più lentamente in questo continente rispetto alle altre parti del mondo, ma probabilmente resterà nella regione più a lungo, forse addirittura per diversi anni.

Cosa dice l’Oms
Gli esperti dell’Oms peraltro danno anche altri dati – stimati, naturalmente – secondo i quali quasi una persona su quattro (22%) del miliardo di africani potrebbe contrarre l’infezione nei primi 12 mesi dall’esplosione della pandemia e, quindi, un numero compreso fra 37 e 44 milioni di persone in cifre assolute. Ammesso che i contagiati manifestassero sintomi analoghi a quelli dei Paesi più colpiti, i ricoverati in ospedale potrebbero essere 4,6-5,5 milioni, e le vittime 150.000-190.000. Se così fosse è chiaro che le strutture sanitarie fragili dei Paesi africani ne verrebbero totalmente travolte.
Si diceva, però, che la pandemia, per l’Africa, potrebbe diventare disastrosa comunque, anche senza una crescita forte dei contagi. In parte perché il Continente, ancora una volta, pagherebbe il prezzo dei guai altrui. E questo, in realtà, sta già accadendo: le esportazioni di materie prime come pure le importazioni di prodotti lavorati e di generi alimentari sta subendo un forte rallentamento, dovuto naturalmente alle emergenze del Nord del mondo.
Un secondo forte rischio è la diminuzione degli aiuti internazionali e umanitari provocato dalle emergenze che vivono i Paesi ricchi e alla crisi economica che si prospetta.
Un terzo problema è la probabile riduzione delle rimesse dei migranti, che – ricordiamolo – costituiscono la prima voce di “aiuto” ai Paesi africani, superiore a quella del sostegno internazionale. Anche sotto questo profilo, la crisi pesantissima che si prefigura nelle economie forti sarà pagata pesantemente dalle fasce di popolazione più vulnerabile, fra cui c’è la gran parte dei lavoratori stranieri affluiti in Europa e negli Stati Uniti.
Perciò, in definitiva, se anche fosse vero che l’Africa sarà colpita in modo molto meno duro dalla pandemia, pagherà un prezzo altissimo, tanto che le previsioni della Banca Mondiale indicano che per la prima volta da 25 anni a questa parte il Continente andrà in recessione, passando da una crescita del 2,4% del 2019, a un calo compreso fra il 2,1 e il 5,1 nel 2020.
Scenari possibili
Ovviamente, uno scenario ben diverso si prospetta se, pur con una evoluzione più lenta, il virus esploderà comunque con numeri di contagio rilevanti. Per cogliere la dimensione del disastro basti qualche dato: a fronte del 16% della popolazione globale del pianeta, l’Africa ha l’1% delle risorse dedicate alla sanità. E se l’Italia ha 41 medici ogni 10 mila abitanti, l’Africa ne ha soltanto 2, così come ha, secondo l’Oms, 5 posti letto di terapia intensiva, in media, per milione di abitanti. In Togo, per fare qualche esempio, ci sono soltanto 4 respiratori, in Burkina Faso 15 posti in terapia intensiva.
Sembra che, comunque vada, sia saggio il consiglio dato ai governi del Continente nero dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Il miglior consiglio da dare all’Africa», ha detto, «è quello di prepararsi al peggio e prepararsi sin da oggi». Già adesso gli analisti parlano di almeno 20 milioni di posti di lavoro che saranno perduti.
Cosa fanno le élite africane
Lo stanno facendo, le leadership africane? Perlopiù sì, per ciò che possono. La maggioranza dei Governi ha emanato provvedimenti di distanziamento sociale e restrittivi alla circolazione delle persone. Spesso però in modo non coordinato. Se il Ruanda e il Sudafrica hanno posto norme abbastanza simili a quelle italiane e la Tunisia ha persino riesumato alcuni robottini su ruote per “stanare” chi avesse violato il lockdown totale, in Kenya il presidente Uhuru Kenyatta ha decretato il 6 aprile scorso 21 giorni di chiusura totale della città e dell’hinterland di Nairobi e il coprifuoco serale, mentre il Sud Sudan (che ha ad oggi 282 casi e 4 vittime) ha stabilito sei settimane di coprifuoco notturno e chiusura totale di aeroporti, scuole, moschee e chiese. Il Senegal ha chiuso scuole, università e ha soppresso le manifestazioni religiose, la Nigeria ha messo in rigida quarantena la capitale federale Abuja e la città più popolosa, Lagos, che conta oltre 20 milioni di abitanti. La RD Congo ha vietato assembramenti al di sopra delle 20 persone. In 20 Paesi sono state chiuse le scuole.
Anche in questa circostanza, il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali (Premio Nobel per la Pace 2019) ha dimostrato una levatura diversa: oltre ad avviare da subito un tavolo di coordinamento con una decina di altri presidenti africani, si è rivolto al G-20 con un piano in tre punti: la creazione di un fondo globale per l’Africa con 150 miliardi di dollari per fronteggiare l’emergenza, uno specifico pacchetto di interventi sui sistemi medico-sanitari, infine una sostanziale riduzione o ristrutturazione di quel debito estero che appesantisce tanti degli Stati del continente. Il G-20, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, ha accolto l’ipotesi di sospensione del debito.
Un’ultima annotazione. Le misure decise nei Paesi del Nord del mondo possono essere efficaci in Africa? La risposta, sintetica e puntuale, l’ha data il ginecologo congolese Denis Mukwege (anche lui Premio Nobel, nel 2018): «Temo l’ecatombe», ha detto, «perché non abbiamo i mezzi per combattere il virus e perché gli africani sono costretti a uscire di casa per procurarsi il cibo. Nessun confinamento è dunque possibile, e il Covid-19 si sta diffondendo a velocità da primato». Il “distanziamento sociale” nel Continente è una chimera. Metterlo in atto per la maggioranza degli africani significherebbe fame entro 72 ore.

Con più di 1,4 mln di casi a metà maggio e superate le 85 mila morti, gli Stati Uniti d’America rimangono in testa alle classifiche epidemiologiche relative alla Pandemia in corso. Covid19 sta inoltre mettendo in ginocchio anche l’economia a stelle strisce: in circa due mesi i disoccupati sono infatti diventati più di 36 milioni.
Gli Usa sono uno “Stato Fallito” ha scritto amaro George Packer sul The Atlantic, spiegando che le morti per Covid19, la mala gestione di Washington così come il fatto che il 10% della popolazione americana sia ora disoccupata siano frutto delle “malattie croniche” degli Usa. Una “classe politica corrotta, una burocrazia sclerotizzata, un’economia senza cuore, un pubblico distratto e diviso”. Dal Time, viene inoltre sottolineato come ormai le vittime siano 28 volte quelle dell’Undici Settembre, più dei morti americani nella guerra del Vietnam e un quarto di quelle globali per Covid19. Il Paese è sotto shock, Trump ha definito la situazione come un vero e proprio “attacco all’America”, autoproclamandosi un “Presidente in tempi di guerra”. La realtà è che le ripercussioni di Covid-19 sono state esacerbate dalla malagestione che il Presidente ha esercitato e abbiamo raccontato sin dall’inizio.
Il dilemma tra far ripartire l’economia e tutelare la salute dei cittadini sembra essere stato risolto in favore della “resilienza economica”: una trentina di Stati stanno infatti allentando le misure di distanziamento sociale, nonostante gli esperti siano contrari. Tutelare le vite è già costato 48 miliardi in termini di sussidi per la disoccupazione e il Nyt ha spiegato che per molti “l’helicopter money”, ovvero i dollari che lo Stato ha iniettato direttamente nei conti correnti di molti disoccupati, sarebbero ammontati addirittura a più dello stipendio percepito normalmente. La situazione non può però rimanere così a lungo secondo molti, in particolare repubblicani. Circa 30 Stati stanno quindi allentando le misure di controllo sociale, anche se i criteri suggeriti per riaprire in sicurezza dalla stessa Casa Bianca non sono stati ancora raggiunti. Da una parte non si è assistito ad una diminuzione dei nuovi contagiati su base giornaliera per almeno due settimane, dall’altra nemmeno la percentuale dei test positivi sul totale dei realizzati quotidianamente starebbe diminuendo. Per l’infettivologo Fauci e l’epidemiologo Powers quindi, se si dovesse riaprire in maniera troppo precoce e avventata, nuovi focolai così come la prosecuzione dell’epidemia sono molto probabili. Trump ha però accusato Fauci di essere esagerato, esprimendo la volontà di riaprire molte attività produttive e le scuole al più presto.
Per il Time, che lo ha anche scritto in copertina: “C’è un modo corretto per riaprire l’America, quello imboccato non lo è”. E’ vero: ormai anche negli Usa al giorno 1 persona su 1000 viene testata per Covid19, e ormai 30 individui ogni 1000 sono state sottoposti al test. Tutto sarebbe però arrivato troppo tardi, e c’è già chi denuncia che lo stesso potrebbe avvenire con la produzione e distribuzione di un futuro eventuale vaccino. Questa è almeno l’opinione che il dottor Rick Bright, ex Direttore dell’Autorità Biomedica per la Ricerca e lo Sviluppo Avanzato, ridimensionato per aver criticato Trump e non essersi allineato alla sua linea politica, ha condiviso in un’audizione fiume di 4 ore al Congresso. Bright, ha di fatto accusato l’Amministrazione di immobilismo e di aver deliberatamente ignorato i consigli dello staff scientifico, soprattutto nelle prime fasi dell’epidemia.
Caos socio-politico e polarizzazione dello spettro politico che caratterizzano l’odierno tessuto sociale Usa sono particolarmente evidenti in 3 “swing States”, attualmente governati da maggioranze democratiche ma il cui esito elettorale incerto sarà probabilmente cruciale per determinare il 3 novembre chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Così, come vi avevamo riportato, in Michigan il Campidoglio è stato occupato da uomini armati e privi di mascherina. In Pennsylvania invece avvocati repubblicani hanno invitato gli esercenti ad ignorare l’ordine di chiusura delle attività economiche non essenziali, il tutto mentre Trump visitava uno stabilimento medico nello Stato. Invece in Wisconsin, è stata la Corte Suprema locale a maggioranza repubblicana ad aver sovvertito l’ordine di lockdown emanato dal Governatore democratico locale Evers.

Presidente Trump e Vice Pence, conferenza stampa del 22 Aprile. (Official White House Photo by D. Myles Cullen)
Orrore, derisione e pietà: un editoriale del Guardian li descrive come i sentimenti provati dai Governi e dagli analisti del resto del mondo dinnanzi all’operato di Trump. Un Presidente in affanno, privo di credibilità perché smentito dai dati; privo di abilità persuasiva perché privo di alleati credibili; incapace di solidità argomentativa, in quanto criticato persino dal proprio staff medico. Il populismo e la post-verità dell’estrema destra populista, si legge, “semplicemente non funzionano per battere Covid-19”. L’attuale Pandemia sta però solo catalizzando quello che Trump aveva già inaugurato con la sua elezione, ovvero il ripiegamento Usa in un isolazionismo “American first” che sta costando a Washington la perdita della propria leadership mondiale. Il Presidente repubblicano ha accusato l’Oms di essere asservito alla Cina ed anziché contribuire a migliorare l’agenzia satellite dell’universo Onu che gli Usa hanno di fatto fondato, ha deciso di tirarsene gradualmente fuori, annunciando un taglio ai fondi annuali, dei quali è stato fino ad ora il primo Paese contribuente. Inoltre, in maniera nemmeno velata si è inimicato ulteriormente gli altri alleati occidentali, rifiutandosi di aderire ad una campagna comune di finanziamenti per la ricerca di un vaccino. Gli Usa di Trump sarebbero passati “da capo architetto a capo incendiario”, tanto che alcuni Stati come Australia e Nuova Zelanda, storici alleati Usa, hanno deciso di fare da sé.
Una nuova “Guerra Fredda” è invece quella che per Jeet Heer sarebbe ormai in corso tra Washington e Pechino. La causa maggiore? La disperazione di Trump, che incapace di prevedere, gestire e decidere, ora starebbe scaricando le proprie colpe sul rivale geopolitico per eccellenza. Su DefenseOne, l’accademica Luy Jinghuia sottolinea come ormai le relazioni commerciali, le mosse militari nel Pacifico meridionale e occidentale, così come i toni e i contenuti del dialogo tra i due Paesi che ogni settimana si accusano reciprocamente, testimonino tutti una dinamica che i realisti definirebbero di tit-for-tat. In altre parole di continuo, costante e apparentemente inestricabile gioco di accuse-controaccuse e mosse-contromosse reciproche, proporzionali ma avversarie e deleterie per la gestione della crisi: la spirale conflittuale è quindi evidente.
Il professore di diplomazia Christopher Hill su Foreign Affairs argomenta invece il perché il problema sia soprattutto statunitense. La Cina è sempre stata trattata da Washington come una potenza regionale egemone: le sono stati concessi spazio e capacità di influenza in Asia, ma limitandone le mire egemoni globali. Ritirarsi dal sistema multilaterale di organizzazioni come l’Oms e dai tavoli di cooperazione, rifiutandosi di coinvolgere Pechino, smorzando i toni e coinvolgendola in dialoghi e iniziative di coordinamento non può essere la strada corretta per imbrigliarne e limitarne l’ascesa non solo economica, ma anche politica del Dragone. Dare “picche non è una politica” chiosa, è necessario il confronto. Secondo la già citata Luy Jinghuia, sarebbe quindi necessario intraprendere una strada di de-escalation i cui elementi vengono chiaramente ri-pescati dalla teoria costruttivista che spiega la fine della Guerra Fredda: aumentare la frequenza del dialogo costruttivo e non propagandistico; confronto continuo sulla natura e la gestione delle crisi per favorire la distensione; narrazione reciproca meno avversariale, così da creare fiducia e rispetto reciproci.
“Chiedetelo alla Cina”, ha però replicato Trump ad una giornalista che gli ha chiesto perché continuasse ad interpretare la gestione della crisi Covid19 come una gara globale tra Stati. Probabilmente la risposta più sincera e vera degli ultimi due mesi. Definire Covid19 come il “virus cinese”, continuare senza prove a paventarne un’origine artificiale nei laboratori di Wuhan, così come ripetere che la Cina è la causa delle difficoltà Usa è semplicemente una tecnica di distrazione di massa, una tecnica di post-verità che mira a dipingere una realtà non vera, non fondata sui fatti, come una realtà affermata. Ha funzionato nel 2016 e ha permesso a Trump di essere eletto, secondo i sondaggi potrebbe rifunzionare questo 3 novembre, ma sta fallendo a livello internazionale. E’ vero, bisogna chiedere alla Cina perché Trump continui ad annaspare, la risposta probabilmente è che non è pronto, non è preparato a condurre la politica estera del grande gioco geopolitico contemporaneo, dove ormai tutto concorre all’equazione della distribuzione del potere. Non c’è più solo l’hard power fatto (semplificando e contestualizzando) di accordi di controllo degli armamenti nucleari e posizionamenti strategici navali; ma c’è anche e soprattutto il soft power, e Covid-19 lo ha ricordato a tutti: cybersecurity per influenzare le masse interconnesse in Internet, interdipendenza economica e credibilità politico-diplomatica degli apparati governativi. Con Trump gli Usa peccano nella gestione del secondo che pure potrebbero avere, se solo decidessero di esercitarlo. La pietà è quindi rivolta all’incapacità di gestire la crisi, l’orrore invece alle vittime che in termini di morti, malati e disoccupati tutto questo sta causando.
Rispetto al vicino americano, il numero dei nuovi contagi in Canada sembra irrisorio: oltre 5 mila morti dall’inizio della pandemia, per quanto tragiche, sembrano uno scenario roseo rispetto alle 3mila morti giornaliere negli Usa a inizio maggio, per un totale dal mese di marzo di oltre 80 mila decessi. Risultati drasticamente diversi, frutto di una serie di fattori. Tra esse, un sistema sanitario più nazionalizzato di quello statunitense, che si affida alle assicurazioni private solo per il 30%. Ma alla qualità del sistema sanitario nazionale si è affiancata da subito una strategia rigorosa, che ha portato a oltre 30 mila test nel Paese, frontiere chiuse con agli Usa e arrivi controllatissimi negli aeroporti; inoltre, il lockdown canadese ha resistito alle proteste contro gli effetti economici delle chiusure forzate, anche grazie ai fondi tempestivamente stanziati dal governo nei confronti di imprese, famiglie, studenti e disoccupati. Ora il governo centrale di Ottawa e i governi delle province stanno coordinando le riaperture sempre all’insegna della cautela, imposta dal premier Trudeau ma ribadita anche dai governatori federali: il “Grande Nord” riaprirà in maniera frammentata, con buona parte delle province ancora recalcitrante all’idea di permettere i viaggi tra un territorio e l’altro.
Eppure, il Canada condivide con gli Stati Uniti altri aspetti cruciali della pandemia: CSIS, l’agenzia di intelligence canadese, ha avvisato il Paese (come è avvenuto anche negli States) che la proprietà intellettuale, in particolare nel campo medico, al momento è un “obiettivo sensibile e di grande valore” per lo spionaggio internazionale. Aumenta il rischio di cyber attacchi ad istituti di ricerca, università e aziende che lavorano per trovare cure contro il Covid-19, dopo che già a marzo l’agenzia aveva avvisato di potenziali cyber attacchi – entrambe le volte, non sono stati fatti nomi o mosse accuse a Paesi precisi, strategia diametralmente opposta a quella di Washington. L’allerta però resta alta, e l’attenzione è rivolta ad attori internazionali ben precisi.

Nel grande e composito mosaico dei Paesi dell’America latina il contagio da Covid19 si va estendendo, senza risparmiare alcuna delle nazioni che ne fanno parte. Al di là delle grandi differenze che marcano Messico e Brasile, Argentina, e Perù, il Centroamerica, il Cile e la Colombia, si possono però individuare alcune tendenze e fenomeni comuni, che possono aiutare a farsi un quadro della situazione attuale che qui riassumiamo in 5 punti. Infine daremo uno sguardo ai tre Paesi più importanti del continente: Messico, Brasile e Argentina.
I cinque pilastri del Covid
1 – La diffusione drammatica nei grandi centri urbani, in quest’immensa area in generale non sovrappopolata, ma che vede alcune delle più grandi megalopoli del Pianeta, come Città del Messico, San Paolo del Brasile, Buenos Aires, Lima e Bogotà;
2 – Un virus che colpisce soprattutto le fasce più povere della popolazione, che vivono nell’informalità, sia per quanto riguarda il lavoro, che per quanto riguarda la casa e l’accesso ai servizi di base: acqua potabile, fognature, servizi sanitari, educazione.
3 – La smentita delle teorie per cui il caldo rappresenterebbe un fattore di indebolimento della potenzialità di contagio del virus. Un caso emblematico è quello di Manaus, in Brasile, dove il contagio ha uno dei suoi focolai più letali, in piena Amazzonia.
4 – La messa a nudo della fragilità e iniquità del modello di sviluppo neoliberista, che con la privatizzazione dei servizi di base, e l’accentuarsi dell’ineguaglianza ha distrutto o impedito la crescita di una rete pubblica di garanzie e diritti comuni, che si traduce oggi in una quasi assoluta incapacità di riposta alla crisi sanitaria, economica e sociale scatenata dal contagio.
5 – Conseguenza diretta della mancanza di una rete pubblica di servizi è l’impossibilità di avere dati credibili sul numero di contagiati e di decessi, dato che la gran parte della popolazione vive ai margini o al di fuori di ogni controllo se assistenza sanitaria e sociale
Messico
Anche il Messico sta affrontando un aumento del bilancio delle vittime – e mette in discussione la sua risposta alla pandemia mentre il governo spinge a riaprire l’economia. Le indagini del New York Times, del Wall Street Journal e de El País fanno capire che il governo di Andrés Manuel López Obrador sta sottostimando gravemente sia i casi che i decessi. Secondo i dati ufficiali presentati martedì 12 maggio per esempio, 937 persone a Città del Messico sono decedute dopo essere risultate positive per Covid19, a cui si aggiungono altri 378 decessi nell’ area metropolitana della capitale. Ma il numero giornaliero di cremazioni dall’inizio della crisi nella stessa area è molto più alto della media degli ultimi anni. Nel mese di maggio, tra il 2014 e il 2018, questa cifra è stata di 374 morti al giorno. Secondo un’inchiesta di Sky News, “Una città immersa nella negazione”, https://news.sky.com/story/a-, si stanno verificando almeno 226 decessi in più “ogni giorno dall’inizio di maggio” nell’area di Città del Messico, e che la maggior parte sono stati probabilmente causati dal coronavirus. L’organizzazione giornalistica ha affermato che le fonti del crematorio hanno riferito che dall’80% al 90% dei corpi che si stanno attualmente cremando sono vittime del Covid19. Supponendo che l’80% delle morti in eccesso trattate dai crematori siano dovute al coronavirus, l’analisi di Sky fa capire che la cifra ufficiale del governo è solo il 19 percento del numero reale dei morti per Covid19 nella capitale messicana. La cifra effettiva è quindi circa cinque volte superiore a quanto indicato nel sito web del Dipartimento della Sanità. Eminenti specialisti del settore privato hanno dichiarato all’emittente di aver avvertito il governo dell’imminente epidemia a gennaio, ottenendo come risposta che non c’era nulla che si potesse fare.
La mancata pubblicazione di tassi di mortalità credibili sembra essere parte di una strategia di contenimento del panico nelle parti più povere di Città del Messico più colpite. Ma mentre le morti totali legate al coronavirus hanno superato quota 5.000, “l’incapacità del governo di pubblicare i numeri reali] pone il Messico in una situazione di negazione della pandemia”,secondo il corrispondente di Sky News Stuart Ramsay L’innalzarsi della curva della mortalità sembra destinata a durare, il servizio sanitario non può farvi fronte, e il distanziamento sociale viene in gran parte ignorato a Città del Messico. Con queste premesse, l’effetto della pandemia di coronavirus su Città del Messico potrebbe rivelarsi catastrofico.
Il Messico è stato messo sotto pressione dai funzionari statunitensi perché riaprissero le attività produttive e commerciali, in particolare gli impianti automobilistici e le fabbriche di prodotti di esportazione lungo il confine settentrionale. E probabilmente dipende da questo se il Presidente Lopez Obrador, malgrado i numeri allarmanti del contagio, ha rivendicato la vittoria – mentre il suo Governo rivelava i piani per rilanciare l’ economia in crisi – dicendo: “La campagna per l’allontanamento sicuro ci ha portato a un appiattimento della curva”. L’edilizia, l’industria mineraria e la produzione di automobili saranno dichiarate attività “essenziali” e hanno ripreso le operazioni il 18 maggio. Le scuole e le imprese nelle aree con un basso numero di casi Covid-19 – soprannominati “Comuni della speranza” – inizieranno a riaprire con il resto del Paese il 1 ° giugno. Secondo l’agenzia di sviluppo sociale (Coneval) del Governo federale, la crisi economica indotta dal coronavirus potrebbe spingere altri 10,7 milioni di persone in stato di povertà. Il numero totale di persone in condizioni di povertà potrebbe quindi aumentare fino a investire il 45,8 percento della popolazione, con un aumento fino al 18 percento in più rispetto ai 60 milioni già segnalati da Coneval nel 2019.
Le persone che vivono nelle grandi aree urbane rischiano di essere maggiormente colpite dalla recessione economica rispetto a quelle nelle aree rurali e nelle piccole città così come le donne potrebbero essere più vulnerabili degli uomini agli effetti economici negativi della pandemia. Con una profonda recessione vista come inevitabile, l’agenzia ha affermato che il Governo deve ampliare e rafforzare la sua capacità di aiutare le persone in situazioni di povertà. Il funzionamento dei programmi sociali dovrebbe essere migliorato per garantire che raggiungano le persone che li richiedono.

Brasile
La seconda settimana di maggio, il Brasile ha visto aggravarsi la situazione del contagio, e ha iniziato a registrare più di 600 nuovi decessi al giorno. Ora, il numero ufficiale di decessi cresce più in Brasile che in Europa. Ad esempio, in Brasile, questo aumento è stato del 6,5 percento al giorno il venerdì 8 maggio. In un giorno equivalente dell’epidemia in Italia, il numero delle vittime è aumentato del 3,1 percento. Quindi, più del doppio dell’incremento giornaliero. Due settimane fa, i ritmi dei due Paesi erano simili. Lo stesso 8 maggio, il tasso di crescita del contagio in Francia è stato del 2,5 percento, nel Regno Unito, del 3 percento, negli Stati Uniti, l’8,2. Nello stato di San Paolo, 4,6 percento. E, come abbiamo detto, sono numeri da tarare a un forte rialzo, data la gran quantità di casi che sfugge, in proporzione alla minore capacità di rilevazione collegata alla minore efficienza del servizio pubblico. Come in Messico, anche qui, grazie alla impostazione data da Jair Bolsonaro alla lotta alla pandemia, si è cominciata la fase di riapertura. Come nel caso della più grande megalopoli brasiliana.
I trasporti pubblici a San Paolo hanno registrato autobus, treni e metropolitane affollati la mattina del primo giorno di una più rigorosa rotazione dei veicoli municipali, una misura progettata per scoraggiare le persone dal viaggio e per ridurre il tasso di diffusione di Covid19. La città ha riferito di aver schierato 1.000 autobus municipali aggiuntivi e altri 600 in riserva, da attivare se necessario. In alcuni casi, il rinforzo ha funzionato, senza sovraffollamento, ma in altri gli autobus erano ancora pieni, in particolare la mattina presto. Secondo studi internazionali, dopo gli ambienti ospedalieri, il trasporto pubblico è il luogo dove il contagio si diffonde più rapidamente. I dati del Ministero della Salute di mercoledì 13 maggio mostrano che il Brasile ha registrato 749 morti in più per Covid19 nelle ultime 24 ore. In totale, i decessi confermati ammontano a 13.149.
Al 18 maggio 2020 il Brasile aveva registrato un totale di oltre 240mila casi (di cui 130mila attivi) con oltre 16mila decessi. Lo stato di San Paolo ha il maggior numero di casi nel paese. Ceará, lo Stato di Fortaleza, ha superato Rio de Janeiro mercoledì 13 maggio, con 19.156 casi in totale, ed è secondo nella lista. Segue Rio. Tutto questo fa del Brasile il Paese emergente più colpito. Intanto il presidente Jair Bolsonaro è impegnato nella lotta con i governatori su come affrontare la pandemia, e si difende attaccando, nello stile di Donald Trump, mentre procede l’indagine della Corte Suprema sulle presunte pressioni sui vertici della polizia per proteggere la sua famiglia. I tre Ministri più vicini al presidente – tre generali, uno attivo – sono stati interrogati a Brasilia sul tema, mentre un sondaggio ha diffuso le cifre che attestano il crollo della sua popolarità. La Corte Suprema indaga su Bolsonaro dopo che Sergio Moro lo ha accusato, mentre in aprile si dimetteva da capo del Ministero della Giustizia. Moro, il giudice che simboleggia la lotta contro la corruzione e che era prima della presidenza Bolsonaro il Ministro più popolare, ha assicurato che il Presidente lo aveva costretto a cambiare il direttore della polizia federale con l’obiettivo di proteggere i suoi figli. Non sono state le uniche dimissioni eccellenti: il Ministro della Sanità brasiliano Nelson Teich si è dimesso bruscamente a metà maggio dopo meno di un mese di lavoro. E’ il secondo Ministro della sanità in pochi mesi a asciare. – e un giorno dopo il Paese ha annunciato di aver registrato quasi 14.000 morti.
Intanto nella capiale Brasilia, il Giorno dell’infermiere è stato celebrato in modo spettacolare e polemico da centinaia di appartenenti al personale paramedico, in gran parte donne, che si sono sdraiate in piazza a braccia aperte, quasi crocefisse al loro ruolo di vittime sacrificali, costrette ad affrontare senza difese la marea del Covid19 che avanza. Intanto il presidente paraguaiano Mario Abdo Benítez ha affermato che la diffusione del coronavirus in Brasile minaccia il successo del suo Paese nel contenere il virus. Benítez ha affermato che oltre la metà dei 563 casi del Paraguay erano persone che erano entrate dal vicino Brasile. E’ uno dei numerosi leader nella regione che hanno espresso preoccupazione per l’epidemia in rapido sviluppo del Brasile. Con il vicino del Nord, il Venezuela, è scontro aperto, e il Presidente Nicolas Maduro ha più volte definito “totalmente irresponsabile” la gestione della crisi da parte di Bolsonaro.
Argentina
Il presidente argentino Alberto Fernandez ha affermato che il commercio tra Brasile e Argentina è un rischio, con riferimento specifico ai camionisti che trasportano merci a Sud nel suo Paese da San Paolo, una delle regioni più infette del Brasile. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Sanità nazionale, giovedì 15 maggio si sono registrati 24 morti e 255 nuovi casi confermati in un giorno. Il tasso di letalità per caso di coronavirus è del 4,94 percento. Questo tasso indica la relazione tra i 353 decessi accumulati dall’inizio della pandemia e le infezioni totali confermate dai dati di laboratorio. Quest’ultimo indice ha raggiunto i 7.134 casi il 13 maggio, con 255 nuovi positivi nell’ultimo giorno. Di questi casi, 153 a Buenos Aires, e 79 nella provincia. Le informazioni fornite dal Ministero della Salnità di Buenos Aires indicano che la maggior parte dei decessi proviene da pazienti provenienti da case di cura. Per ora, le cifre mostrano che la mortalità nei quartieri è molto bassa. La relazione valuta anche che si tratti di un numero elevato di casi, ma di una mortalità molto bassa. Quasi il 42 percento degli ultimi 24 deceduti (15 maggio) erano residenti nell’area metropolitana di Buenos Aires, 5 uomini e 5 donne, tutti pazienti a rischio di età: avevano tra i 66 e i 105 anni. Si tratta di un livello di diffusione e letalità comunque molto più contenuto rispetto alla media dell’America latina.
Se dal punto di vista sanitario l’Argentina sembra affrontare meglio dei suoi vicini la pandemia, comincia a circolare il neologismo “coronacrisis”, alludendo alla inevitabile catastrofe economica che seguirà alla crisi. Che può tradursi in vero fallimento dello Stato, che sarebbe il terzo di questo millennio. Gli ultimi due incontri con i creditori internazionali sono finiti in un nulla di fatto perché non è stato raggiunto un accordo sul piano di rientro presentato dal Governo di Alberto Fernandez, che prevede una manovra da 67 miliardi di dollari. Il Ministro delle Finanze Martin Guzman ha chiesto ai creditori internazionali di digerire una moratoria di 3 anni per la sospensione del pagamento degli interessi cui si aggiunge un taglio della cedola al 2,33%. Il taglio della cedola, in termini di minori interessi pagati, si tradurrebbe per il Paese in un risparmio di 37,9 miliardi. Potrebbe però non bastare a salvare l’Argentina dal fallimento.
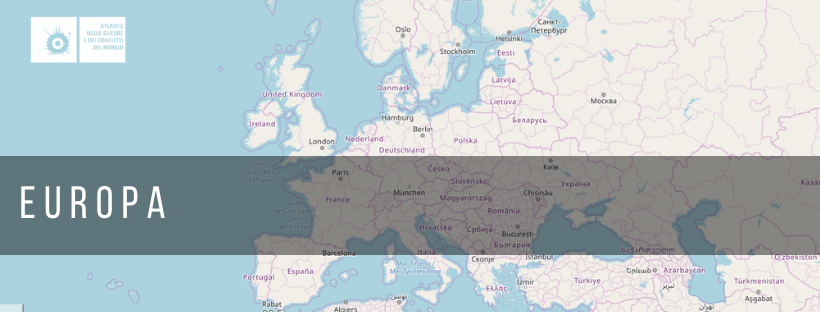
La “Fase Due”: si torna fuori, si torna al lavoro, si torna a scuola
L’Europa si prepara ad affrontare la “fase 2”, dopo due mesi di lockdown in cui sono state contagiate oltre 1,801,668 persone (il numero riguarda solo i contagi “ufficiali”, risultati a seguito di tampone). I Paesi più colpiti inizialmente – Italia e Spagna – tornano a vedere flussi di ricoveri gestibili e terapie intensive meno affollate, mentre il Regno Unito supera i numeri del continente, anche dopo le misure varate da Downing Street all’insegna dello slogan “stay home – protect the NHS – save lives” (restate a casa – proteggete il servizio sanitario nazionale – salvate vite). Boris Johnson ha annunciato a inizio marzo un rilassamento delle regole, che pone la responsabilità in capo ai cittadini, mentre nell’isola di Wight le autorità stanno testando un’app per il tracciamento dei contagiati che potrebbe essere estesa all’intera Nazione per garantire la sicurezza anche una volta che tutto sarà tornato alla normalità.
La riapertura, lenta e moderata, di attività produttive e servizi è ora necessaria: l’eurozona ha perso il 3,8% del Pil nel primo trimestre del 2020 a causa delle chiusure generalizzate di maggio, e secondo la Banca Centrale Europea la recessione causerà un crollo del prodotto interno lordo della zona euro dal 5 al 12%. Nel diffondere i dati, la Bce conferma l’impegno dell’Unione Europea ad aiutare i suoi Stati Membri con fondi disponibili senza condizioni.
Fra i primi a riaprire è stata la Germania, in cui i 16 Stati federati hanno il controllo su ciò che è lecito e proibito nei loro territori. L’esperimento tedesco è stato accolto con freddezza dagli esperti: la Germania, settimo Paese del mondo per numero di contagi, avrebbe forse riaperto troppo presto, portando in pochi giorni il famoso RO (l’indice dei contagi) di nuovo sopra all’1, soglia per cui ogni malato di Covid-19 è in grado di trasmettere il virus a un’altra persona. Angela Merkel ha già dichiarato che, se le riaperture dovessero causare un nuovo aumento nel numero dei casi, il Paese tornerebbe ad una chiusura generalizzata.
La stessa attenzione al fattore RO è dedicata anche dal resto del continente: dall’Italia al Belgio, dalla Francia alla Danimarca, passando per la Spagna, i governi pianificano strategie che gradualmente, tra maggio e giugno, porteranno a un ritorno alla normalità. Grande incognita è quella del turismo: la Grecia investe per garantire ai turisti delle vacanze “covid-19 free”, mentre Regno Unito e Francia pianificano di creare un “corridoio senza quarantena” tra i due Paesi, per incentivare gli spostamenti dei propri cittadini nella stagione estiva: una timida riapertura delle frontiere, grazie alla quale – per la prima volta da mesi – chi attraverserà la Manica non dovrà trascorrere 14 giorni in isolamento. E intanto si ripensa a un’apertura dei confini Europei, con timide proposte per la riapertura dell’area Schengen programmate per giugno.
Per il momento, risposte diverse sono state fornite per quanto riguarda i ritorni a scuola: gli studenti francesi, hanno ricominciato a tornare in classe gradualmente, già dalla prima settimana di maggio, seguiti da Danimarca, Belgio e tanti altri; mentre Italia, Irlanda e Spagna rimandano a settembre. Il messaggio, condiviso da tutti i governi, è all’insegna della sostenibilità: pensare a misure che permettano ai cittadini di pensare a un futuro post-pandemia.

Amsterdam, Max Van Der Oetelaar, Unsplash
Anche perché – lo ha ribadito alla Nazione anche Boris Johnson nella sua ultima conferenza stampa – è possibile che Europa e Mondo debbano imparare a convivere con il virus per un periodo di tempo più lungo del previsto, con gli scienziati che si interrogano su possibili nuove ondate che dovrebbero tornare a colpire nei mesi freddi, in attesa di un vaccino. Vaccino che è studiato in tutti i laboratori del mondo, ma il cui possesso diventerà fattore chiave una volta che la sua efficacia sarà provata: in Francia, il governo si è scagliato contro la multinazionale Sanofi, il cui CEO aveva dichiarato che laddove l’azienda riuscisse ad addivenire ad un vaccino, la vendita sarebbe primariamente rivolta agli Stati Uniti, grandi investitori nella ricerca medica durante la pandemia. Secondo il presidente Macron, un futuro vaccino non dovrebbe soggiacere alle regole di mercato. Intanto, l’Unione Europea ribadisce che tutti i paesi del mondo dovrebbero avere pari accesso alla cura: all’inizio del mese di Maggio l’Ue ha ospitato un summit mondiale (ovviamente online) per finanziare la ricerca su vaccini e trattamenti per il virus, ottenendo 8 bilioni di euro da donatori privati e terze parti. Sembrerebbe un esempio di solidarietà da parte della comunità europea, che però fatica a trovare coesione durante la pandemia. A contrastare gli sforzi di cooperazione e spirito unitario sono due fattori: uno interno e uno esterno.
I nemici dell’Unione Europea: quelli interni, quelli esterni
A rodere l’Europa dall’interno è, ora più del solito, la fitta rete di estreme destre nazionaliste che si è sviluppata nei vari Paesi. In risposta alla recessione economica, agli sforzi richiesti dai governi e agli aiuti messi in campo dall’Unione, i gruppi di destra più estrema hanno sfruttato la pandemia per diffondere messaggi xenofobi e razzisti, ma anche disinformazione e odio intraeuropeo: notizie vere o presunte tali di scorte di mascherine “rubate” da uno Stato all’altro, lotta per le risorse scarse e narrazioni distorte sulle istituzioni Ue. Immancabile la retorica anti immigrazione, particolarmente efficace in un momento in cui sempre più cittadini europei lottano contro la povertà: il momento ideale – come risulta dai forum e dalle chat della destra più radicale – per infiltrare messaggi estremisti nella politica mainstream. Dopo il coronavirus, insomma, i Paesi europei si troveranno vulnerabili al virus dell’ultra-nazionalismo, che punta all’ “uniformità etnica” all’interno dei vari Stati e secondo il quale la globalizzazione e il sentimento Pan-Europeo hanno già fallito.
Ma interferenze rispetto all’operato europeo arrivano anche dall’esterno: l’influenza di paesi terzi nell’Unione è accertata, e comprovata anche dall’ultimo dossier del Servizio Europeo per l’Azione Europea (di cui vi abbiamo parlato qui). Non solo campagne di influenza esterna da parte della Russia, che l’Unione già monitorava da anni attraverso istituti come East StratCom Taskforce ed EU Vs Disinfo; con il coronavirus a monopolizzare il discorso politico, la Cina è entrata prepotentemente nei social media europei, manipolando la narrazione con un mix di notizie false e di informazioni molto accuratamente costruite e presentate. L’obiettivo di entrambi i paesi sembra quello di “peggiorare le condizioni dell’Unione durante la crisi sanitaria” e al contempo estendere il proprio potere nei paesi feriti dal virus. Una sfida che le istituzioni Europee riconoscono come cruciale, da combattere destinando fondi e attenzione, ma anche educando i cittadini europei a riconoscerne i sintomi e le macchinazioni. È evidente come ne vada, sempre di più, della tenuta del sistema.

Nelle ultime settimane la Russia ha tristemente scalato la lista degli Stati più contagiati al mondo, posizionandosi al secondo posto, dopo gli Stati Uniti. Nonostante il numero di positivi aumenti ad un ritmo spaventoso e il virus abbia contagiato alcuni tra i più importanti membri del Governo (il portavoce di Putin Peshkov, il Premier Mishustin e due Ministri) il Presidente Vladimir Putin ha annunciato un parziale rilascio delle misure restrittive dal 12 maggio, giorno in cui sono tornate a lavoro soprattutto industrie e imprese di costruzione. La responsabilità principale sulla gestione delle misure di contenimento rimane però delle autorità regionali, che possono valutare se seguire le indicazioni centrali o prorogare la chiusura. A detta dell’opposizione si tratta di una scaltra mossa del Presidente per tenersi il più possibile fuori dalle critiche riguardo alla gestione dell’emergenza.
Nel frattempo, in meno di una settimana, sono scoppiati due incendi mortali in dipartimenti ospedalieri che ospitavano pazienti Codiv a Mosca e a San Pietroburgo, causando sei vittime. Secondo quanto riporta il Moscow Times, all’origine di entrambi gli incendi ci sarebbe un cortocircuito causato dallo stesso modello di ventilatori polmonari, gli Aventa-M, prodotti da un’azienda russa, la “UPZ” ( Ural Instrument Engineering Plant), una filiale di Rostec, di proprietà statale, sanzionata dagli Stati Uniti.
Per rispondere all’impennata della domanda di ventilatori, solitamente importati, la produzione dell’azienda è dovuta crescere velocemente a danno però, della qualità dei suoi prodotti. Attualmente, almeno fino a quando non saranno terminate le indagini degli inquirenti la produzione e l’utilizzo degli “Aventa- M” è sospesa.
Caucaso meridionale
L’Armenia risulta lo Stato caucasico più colpito dalla pandemia. Lo stato d’emergenza, in vigore dal 16 marzo è stato prorogato fino al 13 giugno. Dal 4 maggio però, per sopperire alle grandi difficoltà economiche, il Primo Ministro Pashinyan ha dichiarato l’inizio di una graduale riapertura. Ma il numero dei positivi in continua crescita preoccupa le autorità, per questo in una diretta facebook il 13 maggio, lo stesso Pashinyan ha invitato la popolazione a seguire le misure anti contagio più seriamente, per evitare di dover ricorrere nuovamente ad una rigida chiusura.
Anche l’ Azerbaijan, dopo un calo sostanziale dei contagi dovuto alle misure di quarantena in vigore dal 25 Marzo, assiste ad una seconda ondata di contagi dovuti alla riapertura di alcune attività ed una maggiore libertà di movimento dei cittadini. Al contrario della vicina Armenia però, le autorità hanno dichiarato di avere la situazione ‘sotto controllo’ sottolineando come il Paese stia affrontando l’emergenza sanitaria “meglio di tanti altri Stati”.
Inoltre, giornalisti ed oppositori politici continuano ad essere bersaglio della politica repressiva del governo che, secondo Human Rights Watch, sta abusando delle restrizioni imposte per rallentare la diffusione di Covid-19 per arrestarli, mettendo così a tacere ogni critica.
La Georgia continua ad essere il Paese con il più basso numero di contagiati dell’area caucasica, nonostante dall’inizio dell’epidemia sia in corso un dibattito senza precedenti sulla posizione della Chiesa ortodossa georgiana che, non solo non ha cancellato le celebrazioni di Pasqua, ma ha continuato ad utilizzare un cucchiaio comune per la pratica della comunione, nonostante le autorità sanitarie avessero insistemente avvertito degli altissimi rischi di contagio. Il patriarca georgiano Ilia II, nel giorno di Pasqua, ha ricordato il motivo per cui la chiesa non cessa la pratica affermando che “Gesù Cristo ha detto che chiunque si nutre della mia carne e beva il mio sangue ha la vita eterna “.
Le gravi conseguenze delle restrizioni e del mancato sostegno statale ad uno tra i gruppi più vulnerabili del Paese, quello transgender, ha spinto quest’ultimi ad organizzare una protesta di fronte al parlamento georgiano a fine aprile, durante la quale una delle manifestanti si è data fuoco. L’intervento immediato della polizia ha evitato la tragedia, ma la situazione rimane tesa. Dall’11 maggio il paese ha cominciato la prima fase di riaperture che ha come obiettivo ultimo il ripristino del turismo internazionale ad inizio Luglio.

Zone di conflitto nel caucaso meridionale
Nagorno Karabakh, Abcasia ed Ossezia del Sud risultano molto vulnerabili alla pandemia di Covid-19 a causa della mancanza di professionisti medici e di ospedali non equipaggiati- è quanto emerge da un nuovo rapporto dell’International Crisis Group. In particolare viene sottolineato come in Abcasia, l’80% del personale medico sia nella fascia ad alto rischio e che quindi, se il contagio dovesse accelerare, la regione perderebbe tutti i suoi professionisti in pochi giorni. In Ossezia del Sud preoccupa soprattutto la mancata preparazione degli ospedali e del personale sanitario e la parziale riluttanza a lavorare con l’ Oms dato che quest’ultimo collabora anche con la Georgia. In Nagorno Karabakh, così come in Abcasia, le elezioni presidenziali hanno avuto priorità sulla gestione dell’emergenza sanitaria e il territorio, formalmente parte dell’Azerbaijan, rimane inaccessibile per qualsiasi organizzazione internazionale senza il permesso di Baku.
Caucaso settentrionale
Il Daghestan è la più grande tra le Repubbliche della Federazione russa del caucaso settentrionale e la più colpita dalla pandemia. Anche in questo caso, il personale medico denuncia la mancanza di formazione per affrontare l’emergenza, l’impreparazione degli ospedali e la carenza di protezioni personali per il trattamento di pazienti Covid. Mentre invece, l’entità federale di Kasnodar Krai, la seconda più colpita dell’area, considera una prima fase di riapertura dal 23 Maggio. In Cecenia, si teme per l’incolumità della giornalista Yelena Milashina, minacciata di morte dal leader Ramzan Kadyrov, dopo aver pubblicato un articolo in cui denunciava le problematiche legate all’emergenza Covid nel pPese (ancora in isolamento). Yelena lavora per il quotidiano “Novaya Gazeta”, lo stesso per cui scriveva Anna Politkovskaja, la giornalista assassinata nel 2006.

In Oceania, mitigato molto più che in altri Paesi l’impatto sanitario di Covid19, si pensa a come rilanciare al meglio l’economia. Un nuovo attivismo sul piano internazionale è poi stato sottolineato da innumerevoli osservatori. Le “potenze medie” di Canberra e Wellington sembrano essere particolarmente pronte ad una strategia “Tasman first”, che oltre ad una stretta collaborazione internazionale potrebbe portare a qualche dissidio con Pechino.
In Nuova Zelanda, l’eliminazione della trasmissione comunitaria è stata raggiunta, ha annunciato il 27 Aprile la Prima ministra laburista Jacinda Ardern. I dati epidemiologici sono infatti chiari e al 15 maggio 2020 dei 1147 casi totali: 1411 sono guariti, 2 sono attualmente ricoverati, 21 sono spirati. Da giorni ormai non si registrano contagi, tanto che il Direttore generale del Dipartimento Sanità ha dichiarato, con la pacatezza e il pragmatismo distintivi della gestione della crisi messa in campo dall’amministrazione di Wellington: “Siamo fiduciosi che l’eliminazione sia stata raggiunta, non significa che non ci saranno nuovi casi però, ma che sappiamo non saranno comunitari”. Ardern è infatti stata molto netta: “Stiamo riaprendo l’economia, ma non stiamo riaprendo la vita sociale della gente”.
Nel question time parlamentare del 7 maggio, la Prima ministra ha inoltre difeso e ribadito la logica della propria gestione della crisi. Simon Bridges, il leader metà maori e metà di discendenze europee dei 55 rappresentati del New Zeland National Party, l’opposizione di centro destra, l’ha infatti prima accusata di aver imposto restrizioni “troppo dure per troppo tempo”, per poi paragonare il suo operato a quello della vicina Australia, spiegando che con meno restrizioni avrebbe ottenuto gli stessi risultati sanitari ma meno danni economici. Il nodo è infatti quello della disoccupazione. Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto una balzo al 9.8% nel 2021, che corrisponderebbe ad un +5,7% su base annuale. Ardern non si è però scomposta, ricordando che queste come quelle sul Pil che dovrebbe diminuire del 7,2%, sono ancora solo delle stime statistiche, rivendicando: “E’ vero ci siamo andati forti” ma rilanciando immediatamente “E la nostra intenzione è di uscirne il più forti possibile”. La Prima Ministra ha quindi sottolineato di aver deliberatamente optato per misure che tutelassero al massimo la salute, così da garantire una ripresa economico-sociale più solida nel lungo periodo.
Nella vicina Australia il trend è altrettanto positivo: dei 7mila malati registrati 6,3mila sarebbero guariti e i decessi al 14 maggio sarebbero 98. Limitati anche i contagi giornalieri, che appunto il 14 maggio erano solo 14. Più problematica invece la situazione economica, con un Pil che dovrebbe crollare del 6,7% e la disoccupazione che dovrebbe aumentare di 3,4 punti rispetto ai 5,2 di inizio 2021 secondo il Fmi. Anche Canberra sta però allentando il lockdown, al punto che per rilanciare l’interscambio commerciale e turistico con la vicina Nuova Zelanda, ha deciso di sottoscrivere un accordo formale per istituire una “bolla di viaggio trans-tasmana”. In altre parole il 5 maggio, l’australiano Morrison e l’omonima neozelandese Ardern hanno stabilito che terranno le proprie frontiere chiuse agli stranieri ancora per molto, ma che non appena l’Australia riaprirà il movimento tra i propri Stati federati, potranno riprendere anche i voli tra i due Paesi. Hanno inoltre ribadito le somiglianze nell’approccio gestionale alla crisi e la comune volontà di proseguire con una pragmatica prudenza. La dichiarazione congiunta spiega quindi che la “Famiglia Pacifica” potrà ricongiungersi progressivamente e che con il tempo anche le altre isole del Pacifico verranno coinvolte.

Primi Ministri s. Morrison e J. Ardern, febbraio 2019. (Commonwealth of Australia 2016)
E’ stato però registrato anche un insolito attivismo diplomatico, focalizzato a bilanciare la politica difensiva cinese e l’assenza di leadership degli Usa. In un’analisi pubblicata sul NYT si plaude infatti al coraggio delle “Potenze Medie”, che sarebbero appunto stufe di chiudere un occhio dinanzi al regime autoritario, scarsamente trasparente e poco responsabile cinese, così come di aspettare l’intervento americano, con Trump a dir poco assente, unilateralista ed isolazionista. L’Australia è sostenitrice del regime di istituzioni liberali fondate sul multilateralismo internazionale e non vuole affatto smantellarlo. Senza appoggiare l’inchiesta Usa, ha quindi annunciato la volontà di chiedere ufficialmente all’Oms la realizzazione di un’indagine sulla gestione dell’epidemia esercitata da Pechino, più approfondita della precedente e veramente super-partes. Le accuse sono quelle di aver nascosto a lungo la presenza del focolaio di Covid-19, ignorando le allerte della vicina Taiwan e condannando non solo i propri cittadini, ma tutto il Mondo a danni economico-politico-sanitari, molto maggiori di quello che più trasparenza e tempestività nella comunicazione dei dati avrebbero permesso di ottenere.
Dall’altra Wellington ha invece fatto sapere all’OMS il 7 maggio, di voler permettere a Taiwan, Stato non membro dell’agenzia a causa dell’ostilità di Pechino, di poter partecipare come osservatore all’imminente 73° Assemblea Generale. La ragione? “Nessun discostamento dalla politica di Una sola Cina” (imposta dal Partito Comunista Cinese), si è affrettata a tamponare i rimproveri sinici Ardern. Tuttavia come ha fatto capire il Ministro degli Esteri e leader del partito nazionalista-populista NZ First Peters, “la Nuova Zelanda vuole battersi per ciò in cui crede”. Tradotto, i dati epidemiologici dimostrano che Taiwan meriti di essere coinvolta in virtù della sua straordinariamente efficace gestione dell’epidemia di Covid-19, che nonostante la densità abitativa e la vicinanza con la Cina, è stata appunto contenuta. Ha chiosato Peters “I nostri Paesi sono amici” ma “la vera amicizia si basa sull’equità e l’abilità di esserlo anche nel disaccordo ”.
Australia e Nuova Zelanda stanno dunque assumendo una postura internazionale di importanza cruciale nella tutela del multilateralismo internazionale e della difesa dei principi sui quali si fonda e vogliono rendere “accountable”, ovvero trasparentemente responsabili dei propri errori, deliberati o meno che fossero, tutti gli Stati che li hanno commessi, Cina compresa. Forti del successo gestionale della crisi sanitaria, confermato dal “potere dei dati” e dovuta alla rigorosa applicazione dei protocolli dei Regolamenti sanitari internazionali dell’Oms si stanno quindi muovendo. L’analista australiano Peter Jennings, direttore dell’Australian Strategic Policy Institute, ha spiegato che funzionari australiani avrebbero “la pancia piena”, in altre parole ne avrebbero abbastanza della Cina, assertiva, violatrice dei Diritti Umani e adesso pure scarsamente trasparente nella comunicazione dei dati sanitari, recidiva dopo il caso Sars del 2002-03. Dall’altra ha sottolineato, se l’idea di una “Cina benigna” è svanita, anche la leadership Usa sembra essersi volatilizzata. “Normalmente, per quanto imperfettamente l’America avrebbe mobilitato il mondo”, ha scritto l’ex Primo Ministro Kevin Rudd. Oggi non lo avrebbe però fatto nessuno per Canberra, che si appresterebbe quindi a guidare la carica delle “potenze medie”.
La determinazione australiana, ancora tutta da provare nei fatti, poggia su una serie di certezze. La prima è quella di valere economicamente quasi quanto la Russia; la seconda è di dipendere commercialmente, turisticamente e accademicamente dagli import-export così come dai nuovi ricchi cinesi e dai loro figli-studenti; la terza è però che i sondaggi e l’umore dell’opinione pubblica e degli elettori è quella di sfiducia se non ostilità nei confronti di Pechino, solo acuite e non determinate, da Covid-19.
Quindi è vero, un’offensiva diplomatica ai danni di Pechino rischierebbe di provocare ritorsioni economiche pesanti, ma il clima sembra quello del: se non ora quando? Canberra conosce appunto i propri assi nella manica, come spiegano gli analisti Cave a Kwai: l’Accordo Commerciale Trans-Pacifico sottoscritto nel 2019 con Canada, Giappone, NZ, Messico e Vietnam conferisce prezioso ossigeno commerciale; la forza di aver detto no all’istallazione del 5G fornito dalle cinesi Huawei e ZT indipendenza tecnologico-strategica, e la dipendenza sinica dalle importazioni dei propri carbone e ferro, in ogni caso molto richiesti anche da Giappone e India le garantirebbero anche una certa serenità economica.