Con questa nuova edizione il Piccolo Atlante di una Pandemia nato il 21 marzo scorso cresce. Con un aggiornamento che diverrà mensile e che intende fotografare non tanto l’evoluzione del virus ma quella della risposta di Paesi, Governi, Continenti, Persone. Un motivo ci spinge a farlo ed è quello di pensare al dopo.
Covid19, crescono le ingiustizie e la fine dell’incubo è lontana
Dice il direttore regionale europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Hans Kluge, che per far finire la pandemia bisognerà vaccinare almeno il 70% della popolazione mondiale. E’ stato lapidario, il direttore: la campagna di vaccinazione nel Vecchio Continente, ha spiegato, è “troppo lenta. Non pensate che la pandemia di Covid19 sia finita. Il nostro migliore amico è la velocità, il tempo sta lavorando contro di noi, la campagna va ancora troppo lenta. Dobbiamo accelerare, dobbiamo aumentare il numero di vaccini”.
I dati gli danno ragione: nei 53 Paesi e territori che compongono la regione europea dell’Oms, inclusi diversi Stati in Asia centrale, solo il 26% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid19. Nell’Unione Europea solo il 36,6% della popolazione è stato vaccinato con almeno una dose e il 16,9% ha terminato il ciclo vaccinale.
Insomma, siamo lontanissimi in Europa da una copertura seria, figuriamoci nel resto del Mondo. Africa e Asia annaspano. In America Latina, cadono teste e ministri sull’altare della disorganizzazione e della mancanza di vaccini. La gente è morta e muore per strada, praticamente priva di cure. Immaginare una via d’uscita, a livello planetario, è difficilissimo. Pensare alla ricostruzione economica ancora più velleitario.
Economie, democrazie e collettività escono pesantemente colpiti dal virus. Il numero di Paesi che, in nome dell’emergenza, ha visto calare drasticamente il proprio livello di democrazia è cresciuto in modo esponenziale, in questi mesi. Parliamo di Stati dell’Europa, Asia Centrale, America del Sud. I governi hanno avuto gioco facile nel girare la vite delle libertà, semplificato dalla paura dei cittadini e dalla loro necessità di sopravvivere. La pandemia – lo dice l’Onu – ha ridotto in povertà oltre 100 milioni di lavoratori nel Mondo. Di fatto, la diminuzione delle ore e la scomparsa di impieghi di qualità causati dalla malattia hanno annullato cinque anni di progressi nella lotta all’impoverimento del lavoro. Un recente rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), dice che nel tempo del contagio, cioè dal 2019, oltre 108 milioni di lavoratori in più in tutto il mondo sono stati classificati come poveri o estremamente poveri. Se a questo aggiungiamo che già prima, nel 2018, le condizioni generali di lavoro erano peggiorate, abbiamo come risultato che nel 2022 il numero di disoccupati dovrebbe raggiungere i 205 milioni, contro i 187 milioni nel 2019. Il tasso di disoccupazione salirà al 5,7%, il più alto dal 2013.
Un disastro che, dal punto di vista geografico, colpisce soprattutto l’America Latina e i Caraibi, l’Europa e l’Asia centrale. Dal punto di vista umano, invece, sono le donne a subire la cosa in modo sproporzionato. L’occupazione femminile è diminuita del 5% nel 2020, rispetto al 3,9% di quella maschile, 112 milioni di donne corrono il rischio di perdere il proprio lavoro entro breve e quindi il proprio reddito. Ciò è evidente in Medioriente e Africa del Nord, dove le donne rappresentano solo il 20% della forza lavoro, ma le perdite di posti di lavoro dovute al Covid19, secondo le stime, incideranno sull’occupazione femminile per il 40%. In generale, ricordiamolo, le donne rappresentano oltre il 70% della forza lavoro impiegata in professioni sanitarie o lavori sociali e di cura. Ad essere massacrata, poi, è l’occupazione giovanile, scesa dell’8,7%.
Mentre tutto questo accade, c’è chi sta meglio di prima. In solo nove mesi, infatti, le 1.000 persone più ricche del mondo hanno recuperato tutte le perdite create dal Covdi19. Ai più poveri – dicono sempre gli esperti – serviranno 10 anni. Una ingiustizia evidente. Ma, d’altro canto, questa pandemia è ingiusta. Uccide in modo disuguale. Le statistiche raccontano, ad esempio, che I brasiliani di ascendenza africana hanno il 40% di probabilità in più di morire di Covid19 rispetto alla popolazione di origine europea. Negli Stati Uniti, 22.000 cittadini afroamericani e latino-americani sarebbero ancora vivi se il loro tasso di mortalità fosse stato uguale a quello dei bianchi.
L’unica soluzione, per ora, resta quella indicata dal direttore Kluge: fare in fretta. Fermare la corsa del virus significa poter riprendere la vita normale e tentare di ricostruire economie e collettività. Sperando che, nel frattempo, di danni creati dalla malattia non siano diventati permanenti.

La pandemia da Covid19 continua a mostrare tutte le sue conseguenze nel Vicino Oriente. In Libano è tuttora in corso, quello che l’Osservatorio per i Diritti Umani ha definito “il più drastico deterioramento dei diritti umani in decenni” a causa della pandemia e soprattutto della profonda crisi sociale, politica ed economica e di tutte le conseguenze dell’esplosione di Beirut del 4 agosto 2020.
Anche le migliaia di migranti presenti in Libano sono stati colpiti dalla profonda crisi economica. A lanciare l’allarme l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), secondo cui la situazione in corso ha “esacerbato la vulnerabilità” dei lavoratori migranti. Secondo il rapporto elaborato dagli esperti, più del 50% non è capace di rispondere ai propri bisogni alimentari di base. Almeno il 20% dei lavoratori ha dichiarato di soffrire di problemi cronici di salute, compresi problemi mentali.
I raid a Gaza
Gli undici giorni di raid su Gaza nel maggio 2021 hanno peggiorato una situazione già al limite. Nell’enclave secondo Croce rossa e Mezzaluna rossa, solo il 6% della popolazione ha ricevuto il vaccino (in Israele siamo al 63% al 31 maggio 2021) e più di 100mila palestinesi sono stati sfollati costretti a pernottare “nelle scuole, nei rifugi improvvisati o a casa dei parenti in piccoli appartamenti”. I raid israeliani hanno poi danneggiato sei ospedali e undici centri di assistenza sanitaria di base, oltre all’unica clinica per i test Covid che è stata resa inutilizzabile.
In Yemen l’agenzia Onu World Food Programme (Wfp) sta aumentando il livello di assistenza alimentare nei luoghi di maggiore fame per prevenire una devastante carestia. Con gli aumenti dei prezzi alimentari il cibo è fuori dalla portata per milioni di persone. Il Paese sta inoltre attraversando una seconda ondata di Covid19 alla quale il sistema sanitario non riesce a far fronte. Quasi 50mila persone vivono già in condizioni simili alla carestia, 5milioni di persone si trovano in estrema difficoltà. Secondo il Wfp un bambino muore ogni 10 minuti per malattie prevenibili come la diarrea, la malnutrizione ed infezioni del tratto respiratorio.

Seconda ondata in Siria
Una seconda ondata di Covid19 ha raggiunto anche il Nord-Est della Siria. Medici senza frontiere ha denunciato che “i piani vaccinali per gli operatori sanitari che lavorano in prima linea, ma anche per la popolazione, restano vaghi”. Per Crystal Van Leeuwen, responsabile medico Msf in Siria “l’assegnazione di vaccini e altre forniture essenziali si è dimostrata iniqua nelle diverse regioni del Paese, provando che ancora una volta la risposta agli aiuti umanitari nel nord-est della Siria è influenzata negativamente dalle politiche regionali e dalla mancanza di un meccanismo transfrontaliero delle Nazioni Unite”.
La campagna vaccinale è partita in vari Paesi dell’area già dai primi mesi del 2021, ma come era prevedibile procede a rilento in quelli interessati dai conflitti e nelle aree popolate da profughi e sfollati. Al 31 maggio 2021 in Siria aveva ricevuto la prima dose vaccinale lo 0,14 % della popolazione e in Yemen lo 0,35%. In Libano il 7,6% ha ricevuto almeno una dose, in Giordania siamo al 13,8%, il 3,26% in Iran e il 14,9% in Turchia. Alta invece la percentuale nel piccolo Stato del Bahrein con il 55,3% di immunizzazioni e in Qatar con il 50%.In Oman siamo invece al 4,2%. Fermi a zero l’Iraq, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita.

A un anno e mezzo dall’esplosione della pandemia in Asia, si può tentare di tracciare in bilancio sulle sfide lanciate dal virus al continente più popoloso del globo. Lo si può leggere attraverso quattro nodi principali: la proposta di tregua dell’Onu del marzo 2020; la capacità di creare la possibilità che tutti siano curati (da cui l’esperimento Oms Covax); gli effetti sul multilateralismo; la sfida geopolitica della diffusione dei diversi vaccini (cinesi, russi, americani). Del primo punto abbiamo già ampiamente scritto: la proposta di tregua di Antonio Guterres – rilanciata anche da papa Francesco – non trova in Asia (ma nemmeno altrove) risposte concerete, al netto di qualche raro episodio. Proposta che fallisce in Thailandia, nella Filippine, in India e, soprattutto, in Myanmar dove si riaccendo i riflettori dal 1 febbraio 2021 quando un golpe militare scalza il governo civile di Aung San Suu Kyi (e i dati sulla diffusione della pandemia diventano poco credibili). Quanto alla garanzia di “vaccino per tutti”, il Continente si segnalava per grandi disparità da Paese a Paese: motivi dovuti al numero degli abitanti, alla possibilità di avere scorte sufficienti, all’atteggiamento dei singoli governi. Tra i più efficienti: Cina, Corea del Sud, Giappone e Vietnam. Tra i meno efficienti: India, Indonesia (ma va tenuto conto anche dei numeri) e Filippine.
Ritorno al multilateralismo
La sfida del multilateralismo è forse il tema per il quale si può sottolineare qualche progresso. Il multilateralismo infatti guadagna qualche punto, se non altro per la decisione americana di continuare a far parte dell’Oms, di voler cooperare sul clima, di voler cambiare approccio nei confronti dell’Iran. La nuova Amministrazione americana, insomma, cambia il corso della Storia cui Trump aveva impresso una marcia indietro isolazionista e pronta a minare qualsiasi iniziativa multilaterale, dalle bombe alla salute. E per l’Asia questo cambiamento diventa epocale soprattutto nell’area Vicino oriente-Asia centrale, dove si conclude la missione afgana e dove si raffredda il contenzioso con l’Iran, due Paesi che hanno a che fare col Covid in maniera molto differente ma non meno preoccupante (l’Iran con quasi 3milioni di casi conclamati e oltre 80mila decessi; l’Afghanistan con oltre 75mila casi e oltre 3mila decessi ma numeri viziati da una certa diffidenza – trattandosi di un Paese in guerra – a ritenere tutti i casi reali effettivamente documentati).
Geopolitica del vaccino
Come abbiamo già spesso notato, la diffusione dei vaccini resta un’arma geopolitica di penetrazione utilizzata soprattutto dai grandi imperi: Cina, Usa e Russia. Sul fronte dei vaccini l’Asia si è attrezzata abbastanza velocemente e capillarmente e, com’è noto, ha sperimentato anche sistemi innovativi di prevenzione (dal Vietnam alla Corea del Sud) scontando comunque i problemi atavici di un continente dove fame, povertà e malattie sono ancora dominanti, specie in paesi popolosi come India, Pakistan e Indonesia. Se è da segnalare l’attivismo cinese nel proporre e spesso regalare i suoi vaccini soprattutto nel “cortile di casa” (il Sudest asiatico), vale la pena di notare la capacità dei singoli Paesi di fare scelte equilibrate tra vaccini asiatici e occidentali. Un modo per sfuggire a una dipendenza diretta.
Dal punto di vista della diffusione della pandemia, se è vero che l’India si trova al secondo posto nella classifica mondiale (dopo gli Usa e prima del Brasile, con oltre 28milioni di casi e e oltre 300mila decessi), bisogna poi arrivare al 13mo posto (Iran) e al 18mo (Indonesia) per trovare altri Paesi asiatici tra i primi 20 Paesi colpiti dal Covid19. Resta infatti preoccupante la situazione in Iran e Indonesia, così come nelle Filippine e in Pakistan ma, considerata la popolazione dei singoli Paesi, la situazione in Asia (India esclusa) resta abbastanza sotto controllo. Da segnalare la Cambogia, che fino a qualche mese fa non segnalava nessun decesso (ora siamo a 236) e le 3 vittime del Laos (altro Paese che non segnalava alcun decesso). Infine il Myanmar cui abbiamo già accennato, con 143mila casi e oltre 3200 decessi: dati su cui resta impossibile accertare la veridicità dei numeri, in un Paese che rischia di ritrovarsi in una situazione di guerra civile e nel quale il sistema ospedaliero, già sotto stress in tempi normali, è praticamente collassato benché medici e paramedici, pur avendo aderito alle proteste anti golpe (ne sono anzi stati l’avanguardia), hanno cercato di continuare a garantire i servizi di emergenza, molti dei quali riguardavano dimostranti feriti dalle forze dell’ordine fedeli alla giunta.

A parte il caso già segnalato dell’Afghanistan, un Paese a cavallo tra Asia centrale, subcontinente indiano e Vicino Oriente, un discorso a parte meritano i 5 Stan. La pandemia, al di là delle dichiarazioni ufficiali di alcuni governi, ha colpito duro e ha messo in crisi – in alcuni casi pare definitivamente – i deboli modelli democratici. I numeri complessivi dei cinque Stan, al netto del Turkmenistan, che continua a dichiarare 0 casi e 0 contagi, è di oltre 670mila casi totali ai primi di giugno, con quasi 10mila morti.
Nel frattempo, la vita è andata faticosamente avanti, spesso non bene. Con l’elezione di Zhaparov, l’esperimento democratico in Kirghizistan si può ritenere concluso e a giudizio degli osservatori, a differenza di altre crisi, la politica estera ha ben poco a che fare con la crisi a Bishkek. Insomma, non ci sono state ingerenze. Contemporaneamente, in Kazakistan le elezioni sono state un disastro. In assenza di una vera opposizione organizzata in un qualche partito, ha vinto Kassym-Jomart Tokaye, rappresentate della vecchia nomenclatura di potere. E questo nonostante la piazza abbia alzato il tono della protesta. In entrambi i Paesi, a dominare continua ad essere la politica dei clan famigliari e dei gruppi di potere, che rendono inutile ogni blando tentativo di democratizzazione reale.
Poca democrazia, insomma, con il Turkmenistan che insiste nel dichiararsi Covid19 – free a dispetto delle inquietudini mostrate dalla popolazione: il presidente Gurbangouly Berdymoukhamedov insiste nel sostenere che ”la liquirizia impedisce lo sviluppo del Coronavirus”. Al di là delle questioni sanitarie e della crisi economica che sta colpendo tutti e cinque i Paesi, con le frontiere chiuse e iI flusso turistico bloccato, il virus sta creando buone occasioni per ridefinire ruoli e “potenza” nella Regione.
Il Kazakistan ha consolidato il proprio status di “potenza umanitaria”, erogando gratuitamente beni igienico-sanitari ai propri vicini. Ovviamente a titolo gratuito. Nur-Sultan ha riaffermato il proprio ruolo di leader, trasformando la campagna d’aiuti in un momento di promozione multimediale. A far da spalla al governo kazako ha pensato quello uzbeko. Il Kirghizistan è stato il Paese che più e per primo ha goduto degli aiuti kazaki. Parliamo di sanitari ospedalieri, strumenti medicali, cibo. Le derrate per Biskek sono state regolari, continue sin dall’inizio dell’epidemia. Lo stesso è accaduto con il Tagikistan. In questo modo, la posizione kazaka nell’Unione Economica Euroasiatica e nel Consiglio Turco ne è uscita rafforzata.

L’Africa continua a essere il continente meno colpito – per numero di casi e di vittime – dal Covid19: a fine maggio il numero totale dei casi accertati era di 4,9 milioni nell’intero Continente, con 123mila morti (quando, ad esempio, gli Stati Uniti da soli ne contano 33,5 milioni con 600mila decessi e l’India 29 milioni con 350mila vittime).
Resta naturalmente il problema di una maggiore incertezza sui dati (data la minore capacità di monitoraggio in tanti Paesi) e la grande concentrazione di positivi al virus in alcuni Stati: il Sudafrica ha oltrepassato il numero di 1,6 milioni, il Marocco 520mila, la Tunisia ha superato i 350mila, Etiopia ed Egitto sono rispettivamente poco sopra e poco sotto i 270mila. Questi soli cinque Paesi assommano i due terzi dei contagi totali, sui 54 Stati africani. La metà (27) sono al di sotto dei 20mila casi confermati.
Dopo quasi un anno e mezzo dall’inizio della pandemia si confermano, per l’Africa, alcuni fattori, che possono spiegare il diverso andamento dei contagi rispetto al resto del mondo: la bassa età media del Continente ha ridotto la forza diffusiva del virus e nel contempo la scarsa efficacia dei sistemi di monitoraggio ha intercettato una parte minima dei casi paucisintomatici e asintomatici. D’altro canto, l’Africa è l’unica area del mondo ad aver affrontato questa emergenza con una strategia pressoché continentale (a parte qualche eccezione di governi “negazionisti”). Inoltre, ha giocato un ruolo favorevole la consapevolezza, in tanti Paesi africani, della minore capacità di contrasto alla malattia in termini di cure e ospedalizzazione, che ha spinto molti governi a operare sulla prevenzione attraverso i sistemi di protezione a basso costo (mascherine e disinfezione) e le campagne di sensibilizzazione, con un forte sostegno, in questa azione, da parte delle agenzie umanitarie Onu e delle Ong. Non solo. Anche la maggiore “familiarità” nel gestire le emergenze è stata d’aiuto: all’arrivo del coronavirus l’Africa si trovava già a fare i conti con più di cento malattie infettive in corso e una dozzina di emergenze umanitarie.
Quello che si temeva, insomma, ossia un vero e proprio collasso dei sistemi sanitari, non è avvenuto. Ma non è consolante. Perché le conseguenze più pesanti il Continente le ha patite – e continuerà a subirle – sotto altri aspetti: i passi indietro sulle altre emergenze sanitarie (le affezioni da acqua impura, la malaria, l’Aids, la Tbc, la malnutrizione grave e acuta, responsabili di milioni e milioni di vittime in Africa), il crollo socio-economico, la perdita di decine di milioni di posti lavoro, lo scivolamento sotto la soglia di povertà di almeno 100 milioni di nuovi “poveri estremi”. Come si è ripetutamente osservato, l’Africa, pur essendo la meno colpita dal virus, ne pagherà le conseguenze più pesanti.
Questa circostanza straordinaria poteva essere l’occasione per varare, finalmente, un vero “piano Marshall” per l’Africa. Ma l’occasione non è stata colta. Ne pagheremo tutti le conseguenze, in termini di diseguaglianze e di nuovo impulso ai fenomeni migratori, ma primi fra tutti le pagheranno gli africani. Basta guardare a un dato: il debito estero medio dei 54 Stati è salito di 6 punti rispetto all’anno scorso, ed è attestato intorno al 58%, il più alto negli ultimi 20 anni. Se è vero, peraltro, che la crisi ha colpito il mondo intero, è altrettanto vero, però, che le fragili economie africane non hanno risorse da destinare al rilancio. Mediamente, i Paesi ricchi e quelli cosiddetti emergenti stanno investendo poco meno del 25% della ricchezza nazionale alla ripartenza; per l’Africa questa cifra si aggira intorno al 2%.

Infine, il problema più grave. I vaccini. Alla fine di maggio solo l’1.5% degli africani ha ottenuto una dose di immunizzazione (contro il 24% della media mondiale). Nel Continente sono arrivate, finora, 37 milioni di dosi, ma anche sotto questo profilo occorre guardare alle situazioni dei singoli Paesi per capire meglio la gravità dello status quo: il solo Marocco ha utilizzato 10 milioni di dosi, con l’11,9% della popolazione vaccinata; la Nigeria 1,67 milioni di dosi, con lo 0,82% di vaccinati; l’Etiopia, terzo in classifica, 1,3 milioni, con l’1,13% di abitanti immunizzati.
Alla faccia di chi diceva che dalla pandemia globale si esce con soluzioni globali, all’Africa mancano innanzitutto i vaccini, nella quasi totalità accaparrati dai Paesi ricchi. La stessa iniziativa Covax, avviata dalla metà del 2020 per sostenere i processi di vaccinazione dei Paesi poveri, prosegue a rilento e con continui ritardi. Le difficoltà sono enormi, e non riguardano soltanto il numero di dosi a disposizione. Altrettanti problemi vi sono nella distribuzione: vi è la carenza di strade efficienti e di mezzi di trasporto adeguati, vi sono grandi difficoltà per mantenere la catena del freddo (anche i vaccini di tipo tradizionale, come quello di Astrazeneca, richiedono comunque una temperatura fra i -2 e i +8 gradi, che in regione con poche infrastrutture e temperature tropicali ed equatoriali sono difficili da mantenere). Vi è – terzo grosso problema – carenza di personale, preparato e organizzato per condurre una campagna vaccinale capillare. Tutto ciò ha già comportato il mancato utilizzo di intere partite di dosi: ben 1,7 milioni in Repubblica Democratica del Congo, 20mila in Malawi, 60mila in Sud Sudan.
Infine, come avviene anche nel resto del mondo, giocano un ruolo negativo le fake news che creano diffidenza verso il farmaco. Nel caso degli africani, le più diffuse sono che il vaccino porterebbe all’infertilità e che il Covid-19 è una “malattia dei bianchi”.

Alla fine di maggio del 2021, con più di 1milione e mezzo di morti accertate, le Americhe rappresentano da sole quasi la metà dei decessi mondiali da Covid19. Ai primi posti in questa tragica classifica globale risultano gli Stati Uniti e il Brasile (rispettivamente al primo e al secondo posto). Occorre comunque chiarire che il rilevamento dei dati a livello globale non è omogeneo, e che i casi segnalati in alcune realtà, Americhe comprese, dipendono dal criterio con cui le morti vengono classificate, e soprattutto dal sistema sanitario chiamato a svolgere l’operazione. Al quarto posto è il Messico con oltre 228mila: per un totale di 1milione e 200mila vittime in soli tre Paesi.
Superficiali quando non negazionisti
In tutti e tre i casi, all’origine della tragedia è l’approccio superficiale, se non negazionista, con cui si è affrontata l’emergenza. In Perù, dopo un’indagine governativa, il numero di morti per Covid19 è risultato doppio di quanto rilevato in precedenza, e porrebbe il Perù al primo posto per rapporto fra abitanti e decessi. Tutto ciò è paradossale in un continente relativamente poco popolato, dotato di enormi risorse naturali, e che è stato a lungo considerato come una ambita meta di migrazione per chi cercasse un futuro migliore.
Malgrado le enormi differenze fra emisfero Nord e Sud delle Americhe, un punto comune può essere identificato, in questa crisi, nel dominio di un modello di sviluppo economico e sociale che si è rivelato del tutto inadatto ad affrontare questa emergenza.
La pandemia è lo scoglio contro cui è andato a scontrarsi il modello neoliberista di Trump e Bolsonaro, che hanno portato al fallimento elettorale l’ormai ex Presidente degli Usa, e che stanno mettendo in grave crisi il i potere del primo cittadino del Brasile. La continua sostituzione ai vertici dei ministero della Sanità di Brasilia, e la riabilitazione e scarcerazione di Lula, principale avversario di Jair Bolsonaro, mettono a rischio la sua rielezione e hanno mobilitato grandi manifestazioni che ne chiedono l’impeachment, anche con accuse di genocidio. Negli Stati Uniti invece, l’elezione di Joe Biden ha portato un piano di riforme da 6mila miliardi di dollari, che prevede un aumento del 20 percento delle risorse destinate a sanità e istruzione. Anche il resto del continente affronta problematiche simili. La pandemia ha messo allo scoperto sia la fragilità dei sistemi sanitari, che le diseguaglianze sociali.

Protesta sociale
In Brasile, ai primi di giugno, dopo un anno di gestione catastrofica della pandemia, centinaia di migliaia di manifestanti hanno marciato in oltre 200 città in tutto il Paese per chiedere l’impeachment di Bolsonaro. Il Presidente è accusato di genocidio, per aver all’inizio negato la pandemia, e poi per aver adottato misure inefficaci e irresponsabili nell’affrontarla. Il Ministero della Sanità affidato a un militare, la negazione dell’utilità delle mascherine, e perfino il rifiuto di acquistare il vaccino della Pfizer sono le ragioni per cui la responsabilità del disastro sanitario vengono attribuite a Bolsonaro. Questo rilancia con forza anche la candidatura alle prossime elezioni presidenziali di Lula, che è stato liberato dal carcere, e riabilitato dalla magistratura.
Dal Cile alla Colombia le piazze si sono mobilitate per esigere un cambiamento di rotta. In Cile, con la vittoria del referendum per una nuova Costituzione, e la vittoria delle sinistre nell’elezione della Costituente, si intravede un’alternativa. Benché il Paese vanti il maggior reddito pro capite del Sud America ai primi di giugno i decessi accertati sono 30mila, e 1milione e mezzo i contagiati. In Colombia, dopo il faticoso processo di pace con la guerriglia, la pandemia ha messo in discussione li modello neoliberista, e uno sciopero generale ha portato al ritiro di una riforma fiscale. Ma le proteste non si sono arrestate, e per tutto il mese di maggio il Paese è stato quasi paralizzato dai posti di blocco dei manifestanti, che richiedono riforme in materia economica, sanitaria e sociale, con una durissima reazione da parte delle forze di polizia e dall’esercito. Si contano decine di morti, su cui non si è fatta luce piena, causando la richiesta di un’indagine da parte delle Nazioni Unite. Qui i decessi per Covid19 superano i 100mila, e i contagi i 3milioni e mezzo. Malgrado ciò il 5 di giugno si è decisa la riapertura delle attività economiche.
Il caso Cuba
Fa eccezione a questo panorama il caso di Cuba che, oltre ad aver vaccinato la totalità della popolazione a rischio, ha messo a punto due nuovi vaccini, dei quali il Soberana 2 pare particolarmente efficace- Ora l’Avana si appresta a distribuirlo gratuitamente alle aree più povere del Pianeta.
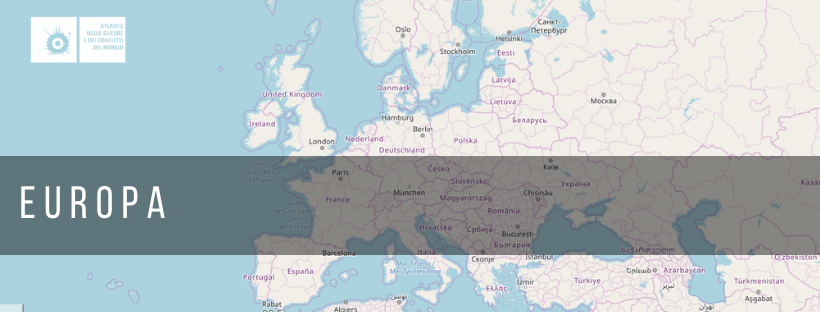
Con l’arrivo della bella stagione, il continente europeo vede la riapertura degli esercizi commerciali e di business come quello dello spettacolo, travolti da oltre un anno di pandemia. Dal Regno Unito all’Italia, passando per Francia e Germania si iniziano a sollevare misure restrittive come i vari coprifuoco, secondo piani nazionali che mirano alla rimozione di queste restrizioni una volta per tutte. Infatti, a giocare a favore del ritorno alla normalità stavolta non è soltanto la bella stagione, ma anche una decisa accelerazione nelle campagne vaccinali di tutti i paesi.
Terza ondata a sorpresa
I piani per le riaperture rimangono però cauti, progressivi, e basati sul costante monitoraggio dei dati dei contagi a livello sia nazionale che locale. In primavera, l’Europa è stata sorpresa da una terza ondata di contagi, proprio mentre sfumavano gli effetti della seconda, l’ondata invernale. Una risalita nei numeri di morti e ammalati del tutto inaspettata, che tra febbraio e marzo 2021 ha costretto tutti i Paesi a un passo indietro: nuove chiusure, un ennesimo crollo nell’economia del continente, e soprattutto un nuovo stress per i governi che – con le campagne vaccinali oramai a regime dopo i ritardi e il caos dei primi mesi – avevano iniziato a promettere riaperture. Complici e causa dell’ondata a sorpresa sono state le cosiddette “varianti”, mutazioni del virus Covid-19 che sono entrate nel continente da paesi come India, Brasile e Sudafrica. Queste variazioni del virus, caratterizzate da una mortalità più accentuata anche tra i giovani e (nel caso della variante indiana) anche da una maggiore contagiosità, hanno costretto i Paesi europei a chiudere i confini a determinati arrivi, o a imporre “quarantene in hotel” dove monitorare non solo il contagio, ma anche la sequenza genetica del virus per individuare la circolazione delle varianti nel continente.

Vaccini: l’unica via d’uscita, ma anche un test per l’autonomia strategica europea
Dopo qualche tentennamento, mentre scienziati e case farmaceutiche testavano l’efficacia dei vaccini esistenti sulle nuove varianti, il messaggio di istituzioni europee, nazionali e locali è stato unanime: spingere per la vaccinazione di massa, il più in fretta possibile. L’Unione punta a vaccinare il 70% degli adulti entro luglio, anche se gli Stati Membri si muovono a velocità diverse. A fine maggio, Malta risulta in testa con il 32,5% della popolazione vaccinata a fine maggio; l’Italia è al 14,5%, mentre il Regno Unito – autonomo dalla strategia Europea a causa della Brexit – è quasi al 31%.
Ma soprattutto, l’UE mira al raggiungimento dell’autonomia nella produzione di vaccini: attraverso contratti preliminari d’acquisto con le case farmaceutiche, l’Unione spera di assicurarsi una costante produzione all’interno dei propri confini. Così, non solo l’autonomia strategica (obiettivo fondamentale della politica estera europea) si traspone in ambito sanitario, ma l’UE – e la sua corte – mantengono il controllo sulle norme relative alla produzione, diffusione, e al costo dei vaccini, che l’Europarlamento spera di mantenere abbordabile. Abbordabile, sì, ma senza liberalizzare i vaccini: nonostante l’apertura da parte di Joe Biden, che a livello globale ha proposto di rinunciare ai brevetti per garantire dosi per tutti e a prezzo ragionevole, Bruxelles è rimasta tiepida su un tema che ha visto l’opposzione guidata da Angela Merkel che si è apertamente opposta alla liberalizzazione.
Unione Europea compatta, sulla salute e sui diritti
L’Unione guarda ora piuttosto ad una riapertura dei confini e di attività permanenti e armonizzate. Dopo aver stanziato oltre 2000 miliardi di euro per la ripresa economica, digitale ed ambientale dell’Unione, Bruxelles sta mettendo a punto un piano per permettere ai suoi cittadini di tornare a spostarsi nell’Area Schengen con un passaporto vaccinale comune, volto ad evitare onerose quarantene e obblighi diversi imposti dalle autorità nazionali. Il “Green Pass” entrerà in vigore dal 1°luglio 2021, e sarà il simbolo di una nuova estate europea.
Ma le deliberazioni europee su vaccini, pianificazione economica e circolazione non sono gli unici segnali di un’Unione compatta: le istituzioni europee sono state capaci, in questa primavera, di portare lo stesso clima di collaborazione e unità fuori dall’argomento sanitario e di applicarlo nei confronti dei diritti umani e della politica estera Europea. In primis, schierandosi compatte attorno a Ursula Von Der Leyen quando Erdogan ha umiliato lei e la parità di genere nel ricevere la rappresentanza europea in Turchia. Poi, chiedendo un cessate il fuoco tra Gaza e Israele. Soprattutto, però, lo hanno fatto adottando in tempi record ulteriori sanzioni contro la Bielorussia di Lukashenko – il vicino scomodo che sempre più spesso calpesta i diritti umani forte dell’alleato Russo, e che è arrivato a dirottare un volo irlandese Atene-Vilnius per arrestare un giornalista dissidente. Comunque, nonostante gli sforzi, l’Europa appare in ritardo con i suoi piani vaccinali rispetto alle previsioni e con differenze rilevanti tra Stato e Stato.
La speranza delle associazioni della società civile intanto è che – in un periodo in cui i flussi migratori tornano a crescere e a mettere in crisi i Paesi del mediterraneo – la stessa compattezza venga dimostrata dall’UE in sede di ridiscussione degli accordi di Dublino sull’accoglienza.

Quasi un anno fa, nell’agosto 2020, Putin annunciava l’approvazione, da parte dell’istituto Gamaleya, del primo vaccino contro Covid-19: lo Sputnik V. Ad oggi però, i vaccinati in Russia risultano essere solo circa il 10%, cifra molto inferiore a quella ,ad esempio ,degli Stati Uniti, che nonostante abbiano approvato il proprio vaccino a dicembre, sono già riusciti a vaccinare quasi il 50% della propria popolazione.
Una parte del problema russo -scrive il New Yorker- sta nella domanda e nell’offerta. Manca il vaccino nei Distretti e mancano coloro che vogliono vaccinarsi. La diffusa sfiducia nelle autorità, una campagna vaccinale praticamente inesistente ed un minore senso di urgenza dovuto all’atmosfera “post-pandemia” che da gennaio si respira nel Paese, sono tra i principali fattori che spiegano la situazione nella Federazione russa.
Nonostante la sfiducia domestica però, le ambiziose aspirazioni geopolitiche affidate a Sputnik V, hanno fatto sì che, ad oggi, la Russia riuscisse ad esportare più di un terzo della propria offerta vaccinale. Se Sputnik V fosse approvato dall’Agenzia Europea del Farmaco – scrive sempre il New Yorker- Putin avrebbe ancor meno ragioni di preoccuparsi per la bassa domanda interna, dato che il prestigio del vaccino aumenterebbe. Intanto però, a parte le esportazioni, la Russia si sta porcurando Sputnik V dalle proprie filiali in India e Corea del Sud per soddisfare la propria domanda interna.

Anche nel Caucaso Meridionale la geopolitica gioca un ruolo centrale nel piano vaccinale. L’Armenia, l’Azerbaijan e la Georgia fanno affidamento per i propri rifornimenti soprattutto su Covax, l’iniziativa globale il cui scopo è quello di garantire l’accessibilità ai vaccini anche ai paesi a reddito più basso. Le forniture di Covax però, coprono solo il 10-20 % della popolazione caucasica, così i tre Paesi chiedono aiuto ai propri alleati: l’Armenia alla Russia, l’Azerbaijan alla Turchia e la Georgia all’Occidente.
In Armenia, il processo di vaccinazione volontaria è iniziato ad aprile, ma lo scetticismo e la diffusa sfiducia nel governo, cresciuta dopo la sconfitta nella guerra per il Nagorno-Karabakh (vedi scheda) alla fine dell’anno 2020, hanno contribuito a far sì che finora si vaccinasse solo appena il 2% delle persone a rischio e circa lo 0.6% della popolazione complessiva. Per far decollare le vaccinazioni, il governo di Yerevan ha messo a disposizione dei punti di vaccinazione mobili, gratuiti ed aperti a chiunque, anche agli stranieri. Al momento però, il numero di vaccinati continua ad essere basso.
Anche in Georgia lo scetticismo è elevato ed anche in questo caso -scrive Eurasianet– la mancanza di informazioni chiare da parte delle autorità governative non ha fatto altro che fomentare teorie complottiste a cui si sono aggiunte questioni geopolitiche che hanno visto schierati: gli anti-russi contro Sputnik V, gli anti-occidentali contro Pfizer/BioNTech e AstraZeneca.
L’Azerbaijan invece, primo tra i Paesi caucasici a cominciare le vaccinazioni, è riuscito a coinvolgere più del 12% della propria popolazione. Ma nonostante il maggior successo vaccinale rispetto agli altri due Paesi caucasici, anche qua lo scetticismo rimane alto.

Australia e Nuova Zelanda sono, secondo l’indice di resilienza alla pandemia elaborato da Bloomberg, il terzo e primo luogo migliori al Mond, in cui vivere durante la Pandemia di Covid19. Al 26 maggio sono poco più di 30mila i casi di positività nella prima ed appena 22 (tutti importati) per la seconda. Nell’ultimo mese, entrambi hanno registrato in media 1 positività ogni 100mila abitanti, mentre stanno proseguendo con lentezza le campagne vaccinali: a fine maggio “solo” poco più del 14,5% degli australiani e del 11,6% dei neozelandesi risulta immunizzato.
Per quanto l’allerta nei due Stati rimanga quindi alta e l’ingresso ai non-cittadini sostanzialmente vietato, l’emergenza è sotto controllo: il tasso di contagio comunitario è nullo o bassissimo, il tracciamento dei casi elevato e i sistemi sanitari per nulla sotto stress. Se quindi non sembrano esservi ragioni sanitarie per allarmarsi della lentezza delle vaccinazioni, alcuni analisti reclamano un’accelerazione per salvaguardare il settore turistico. Gli operatori del settore devono per ora accontentarsi della cosiddetta “bolla di viaggio trans-tasmanica”, che permette il movimento, senza quarantene preventive, tra i due Paesi.
Wellington procede lenta ma inesorabile secondo il proprio piano di vaccinazione, in linea con gli obiettivi prefissati: emblematico dalla sua efficacia in termini di approvvigionamento e cruciale per una buona comunicazione della campagna, è l’essersi assicurata sufficienti dosi di uno stesso vaccino, Pfizer/BioNtech, per l’intera popolazione. Il Governo di Canberra ha invece ammesso che entro la fine del 2021 non riuscirà a vaccinare l’intera cittadinanza, come inizialmente programmato. La causa è dovuta a problemi di approvvigionamento. Dei 4 vaccini inizialmente prenotati: Novavax, quello elaborato dall’Università del Queensalnd, PfizerBioNTech ed AstraZeneca; solo gli ultimi due sono infatti disponibili e con significativi problemi nella distribuzione globale.
Sul fronte geopolitico si registra un’ulteriore polarizzazione delle rivalità nella regione pacifico-oceanica. La spirale negativa di tit-for-tat tra Canberra e Pechino, precipitata con la richiesta della prima di indagare più approfonditamente le responsabilità pandemiche della seconda, seguita dalle sanzioni economiche cinesi sull’export alimentare australiano e la caduta del 61% degli investimenti diretti cinesi in terra australe, è proseguita il 4 maggio con la “sospensione indefinita” da parte di Pechino, del China-Australia Strategic Economic Dialogue.

Giustificata come “necessaria e legittima” nei confronti della “mentalità di ideologica discriminazione” del Australia, la decisione è una ritorsione allo stralcio, da parte del Governo Federale di Canberra degli accordi che vincolavano il Governo dello Stato di Victoria alla Via della Seta cinese.
Wellington sta invece portando avanti una politica estera più pragmatica e moderata nei modi, che mira a mantenere la stabilità commerciale con Pechino, assicurandosi però la possibilità di criticarlo. La Prima Ministra Ardern ha infatti espresso “grave preoccupazione” per la situazione inerente al rispetto dei diritti umani nello Xinjiang e a Hong Kong, rifiutandosi però di sottoscrivere un documento dell’alleanza d’intelligence Five Eyes, che ha visto GB, Usa, Australia e Canada definire “genocidio” quello perpetrato da Pechino nei confronti della minoranza Uigura. La dipendenza economica di Wellington dalla Cina è troppo profonda (30% dell’export totale) per essere messa in pericolo. Inoltre, mentre il Dragone dipende dall’importazione di metalli ferrosi australiani, la Nuova Zelanda non ha nessun bene monopolistico tra quelli esportati verso la Cina. Significativa della volontà di coalizzarsi per contenere l’ascesa cinese non solo con esercitazioni militari congiunte, ma anche attraverso il soft power, è invece la decisione del 16 marzo: i Capi di Governo di Usa, Australia, Giappone e India, nell’ambito dell’alleanza informale QUAD, si sono infatti impegnati a distribuire in Asia, 1mld di dosi vaccinali, entro il 2022.










